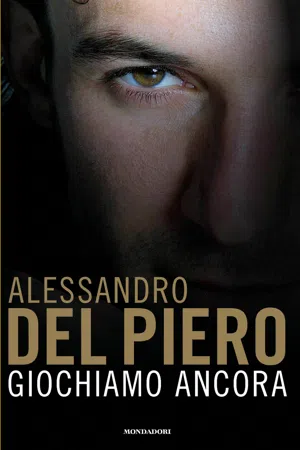![]()
L’ultima stagione alla Juventus è stata la più complicata della mia carriera, perché mi ha messo di fronte a una realtà che non avevo mai conosciuto: la realtà di chi gioca poco o niente. Avevi avuto l’impero, e ora fatichi a coltivare il campo nel tuo piccolo feudo. Non è facile. Bisogna sapersi mettere in discussione.
Credo che la forza di volontà sia uno dei valori che fanno la differenza nella vita e ci permettono di resistere, superando le difficoltà. Esistono problemi, dolori ovviamente molto più grandi che non guardare i compagni di squadra dalla panchina, però tutto, dentro e fuori lo sport, alla fine diventa una questione di testa. A volte l’avvilimento è più forte di te, e allora è facile abbandonarsi alla tristezza. In quei momenti ti chiedi chi sei, da dove vieni, un po’ rivedi la storia della tua famiglia, metti a confronto le tue ansie con quelle che aveva tuo padre, quando lavorava come un mulo per i figli, e grazie a tutto questo ti ritrovi. Il modo in cui sei cresciuto ti spiega come sei adesso e ti invita ad andare oltre, a non arrenderti.
Nella mia storia di calciatore, ho avuto anche momenti di pausa. Colpa degli infortuni, e a volte delle scelte degli allenatori. Mi è accaduto di essere sostituito. Di chi è la colpa? Io ho un modo di pensare molto pratico e meritocratico: se gioca un altro al posto mio, vuol dire che gli spetta. Poi, magari non è vero ma io ci credo, e mi demoralizzo. Eppure, non iniziare neanche le partite è molto peggio che interromperle. Ti metti in discussione, e questo va bene. Però, può capitare che ti metti anche in dubbio, e questo è pericoloso. Perché puoi perdere l’autostima.
Un atleta dev’essere per forza orgoglioso, e io lo sono, parecchio. L’amor proprio è un sentimento che conosco bene, e che mi ha sempre aiutato. Amor proprio, autostima, consapevolezza dei propri mezzi e anche quel sano egoismo che non guasta. Nessuno accetta a cuor leggero di lasciare il posto a un altro. Nessuno pensa veramente di valere meno di un altro. Se lo credi, parti sconfitto e lo sport non potrà essere il tuo mestiere. Il professionismo, intendo. Ma attenzione, questo non significa non essere capaci di giudicare le situazioni: se l’allenatore sceglie un altro, se ha più fiducia in lui che in te, questo è un fatto. E allora dovrai allenarti meglio, dovrai dare ancora di più ogni giorno. Non c’è scelta: un vero atleta deve dare il massimo sempre, in ogni allenamento, non solo in partita. Il problema può nascere quando sai di avere fatto davvero bene, di avere dato quello che dovevi, eppure l’allenatore continua a non sceglierti. Ecco, lì devi trovare risorse di resistenza supplementari. Devi parlare con te stesso a muso duro: “Ale, datti una svegliata!”. Così si ricomincia a salire, magari solo di qualche millimetro. Ma è tutto un percorso verso il giorno magico, quello che hai in mente e desideri più di ogni altra cosa.
Perché il giorno magico poi arriva, come scritto nel destino. L’ho già detto, io ci credo molto, anche se poi il destino lo riscriviamo noi ogni giorno. Riavvolgendo il nastro, ti accorgi che non poteva andare diversamente. Penso, ad esempio, al gol in Coppa Italia contro la Roma, la mia prima rete nel nuovo stadio della Juve. La desideravo con tutto il cuore, ma non arrivava mai. Non voleva saperne. Sbagliavo gol anche facili, e sempre con pochissimi minuti di gioco a disposizione. Finché, finalmente, il copione della mia carriera ha previsto una puntata degna del miglior film, persino più perfetta di come avrei potuto sognarla. Non mancava niente: una partita decisiva, un avversario importante, il meccanismo dell’eliminazione diretta, l’abbraccio con un grande capitano come Francesco Totti, l’anniversario della scomparsa dell’avvocato Agnelli, lui che era sempre stato molto sensibile alla bellezza del calcio. Questo il contesto. Poi, di conseguenza, è venuto il gesto. Una prodezza che chiamano gol alla Del Piero, perché reti del genere ne ho segnate parecchie. E devo riconoscere che il mio tiro contro la Roma, quella sera, è stato proprio meraviglioso. Un tiro “a giro” perfetto, con la palla che finisce all’incrocio dei pali, un’esecuzione potente e precisa. Impeccabile.
Ora, sembra troppo facile pensare che quel gol sia stato la naturale conseguenza della mia capacità di resistere, di non abbattermi e di farmi sempre trovare pronto dopo allenamenti vissuti al massimo. Sembra banale come ragionamento, però è così. È qualcosa di molto zen, il famoso tiro perfetto che sorprende prima di tutto il tiratore. Come mi succede spesso, quando rivedo un gol mi accorgo di cose che non avevo notato mentre lo segnavo. Contro la Roma, pensavo di avere toccato la palla una volta sola, prima del tiro, e invece sono state due. Nella mia mente ripasso l’azione, il tocco per Borriello, il rimpallo tra Kjaer e Taddei, il pallone davanti a me, la porta che neppure guardo, non ce n’è bisogno. Il resto è come un vuoto temporale, una sospensione delle cose. Non ricordo nulla, ho compiuto un volo con il pilota automatico.
La capacità di resistenza riguarda corpo e anima, muscoli e cervello. Con il cervello che, alla fine, governa tutto, perché attinge direttamente dal cuore. Il cervello è di gran lunga l’organo più importante che abbiamo, pur non essendo il motore. Io penso addirittura che il corpo chieda una tregua al cervello quando quest’ultimo è stanco, opaco. Gli infortuni più gravi, di solito, arrivano nei momenti di estrema fragilità mentale. Quando mi sfasciai il ginocchio a Udine, l’8 novembre ’98, il mio corpo e la mia mente avevano bisogno di una lunga sosta. Ricordo benissimo quel periodo: è come se tre campioni del mondo dei pesi massimi se la prendessero, a turno, con me, riempiendomi di botte. Prima, la sconfitta nella finale di Champions League contro il Real Madrid, dove mi faccio pure male: un cazzotto alla Tyson. Poi il mondiale in Francia, con le due prime partite saltate, gli ottavi vinti e l’eliminazione ai quarti di finale: un pugno alla Joe Frazier. Infine, in estate, i sospetti di doping nei confronti della Juventus: una randellata alla Foreman. E poi altro dolore, nuove delusioni in serie. L’infortunio di Udine. La lunghissima rieducazione e la difficile ripresa, lo scudetto perso a Perugia in quell’incredibile diluvio, infine gli europei del 2000 buttati via all’ultimo secondo, senza che io sapessi chiudere la sfida contro i francesi, in cui sbagliai due gol decisivi. Mi sentivo responsabile più di altri. Però bisogna pazientare, come fece l’Uruguay nella storica finale del Maracanã contro il Brasile nel 1950: era sotto 1-0 alla fine del primo tempo, ma poi vinse 2-1 conquistando la Coppa Rimet.
A quel punto, anche Muhammad Alì si era messo a massacrarmi, e che vuoi fare contro il più grande pugile di tutti i tempi? Si sta agli angoli, si alza la guardia e si aspetta che l’avversario abbia finito di mitragliarti di colpi. Però, quando riesci a rivedere la cosa a mente fredda, dopo qualche tempo – e può darsi che ne occorra proprio tanto –, allora capisci che anche quei colpi sono stati utili, o addirittura preziosi. Nulla di quello che ti accade è fuori logica. Nulla è estraneo dal tuo percorso di crescita, un viaggio nel quale non si può fare a meno del dolore fisico e psicologico. Chi non soffre, non migliora. E io sono sicuro che il Del Piero nato dall’infortunio di Udine sia diventato migliore, anche se il primo Del Piero aveva vinto tutto e si sentiva non solo imbattibile, ma invulnerabile.
Il corpo di un atleta sa quando è in pericolo, anche se non sempre se ne rende conto. Perché la mente gli invia segnali precisi, che pure devono essere interpretati. Esistono momenti della carriera, partite speciali, in cui si è coinvolti in modo strano, magari ci si arriva stanchi o troppo tesi, oppure si hanno problemi personali che non si riesce a tener fuori dal lavoro, e tutto questo ci rende più esposti ai traumi o alle lesioni muscolari. Difficile, forse impossibile stabilire un collegamento scientifico, ma so per esperienza che è così. Conosco giocatori che si sono fatti male prima di affrontare la loro ex squadra, oppure contro un avversario con cui avevano qualche conto in sospeso. Io credo al destino, ma al caso no.
Nei periodi fortunati, quando il corpo si sente più felice, non è comunque detto che si sia immuni dai rischi. L’ho capito in quest’ultima, stranissima stagione. Ho giocato a strappi, senza continuità, e il mio fisico è stato sottoposto a sollecitazioni mai provate. Di sicuro, è molto più complesso gestire la propria macchina atletica quando si hanno trentasette anni, piuttosto che quando ne avevi venti. E non mi riferisco al logorio fisico, perché in realtà è molto meno evidente di quanto possa sembrare. Io mi alleno con un preparatore personale, ho a disposizione uno staff solo per me, dunque posso calibrare ogni esercizio al millesimo, giorno per giorno. La vera stanchezza, semmai, può essere mentale. Nel senso che l’età la senti più nel cervello che nelle gambe. La nostra testa è una macchina meravigliosa e misteriosa, un grande alleato e un possibile nemico. Bisogna imparare a conoscerla, per prenderla nel verso giusto.
Tutto nasce dal cervello. È la testa che comincia a invecchiare, non il corpo. Quando il tempo passa siamo più tristi, ridiamo meno, questo è un fatto. Sentiamo il peso delle responsabilità, delle preoccupazioni legate alla famiglia, ai figli. Io provengo da un ambiente semplice, mio padre ha sgobbato sempre, mio fratello passava i vestiti dismessi a me, ai cuginetti o ai vicini di casa, perché al paese si usa così, ci si aiuta l’uno con l’altro. Penso spesso alla fatica che hanno fatto i miei genitori per allevare i figli, e mi dico che il loro insegnamento non finisce mai. Ricordo, al paese, che tutti si costruivano la loro casetta, faticando ogni giorno per due o tre ore dopo il lavoro. Ci si scambiava le competenze: mio padre elettricista dava una mano al vicino e gli preparava l’impianto, e magari questo vicino era muratore e gli tirava su una parete. A me sembra un modello sociale bellissimo. E i sacrifici di mio padre li ho compresi nel tempo. Quando sono tornato a casa per la prima volta con un macchinone – si trattava di un Mercedes SL a due posti soltanto, e due posti in una famiglia numerosa come la nostra sembravano davvero una scelta ridicola! – ecco, quel giorno ricordo di essermi un po’ vergognato. Mio padre era orgoglioso e non disse nulla, perché era un uomo taciturno. Tirò fuori dal garage la sua vecchia 127 per far posto al Mercedes, era un box piccolino, mi disse di stare attento a non rigare la fiancata. Quell’automobile che costava così tanto, uno sproposito per noi, mi ricordava chi fossi e da dove venissi.
Il dolore è una dimensione misteriosa, anche quello fisico. Credo di non avere mai sofferto tanto, nel corpo, come quel giorno a Udine, quando in una frazione di secondo compresi di essermi spaccato il ginocchio, senza bisogno della diagnosi medica. Mancava pochissimo alla fine della partita. Zidane mi passò la palla di testa e io feci per calciare. Il mio marcatore oppose il suo corpo, e senza volerlo stoppò la mia gamba nell’esatto momento in cui stavo tirando la frustata. È stato come ghigliottinare il legamento crociato, infatti l’articolazione si ruppe in tre punti: crociato anteriore, collaterale esterno, punto d’angolo antero-posteriore, con interessamento del crociato posteriore, per fortuna non strappato ma solo stiracchiato. Un disastro assoluto. Salvammo solo i menischi, che pure sono la cosa che dentro il ginocchio si ripara più facilmente. Sentii un dolore tremendo per almeno un paio d’ore: non servirono quasi a nulla due iniezioni intramuscolari di Voltaren.
Ricordo la prima diagnosi, ma come ho detto non avevo bisogno di strumenti clinici per sapere cosa mi fosse accaduto. Mi visitarono in Francia, mi operarono negli Stati Uniti e cominciai a guardare la realtà con altri occhi. Mi attendeva una pausa molto lunga: la cosa non mi piacque, però cercai di farne tesoro. Perché forse avevo un disperato bisogno di staccare la spina, anche se l’ho capito dopo. Penso che veramente esistano due Alessandro Del Piero: quello prima dell’incidente e quello dopo. Il ritorno in campo, ma soprattutto il ritorno verso me stesso, fu eterno. In pratica, durò due stagioni sportive. Perché, quando tornai a giocare, ero una specie di parco naturale, ero un’area protetta. Ogni scatto, ogni contrasto comportavano rischi. Dovevo essere cauto e nello stesso tempo ripartire, altrimenti non sarei mai tornato quello di prima. In quei casi l’inconscio ti frena, hai il terrore di romperti una seconda volta. Insomma, è proprio difficile uscirne.
Mi accadeva di non fare più gol su azione, non c’era verso. Segnavo solo su rigore, stava diventando una specie di maledizione, un vero tormento. Mi sbloccai nella penultima di campionato, di testa, in un modo che non appartiene al mio repertorio preferito. Quella rete fu un raggio di luce di brevissima durata, perché una settimana più tardi ci aspettava il Perugia, con il nubifragio e il nostro povero scudetto affogato in quell’acqua malefica.
Tutto finito? Era l’ultimo cazzotto in faccia? Magari! Dovevano ancora arrivare gli europei, con la tremenda finale persa contro i francesi per colpa del “golden gol”, una regola che è stata addirittura eliminata: si vede che non era giusta, però bastò per farci perdere il titolo. Stavamo vincendo 1-0, avevo tra i piedi due palloni perfetti per chiudere quella sfida: li sbagliai entrambi. Come ho detto, mi presi la colpa, tutta intera, anche quella che non era mia, e forse non fu una grande idea. Però lo feci d’istinto, mi sembrava corretto, ero molto deluso. E dire che fin lì avevamo giocato magnificamente. Nell’incredibile semifinale vinta ai rigori contro l’Olanda, avevo addirittura fatto il centrocampista. Tutto sembrava funzionare. Poi, il destino mi ha confermato che è lui l’avversario imbattibile. Da un’annata del genere si può uscire, o fuggire, solo andando molto lontano. Ricordo che scelsi le vacanze con la carta geografica, cercando il punto più remoto, e così finimmo in Polinesia. Scappare può essere una soluzione, ogni tanto.
Il dolore, compreso quello che nasce dalle sconfitte, ha sempre qualcosa di positivo. Perché ferisce, tocca la carne e l’anima, non si può restare indifferenti. È comunque una scossa, qualcosa che ci chiama in causa e ci chiede risposte precise. Non si fugge dalle conseguenze del dolore. Quelle vacanze furono soltanto una tregua, ora si trattava di ritrovare una vita normale, e possibilmente tornare a vincere. Mi chiedo se la mia soglia del dolore sia alta, bassa oppure normale. Per esperienza, ho capito che il male lo avverto subito e lo patisco, però so opporre resistenza. Soffro ma non mollo. Dunque, la mia soglia di resistenza è piuttosto bassa nell’impatto, anche se poi trovo le risorse giuste per non cedere. E alla lunga, vinco io. Andò così anche dopo il lunghissimo recupero dall’incidente di Udine, e dopo quella stagione di delusioni feroci. Ritornai Del Piero in una nuova e diversa versione di me, più completa di quell’altra, anche se meno sfrontata, meno “leggera”: perché la leggerezza appartiene soprattutto ai giovani che non hanno ancora sofferto davvero.
Il dolore più grande della mia vita è stato la perdita di mio padre. Penso che quel conto sia ancora aperto, non mi pare di averlo risolto. Non ho mai pianto in modo disperato la sua assenza, e forse prima o poi dovrò farlo. I tempi del dolore sono un mistero, più o meno come la creatività e il talento. Quando penso a mio padre, lo penso vivo e rivedo le nostre solitudini a confronto, i silenzi che ci scambiavamo, anche se poi era tutta una questione di sguardi, e con quelli sapevamo capirci benissimo. Ogni tanto ci abbracciavamo muti, un gesto che valeva più di qualunque discorso.
Lui non sapeva di essere condannato dalla malattia. O meglio, forse sapeva ma non lo diceva, non lo lasciava intuire a chi gli voleva bene. Credo che non volesse farci soffrire di più. I medici ci consigliarono di nascondere la verità, temevano complicazioni psicologiche. Così spiegammo a mio padre che era una cosa seria e che sarebbero serv...