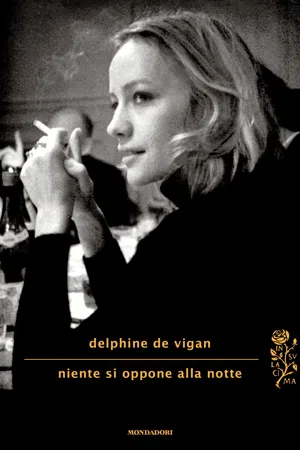![]()
![]()
Mia madre e mio padre hanno vissuto quasi sette anni insieme, per lo più in un appartamento di rue Auguste Lançon, in un angolo del tredicesimo arrondissement che conosco poco. Non ci sono mai tornata. Quando ho iniziato la stesura di questo libro, per la parte riguardante quei sette anni pensavo di lasciare una decina di pagine bianche consecutive, numerate come le altre ma prive di testo. Poi mi è sembrato che questo artificio avrebbe certo segnalato in modo visibile l’ellissi, ma non per questo l’avrebbe resa più accettabile, né tanto meno comprensibile.
In quegli anni mio padre ha lavorato per l’agenzia di Georges, poi, quando questa ha chiuso i battenti, come direttore amministrativo in una banca. Lucile non lavorava, si occupava delle due figlie: io dapprima, e poi Manon, mia sorella, nata quattro anni dopo di me. Lucile e Gabriel, visti da fuori, formavano quella che si dice una bella coppia. Andavano a cena dagli amici, trascorrevano i week-end in campagna dai rispettivi genitori, portavano le figlie al parco Montsouris. Si sono amati, si sono traditi, apparentemente tutto molto ordinario.
Non posso scrivere del periodo che Lucile ha vissuto con mio padre.
È un dato di partenza, un obbligo formale, un capitolo vuoto, sottratto alla scrittura. Lo sapevo ancor prima di cominciare questo libro e rientra fra le ragioni che a lungo mi hanno impedito di dedicarmici.
Quegli anni sono stati per Lucile un tempo di grande solitudine (lo ha detto spesso) e hanno contribuito alla distruzione della sua persona (sono io a scriverlo). L’incontro fra Lucile e Gabriel resta ai miei occhi l’incontro di due grandi sofferenze e, contrariamente alla legge matematica per cui moltiplicando due numeri negativi si ottiene un numero positivo, quell’incontro ha generato violenza e smarrimento.
Non ho interrogato mio padre riguardo a Lucile, mi sono limitata a chiedergli i documenti che erano in suo possesso (il rapporto di polizia redatto qualche anno dopo la loro separazione, in occasione del primo internamento di Lucile, e quello dell’indagine sociale che ne seguì, ma ci tornerò), documenti che mi ha fatto pervenire il giorno dopo via posta, senza alcuna difficoltà. Mentre ambisco a scrivere un libro intorno alla donna che forse lui ha amato, e odiato, più di ogni altra, mio padre si stupisce che non faccia appello ai suoi ricordi, che non voglia ascoltarlo. Ma mio padre non sa nulla. Ha riscritto la propria storia, e di conseguenza anche quella di Lucile, per ragioni che appartengono solo a lui e che non è il caso ora di commentare.
Per dare dimostrazione di una presunta coerenza nel mio procedere, non ho interrogato nessuno degli uomini che hanno condiviso da vicino o da lontano la vita di Lucile – né Forrest, il suo primo amore platonico, e neanche Nébo, il suo grande amore passionale, entrambi presenti, tuttavia, il giorno del suo funerale. Così potrò argomentare e dimostrare a mio padre che non è oggetto di nessuna discriminazione. Non sono sicura che ci crederà.
Non ho interrogato nessuno degli uomini che hanno condiviso la vita di Lucile e, a pensarci, mi sembra di aver fatto bene. Non voglio sapere che tipo di moglie o di amante Lucile sia stata. La cosa non mi riguarda.
Scrivo di Lucile con i miei occhi di bambina cresciuta troppo in fretta, scrivo il mistero che lei è sempre stata per me, così presente e nello stesso tempo così lontana, lei che non mi ha mai più abbracciato da quando ho compiuto dieci anni.
![]()
Quando Lucile lasciò Gabriel, aveva ventisei anni. All’inizio trovò rifugio dai genitori, a Versailles, dove abitammo per diverse settimane e dove fui iscritta in una scuola di quartiere. Di quel periodo conservo l’immagine confusa di una lavagna coperta da linee tracciate con il gesso bianco, che gli altri bambini sapevano leggere e che a me era impossibile decifrare. Alla fine mio padre venne a riprenderci, poi fummo di nuovo prelevate da Lucile, poi di nuovo da Gabriel, finché non venne firmata un’ordinanza di non conciliazione.
Più avanti Lucile si trasferì con un altro uomo in un appartamento di rue Mathurin Régnier, nel quattordicesimo arrondissement. Aveva conosciuto Tibère qualche mese prima tramite Barthélémy, che era diventato direttore artistico junior in un’agenzia di pubblicità. Tibère era un gigante dai capelli arancioni, fotografo indipendente e naturista convinto. Visto dal basso, veniva da un altro mondo e ispirava in noi un vago sentimento di paura. Il solo ricordo nitido che ho di quel periodo – oltre ai quadrati di cioccolata che Lucile faceva fondere e metteva sul pane per la nostra merenda e il programma televisivo che guardavo il giovedì, nel quale un ragazzo di nome Samson con un mantello raccontava favole ai bambini – è quello di un fortissimo mal di denti che la prostrò per diversi giorni. Lucile piangeva dal dolore. È una delle primissime immagini che ho di mia madre, già carica della mia impotenza di fronte al male che la sommerge.
Il divorzio dei miei genitori fu terribilmente ordinario, segnato da una lotta senza pietà per l’affidamento dei figli, condotta sulla base di testimonianze più o meno compiacenti raccolte dalle due parti. La sentenza fu pronunciata a danno di Lucile (la cui infedeltà venne dimostrata con una constatazione di adulterio notificata a mezzo di ufficiale giudiziario). Lei ottenne l’affidamento (o Gabriel glielo concesse, secondo le versioni). Avevo appena compiuto sei anni, Manon ne aveva due.
Lucile aveva trovato lavoro come segretaria in una piccola agenzia di pubblicità, dov’era stata selezionata tra un centinaio di aspiranti. Era l’unica ad aver incrociato Gilberte Pasquier.
Alla riapertura dell’anno scolastico, Lucile e Tibère cercarono un posto dove sistemarsi. Lisbeth si era sposata qualche anno dopo Lucile e si era trasferita nell’Essonne. Tramite il marito di Lisbeth, Lucile e Tibère vennero a sapere che si era liberata una villetta non lontano da casa loro. Al momento di avviare le pratiche, la leggenda narra che Tibère, sprovvisto di documenti d’identità, esibì la sua tessera di naturista. Fu concordato l’affitto. Traslocammo a Yerres, a una trentina di chilometri da Parigi. Il complesso dei Grands Godeaux era diviso in due parti dalla strada che portava lo stesso nome. Da una parte erano allineati alcuni edifici in mattoni rossi, dall’altra una decina di villette si disperdevano intorno a strette viuzze ricoperte di asfalto rosa. Poco più lontano, in direzione della stazione, si trovavano un fornaio, una farmacia e un negozio Coop.
Julien, il figlio di Tibère, venne a vivere con noi. Manon entrò alla materna mentre io iniziai la scuola elementare. Pochi giorni dopo l’inizio delle lezioni, Lucile venne convocata dalla direttrice didattica che la redarguì: era estremamente dannoso per gli alunni anticipare il programma scolastico. Lucile scoprì così che sapevo leggere e scrivere; si decise dunque di farmi saltare una classe.
Probabilmente quel giorno nacque in Lucile l’idea, che avrebbe conservato a lungo, che me la sarei sempre cavata, qualunque cosa accadesse.
In pieni anni Settanta Yerres fu per noi l’inizio di una nuova vita, circonfusa nei miei ricordi da un alone bizzarro e luminoso. Lucile e Tibère dipinsero il parquet del salotto di bianco, mentre i materassi appoggiati per terra, che fungevano da divani, vennero tinti di verde. Poco alla volta la nostra villetta venne invasa da un caos incredibile e allegro, a immagine del nostro modo di vivere, in cui i pochi divieti dipendevano più dalle condizioni del tempo o dall’umore che dall’educazione. Potevamo appoggiare i gomiti sul tavolo e leccare i piatti, disegnare sui muri, andare e venire come ci pareva, passavamo la maggior parte del tempo fuori casa, con gli altri bambini. Avevamo paura del signor Z., il dirimpettaio, del quale si raccontava che non sopportasse il chiasso e che non esitava a tirare fuori la carabina, avevamo paura del cane giallo, che veniva da chissà dove e gironzolava davanti alle case, con la coda bassa e l’aria sorniona, avevamo paura dell’esibizionista che era spuntato da un cespuglio, una sera d’inverno, mentre uscivamo dal centro culturale. Il nostro territorio, comunque, continuava ad allargarsi.
La sera, amici e amici degli amici venivano a cena, a bere qualcosa, a farsi una canna. Una spessa coltre di fumo invadeva il salotto. La nostra alimentazione era essenzialmente composta da spaghetti o conchiglie, accompagnati o meno da salsa di pomodoro, giravamo a bordo di una vecchia 403, anche lei dipinta di verde. Lucile si recava tutti i giorni a Parigi, Tibère girava nudo per casa, rubava arrosti confezionati al negozio Coop e, fra un servizio fotografico e l’altro, faceva l’uomo di casa.
Nel quartiere iniziò a correre la voce che casa nostra fosse un ritrovo per hippy e drogati, cosa che mi venne ripetuta a scuola, senza che ciò avesse particolari ripercussioni nel mio animo. Eravamo diversi, non eravamo come le altre famiglie, il resto mi sfuggiva, non aveva alcun significato. Tutti i giovedì a mezzogiorno ero invitata a pranzo da una mia compagna di classe, la cui madre si vantò in seguito di offrirmi la sola bistecca che mangiassi durante la settimana. Quando Lucile lo venne a sapere, smisi di andarci.
Ben presto facemmo la conoscenza dei Ramaud, una famiglia di sette bambini cresciuti dalla madre, che abitavano nella villetta accanto. Fra la loro casa e la nostra s’instaurò una specie di libera circolazione dei beni (merende, giochi, biro, bambole) e delle persone, che si prolungò per diversi anni. Sognavo di avere un reggiseno come quello di Estelle, la figlia maggiore, e, come lei, di piacere ai ragazzi.
Ci raggruppavamo più o meno secondo l’età, e a volte tutti insieme per giochi più estesi. Con le mie amiche ripetevo all’infinito le coreografie di Claude François, che costituivano l’attrazione principale degli spettacoli gratuiti che davamo sul prato comune.
Sandra abitava in uno dei palazzi della zona. Nonostante le voci che correvano, i suoi genitori le permettevano di venire da noi e anche di restare a dormire. Fu la mia prima amica d’infanzia. Il mercoledì, come altri bambini del quartiere, Sandra andava a catechismo. Si poteva mangiare la torta quattro quarti e bere aranciata a sazietà. Pretesi di andarci, Lucile rifiutò.
A modo nostro conducevamo una vita regolare, le cose si ripetevano e si susseguivano sempre uguali, Lucile lavorava a Parigi, Tibère si occupava della spesa e della casa.
A week-end alterni Gabriel veniva a prenderci. Parcheggiava la sua BMW davanti a casa, ci aspettava in strada, eravamo le regine del mondo.
Durante i ponti o in altri week-end andavamo ogni tanto a Pierremont, dove Liane e Georges si erano trasferiti. I miei nonni avevano lasciato Versailles, l’agenzia di Georges era fallita e, con l’eccezione di Tom, i fratelli e le sorelle di Lucile se n’erano andati tutti.
L’anno del mio settimo compleanno Lucile mi portò a Londra. Non so quale evento fosse all’origine di questo viaggio, forse l’età della ragione che avevo raggiunto. Al mercatino delle pulci di Portobello Lucile scovò fra gli abiti usati due minigonne in tergal (una rosa, una verde, entrambe a forma trapezoidale) e le comprò per me. Le ho indossate finché non mi sono arrivate a metà natica e furono, per mesi, il pezzo forte del mio guardaroba (vennero rimpiazzate da un paio di pantaloni di velluto liscio Newman color pesca, recuperato dalla figlia di un’amica, di cui andai ugualmente fiera).
Nulla era grave, né le piattole che Lucile e Tibère si presero al cinema di Brunoy (secondo la versione ufficiale) e che per qualche tempo si trasferirono nelle nostre capigliature infantili (Manon le aveva fin nelle sopracciglia), né le mattine in cui arrivavamo tardi a scuola, né quella in cui entrai in classe con la testa ancora coperta di Paranix, il cui odore di aceto si sentiva anche a cento metri di distanza (Lucile non aveva avuto il tempo di sciacquarmi i capelli), né la fine degli arrosti e dei polli confezionati (Tibère si era fatto beccare al negozio Coop), né l’insistenza di Julien, che mi chiedeva di accarezzargli il sesso fino all’eiaculazione, cosa che accettavo di fare all’unica condizione di avvolgere la mano in un guanto di spugna.
Quell’epoca nasconde le sue zone d’ombra.
D’estate partivamo per il campo naturista di Montalivet, dove Lucile e Tibère affittavano un bungalow in mezzo ai pini. Ritrovavamo i loro amici, una comunità a geometria variabile che ci precedeva, ci accompagnava o ci raggiungeva, alcuni erano di passaggio, altri restavano, piantavano la loro tenda nella foresta. Eravamo nudi sulla sabbia, nudi al supermercato, nudi in piscina, nudi lungo i sentieri coperti di spine, e la mia amica Sandra, che veniva in vacanza con noi, fu pregata di provare de visu l’esistenza di una sua scottatura per avere il diritto di andare in spiaggia con le mutandine del costume.
Le fotografie di quegli anni, per lo più scattate da Tibère, sono quelle che preferisco. Raccontano un’epoca. Amo i colori, la poesia, l’utopia che contengono. Lucile ne possedeva alcune stampe. Dopo la sua morte ne ho fatte sviluppare altre, ritrovate in casa sua dentro uno scatolone, in formato diapositiva. C’è quella di mia madre, in mezzo alla folla, scattata durante una manifestazione nel Larzac. Un’altra in cui Lucile, vestita con pantaloni a zampa d’elefante a scacchi multicolori, tiene Manon in braccio. Fra queste fotografie una sequenza m’incanta e mi turba: Manon, il cui vestitino verde e bianco sembra uscito direttamente da un revival anni Settanta, gioca con una pompa da giardino, la pelle abbronzata, le cosce grassottelle, in una successione di smorfie inverosimili. C’è anche quella in cui posiamo tutti insieme (una dozzina di persone), nudi come vermi davanti al bungalow di Montalivet, i piccoli davanti e i grandi dietro, perfettamente allineati, il mento in alto e il sorriso dell’estate.
In qualche fotografia si rivedono Lisbeth, Justine o anche Violette, credo che sia un periodo in cui Lucile è meno sola, in cui si avvicina ai fratelli e alle sorelle. Qualche volta Lucile fa da modella per Tibère, mi sembra che non sia mai stata così bella.
Nella luce radente di un tardo pomeriggio, Tibère fotografa Manon e Gaëtan (il figlio di un’amica di Lucile) che camminano di schiena sulla spiaggia. Si danno la mano, abbronzati, con i culetti nudi e la sabbia incollata alla pelle. Di quello scatto Tibère farà un poster, che sarà venduto in migliaia di copie in tutti i supermercati di Francia.
Nella mia collezione personale è presente anche una foto mia e di Manon a Yerres, mentre andiamo a scuola, con le cartelle in spalla. In rue des Grands Godeaux ci siamo voltate per guardare l’obiettivo, io indosso un mini kilt stravagante, al ritorno dalle vacanze i nostri capelli sono quasi bianchi.
Queste immagini, e ogni loro particolare (vestiti, taglio di capelli, gioielli), fanno parte della mia mitologia personale. Se le epoche si riassumono nel luogo che le contiene, Yerres resta per me l’emblema di un “prima”. “Prima” dell’inquietudine. “Prima” della paura. “Prima” che Lucile sragioni.
Con il passare del tempo la memoria ha fatto la sua selezione, questo è quello che ha prevalso.
Pochi mesi fa un giornalista che mi sostiene da tempo e di cui apprezzo il garbo mi ha contattata per sapere se avrei accettato di partecipare a una serie sui luoghi degli scrittori che stava preparando per la radio. Avevo un luogo simbolo? Stazione balneare, dimora di famiglia, capanna per scrivere sperduta in mezzo ai boschi, scogliera battuta dalle onde? Ho subito pensato a Yerres, teoricamente meno in sintonia con il suo palinsesto estivo. Ha accettato. Yerres fu per me come un’età dell’oro, mi appartiene, e del resto appartiene solo a me. Non sono sicura che Lucile o Manon la ricorderebbero nello stesso modo.
Ci abbiamo vissuto quattro anni, due anni con Tibère, poi due anni senza di lui. Credo che Lucile l’abbia lasciato, oppure si sono separati. Tibère era per lei l’uomo del distacco, della transizione. Ci ha lasciato Julien, suo figlio, che è rimasto a vivere con noi fino al nostro trasloco.
Del periodo che seguì la partenza di Tibère conservo ricordi più confusi. Molte delle persone che circondano Lucile non sono più le stesse, qualcuno è sparito, altri si sono aggiunti, altri sono semplicemente di passaggio.
È in questo periodo che Lucile incontrò Nébo, di cui s’innamorò perdutamente e che rimase, fino alla fine dei suoi giorni, il suo grande amore ferito. Nébo era di origine italiana, aveva i capelli di un nero che sembrava immutabile e gli occhi verde mare. Era di una bellezza e di un magnetismo che non passavano inosservati. Si diceva che fosse un donnaiolo, un uomo che non si legava, o comunque è il ricordo che ho di lui, della reputazione sulfurea che lo circondava e lo rendeva inaccessibile. Per qualche mese Nébo passò alcune serate nel nostro salotto dal parquet bianco, comparve a intervalli, con o senza i suoi amici, non cercò di stabilire alcun contatto con noi. Io ascoltavo le conversazioni degli adulti, i nomi che giravano, Freud, Foucault, Wilhelm Reich, cercavo di ricordare sigle che non capivo.
Estelle Ramaud fece la prima comunione e in quell’occasione ricevette un orologio e alcuni reggiseni di pizzo. Io fui presa da una crisi mistica e pretesi di farla anch’io su due piedi, al che mi fu risposto che, primo, non andavo al catechismo e, secondo, non mi era ancora spuntato il seno.
Venimmo derubati una prima volta, i gioielli di Lucil...