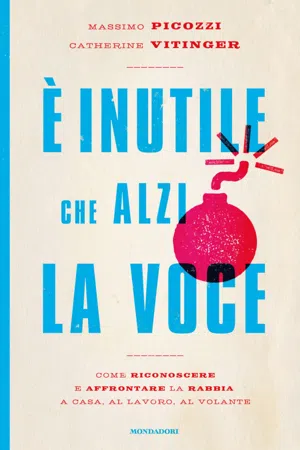![]()
Ero arrabbiato con il mio amico: glielo dissi, e la rabbia finì. Ero arrabbiato con il nemico: non ne parlai, e la rabbia crebbe.
WILLIAM BLAKE
A Bill Bland piace il suo lavoro, anche se deve urlare dalla mattina alla sera; ma spesso gridare non serve, allora prende carta e penna e scrive alla direzione, denunciando chi ha infranto le regole.
Bland è convinto di aver sempre ragione, perché un responsabile non può permettere che il suo ufficio postale vada in malora, e non importa se qualcuno pensa sia solo un sadico stronzo; come quella volta che aveva spedito la lettera di sospensione a Patrick Sherrill, il postino, perché aveva lasciato senza custodia tre pacchi e un paio di scatoloni di posta; poi, nel dubbio che sette giorni senza stipendio non fossero abbastanza, aveva deciso di cronometrare il suo giro di consegne.
Questo è successo nove mesi prima, e nessuno ha fatto caso ai cambiamenti di Sherrill, sempre più chiuso in un silenzio carico di rabbia. Intanto, nella sua testa, è maturata la convinzione che il suo capo stia solo cercando un pretesto per licenziarlo, e l’occasione arriva la mattina del 19 agosto 1986, quando Bill Bland lo chiama in ufficio e gli urla in faccia che è un incapace e un parassita.
45 anni non ancora compiuti, un metro e ottanta di altezza per novanta chili, Sherrill non ha amici e vive da solo, dopo che la madre, malata di Alzheimer, è morta nel 1978.
L’unica cosa che gli rimane è il lavoro.
Dopo la tragedia saranno in molti a raccontare che era un tipo strano, capace di mettersi a falciare il prato di casa in piena notte, o di spiare i vicini sbirciando attraverso le loro finestre; ma c’è anche chi dirà che sembrava solo una persona triste; garbata e gentile, ma disperatamente triste.
Sono passate da poco le sei e mezzo di mattino del 20 agosto, e solo un giorno da quando il suo capo lo ha aggredito in ufficio.
Patrick parcheggia l’auto davanti all’ufficio postale di Edmond, Oklahoma, e afferra la sacca della posta, quella dove ogni giorno infila buste e raccomandate da distribuire nel suo giro.
Ogni giorno, ma non oggi, perché nella sacca ci ha messo due semiautomatiche calibro 45 e almeno duecento colpi di scorta.
Gli basta una ventina di minuti per entrare, estrarre le armi e prendere la mira, sparando con metodo; non risparmia nessuno, nemmeno chi ha cercato rifugio sotto le scrivanie.
Non risparmia il supervisore Patty Jean Husband, che anziché scappare lo affronta e gli grida in faccia che è un pazzo figlio di puttana.
Sono le sue ultime parole.
Prima di piantarsi in testa l’ultima pallottola, Patrick Sherrill si lascia dietro quattordici cadaveri e sei feriti, nel più grave omicidio di massa sul lavoro mai accaduto.
Per l’amara ironia del destino, Bill Bland, il primo obiettivo della furia del postino, non è tra le vittime della carneficina: proprio quel giorno aveva deciso di prendersi un’ora di permesso e restarsene a casa a dormire.
Né Sherrill, né tantomeno Bland potevano sapere che negli anni a seguire la loro storia avrebbe scatenato una serie di drammatici eventi, un’epidemia di stragi consumate negli uffici postali da dipendenti mossi da una furia distruttiva. Tanto che per definire un tizio fuori controllo, che si vendica sul posto di lavoro uccidendo in preda alla collera, si usa il termine «going postal».
Il tutto accompagnato dal cinico umorismo di battute del tipo: «Sai che significa una bandiera a mezz’asta davanti a un ufficio postale? Vuol dire che assumono gente nuova».
Gli esperti hanno faticato un po’ a capire come mai tanti massacri proprio negli uffici postali, posti tranquilli, dove al massimo ti aspetti che siano i clienti in coda a perdere la pazienza (il che, beninteso, accade con sempre maggiore frequenza).
Ma poi ci sono arrivati, con una spiegazione in verità abbastanza semplice: il servizio postale rappresenta il secondo datore di lavoro degli Stati Uniti, e con la legge di riorganizzazione voluta da Nixon del 1970, i suoi dipendenti si sono trovati con una tutela sindacale sensibilmente indebolita, a fronte di un regime di concorrenza mai sperimentato prima. Una combinazione di elementi che si è tradotta nella ricerca di una maggiore competitività attraverso carichi di lavoro sempre più pesanti.
Ma gli episodi di violenza, fino a quei casi che sono definiti «omicidi per rabbia», non sono una prerogativa solamente americana.
21 gennaio 2010, Montecatini Terme.
Silvano Condotti ha 55 anni, e quando entra in Comune non è che gli badino troppo.
Conoscono la sua storia, quella di un autista di scuolabus che un giorno ha dato uno schiaffo a un bambino, e per questo è stato licenziato.
Sanno anche che quel provvedimento Silvano non l’ha mai accettato perché, se pure ha commesso uno sbaglio, è convinto di meritarsi un’altra opportunità.
Ha fatto ricorso, ha perso ma non si è arreso, nemmeno quando il processo d’appello ha confermato la sentenza.
Come già tante volte gli è successo, anche quella mattina si è diretto verso l’ufficio di Giovanna Piattelli, 60 anni, la dirigente dei servizi scolastici, le ha scaricato addosso tutte le sue rabbiose proteste, e poi se n’è andato, scuro in volto, frustrato e deluso.
Ma poi, quello stesso giorno, è tornato; e questa volta accompagnato non solo da pretese e richieste, ma da una pistola stretta nel pugno.
Questa volta si accorgono di lui, e in preda al terrore si barricano negli uffici; ma Silvano ha un solo obiettivo, e appena arriva a tiro, spara a Giovanna, uccidendola sul colpo.
Poi scappa, e subito polizia e carabinieri si mettono a cercarlo, organizzando posti di blocco per la città, avvisando di stare attenti, perché si tratta di un «soggetto armato e pericoloso». La dirigente non è infatti l’unica con cui l’uomo è arrabbiato: nei suoi discorsi Silvano Condotti parlava sempre del sindaco, di quello che avrebbe potuto fare per non togliergli il lavoro o per restituirglielo.
Silvano, sposato e con un figlio, lo trovano a casa sua. Appena vede arrivare gli agenti, in un attimo si rende conto dell’enormità di ciò che ha fatto, s’infila la canna della pistola in bocca. E poi preme il grilletto.
Lo stesso giorno della tragedia di Montecatini, un altro grave episodio di rabbia e violenza sul posto di lavoro occupa le pagine della cronaca nera.
Fortunatamente, almeno questa volta, senza perdita di vite umane.
Gabriele Mancini ha 41 anni, una laurea in ingegneria, e da tempo lavora nel corpo dei vigili del fuoco di Roma. Difficile dire cosa abbia scatenato la sua collera, ma durante una discussione tra colleghi, improvvisamente tira fuori di tasca un coltello e comincia a gridare che sgozzerà tutti. Finisce per colpirne almeno sette, e quattro li investe con l’auto nel tentativo di fuggire.
Qualche segnale di crisi, in realtà, lo aveva già dato: giusto qualche mese prima dei fatti, era stato visitato da uno psichiatra, e poi sottoposto a una visita per l’idoneità al servizio.
Ma Gabriele era stato bravo a fingere; oppure chi l’aveva esaminato non aveva intuito il suo disagio, dichiarandolo abile al lavoro.
Edmond, poi Montecatini e Roma, sono fatti eccezionali, ma rappresentano la punta di un iceberg, la piccola parte drammaticamente visibile di un fenomeno in preoccupante aumento.
Da sempre siamo abituati a considerare l’ambiente di lavoro come uno spazio sicuro, al contrario di casa e famiglia, classici teatri di violenze e tragedie; o almeno così è stato fino a una trentina di anni fa, quando un mix di competizione sfrenata e carichi eccessivi ha trasformato uffici e aziende in contenitori di rabbia pronti a esplodere.
A tutti noi è capitato di arrabbiarci perché trattati con sufficienza da un collega, oppure offesi da un capo insensibile, dalle sue decisioni miopi e unilaterali; e nel ventaglio di emozioni che va dal semplice fastidio allo scoppio di una collera irrefrenabile, proviamo una qualche forma d’irritazione sul lavoro almeno dieci volte al giorno.
Ma la novità degli ultimi tempi è che fatichiamo sempre più a controllarci, a gestire il risentimento e la frustrazione; piuttosto li esprimiamo attraverso performance ridotte, minacce e molestie, atti di sabotaggio, aggressioni verbali e fisiche; con inevitabili ricadute sul clima emotivo, sulla produttività e sul bilancio dell’azienda, in un circolo vizioso e distruttivo.
Di fatto, l’estensione del problema è così preoccupante che, per evitare l’imbarazzo e il danno di una cattiva immagine, spesso accade che gli episodi critici non siano nemmeno segnalati.
Naturalmente la vicenda è complessa, ed è impossibile identificare una sola ragione che ne spieghi l’origine, ma certo la crisi economica gioca un ruolo decisivo; ridimensionamenti, ristrutturazioni, cambiamenti radicali nel mondo del lavoro trascinano inevitabilmente con sé mortificazione, paura e rabbia.
La tanto invocata disponibilità ad accettare e vivere la flessibilità implica una grande capacità di adattamento, che a sua volta poggia sulla sicurezza di sé e l’autostima, merci rare di questi tempi.
Chi rischia di perdere il posto sa poi molto bene quanto sia difficile trovare una nuova sistemazione, simile per mansioni, soddisfazione e compensi. Le statistiche dicono, infatti, che l’80 per cento dei lavoratori ci riusciva negli anni Sessanta e Settanta; la percentuale è scesa al 50 per cento nei primi anni Ottanta, al 25 per cento agli inizi degli anni Novanta, per arrivare al 10 per cento alla fine del secolo scorso, e peggiorare ancora nel terzo millennio.
Se il messaggio che passa è che ognuno rischia di essere sfruttato e poi accantonato, ne deriva un senso di alienazione, la perdita di qualunque forma di attaccamento e fedeltà all’azienda.
È uno dei moderni paradossi: si ama il proprio lavoro, mentre si finisce per odiare la struttura, le regole e l’ambiente dove lo si svolge ogni giorno.
Poi, accanto ai mutamenti macro e micro-sociali, c’è sempre il fattore umano.
Non sono pochi i casi in cui un dipendente con difficoltà emotive e scarsa stima di sé guarda al posto di lavoro come al supporto emozionale di cui ha bisogno. La percezione di non essere compreso e apprezzato, dolorosa per tutti noi, può avere effetti devastanti su chi vive il lavoro come l’unica cosa importante della propria vita; proprio com’è successo a Patrick Sherrill, l’autore della strage di Edmond.
Certo il problema non è solo l’irritazione o la rabbia, piuttosto il modo in cui le emozioni sono vissute e agite.
Molti riescono a gestirle, altri non ce la fanno; può dipendere da uno sfortunato assetto genetico, o dalla storia familiare e personale; anche lo stile di pensiero influenza la predisposizione alla rabbia: dare per scontate le cose positive, enfatizzare le negative, essere eccessivamente perfezionisti sono tutte condizioni che possono innescare sentimenti di rabbia; così come le convinzioni personali sui concetti di giustizia ed equità.
Esiste poi un forte legame tra pensiero e tono dell’umore: più negativo è il sentire, maggiore è la propensione alla collera, soprattutto se i pensieri sono basati sulla percezione di minaccia o ingiustizia.
Michele, Giovanni e Pietro sono candidati per una promozione a direttore marketing in una importante catena di supermercati.
Professionisti ancora giovani, i tre sanno che l’occasione è preziosa e si preparano alla selezione con grandi aspettative e atteggiamenti del tutto...