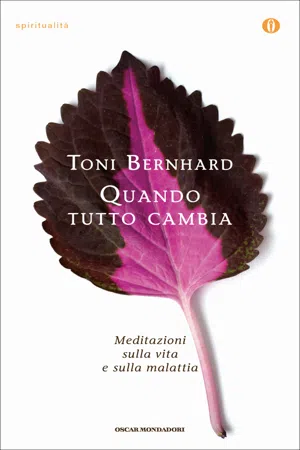![]()
![]()
Non dovremmo aggrapparci
assolutamente a niente.
BHIKKHU BUDDHADASA
Molti insegnanti consigliano di iniziare la pratica buddhista partendo dalla meditazione, ma il mio retroterra accademico mi costrinse a dedicarmi innanzitutto alla lettura di testi e a un po’ di ricerca. Il mio bisogno di dare alla cultura la priorità era tale che, al primo spuntare del mio interesse per il buddhismo nel 1992, feci subito una ricerca e scrissi un saggio di venti pagine, completo di note, che forniva le fonti di almeno tre dozzine di libri. Lo intitolai “Introduzione al buddhismo”. Dato che non ricordo di avere dato a nessuno questo dotto libello, penso che il suo unico scopo fosse di introdurre me stessa al buddhismo.
Durante questa fase di studio erudito adottai una strategia che mi è stata utile: se incontravo un insegnamento che non capivo, lo saltavo. Fu la mia prima relazione con la ruota della sofferenza. La saltai e passai a un insegnamento più accessibile.
Iniziai i miei studi da un libro che già avevamo in casa: What the Buddha Taught, scritto nel 1959 da Walpola Rahula, un colto monaco dello Sri Lanka. Nel 1992, quando lo sfilai dalla libreria, quest’opera era ancora considerata da molti una guida determinante per introdurre al buddhismo gli occidentali. Non era una lettura facile, soprattutto a paragone delle dozzine di testi semplici su questo tema ora disponibili. Quando arrivai alla trattazione di Rahula della dottrina chiamata paticca-samuppada, la “ruota della sofferenza” o dell’“origine dipendente”, com’è più spesso definita, avrei potuto molto facilmente deragliare in questa nuova ricerca spirituale se non l’avessi semplicemente sorvolata. Il suo uso di espressioni come “genesi condizionata” e “cessazione delle formazioni volitive” mi facevano girare la testa come una trottola.
Ma anni dopo, una volta stabilizzata la pratica meditativa, affrontai di nuovo quell’insegnamento attraverso gli scritti di Ayya Khema e il libro Vipassana Meditation as Taught by S.N. Goenka di William Hart.
Paticca-samuppada può essere tradotto in molti modi. La traduzione più comune è “origine dipendente”, ma io preferisco “ruota della sofferenza”, perché descrive meglio la nostra esperienza. Con l’avvertimento che la mia non sarà un’analisi dettagliata né dotta, passo immediatamente in rassegna questa dottrina, per spiegare come fare di questi insegnamenti uno strumento pratico per alleviare la sofferenza mentale che accompagna la malattia cronica.
Nella vita quotidiana abbiamo continui contatti attraverso i sei sensi. (Il buddhismo, come altri sistemi filosofici indiani, include come sesto senso la facoltà mentale che coordina le percezioni.) Percepiamo questi contatti sotto forma di sensazioni piacevoli, spiacevoli o, più raramente, neutre. Se l’esperienza del contatto è piacevole, ne vogliamo di più, e questo è il desiderio. Se l’esperienza del contatto è spiacevole, vogliamo che se ne vada, che è semplicemente un’altra forma di desiderio, il desiderio che vada via, di solito definito nel buddhismo “avversione”. Il termine pali per questo desiderio/avversione, come abbiamo già detto, è tanha. Mi piace definire tanha come “voglio/non voglio” perché descrive piuttosto bene uno dei due stati mentali in cui mi trovo gran parte di ogni giorno.
La mente si aggrappa a questo desiderio o avversione, appiccicandosi a esso come una colla. Questa parte del processo è chiamata in vari modi: aggrapparsi, afferrare, o attaccamento. Una volta che ci siamo aggrappati al desiderio o all’avversione, non c’è possibilità di tornare indietro. Questo afferrare dà origine al senso di un sé solido, come se la colla si fosse seccata. In breve, noi rinasciamo momento per momento in identità di sé che creiamo afferrandoci o attaccandoci ai nostri desideri e avversioni.
A quel punto dobbiamo affrontare le conseguenze della nascita, o rinascita, se preferite, in cui cadiamo ogni momento. Queste conseguenze sono quello che viene chiamato karma e affrontare queste conseguenze è la maturazione o la realizzazione del karma.
Un esempio semplice. C’è un contatto con il mondo sotto forma di qualcuno che ci passa davanti nel traffico anche se abbiamo noi la precedenza. Notate che il contatto coinvolge più di un senso: gli occhi vedono spuntare l’auto, le orecchie sentono che si muove, il sesto senso pensa: “Mi sta tagliando la strada, anche se ho la precedenza”. La parte del contatto che coinvolge la mente è percepita come una sensazione spiacevole. Prima di riuscire a fermarci, reagiamo con avversione alla spiacevolezza. In effetti, non possiamo liberarci dall’avversione. Ci afferra, si appiccica come una colla e in quell’istante stiamo per “diventare” e “rinascere” nella forma di persona arrabbiata. Ed eccola lì: la sofferenza, la Prima Nobile Verità.
La buona notizia è che possiamo spezzare il ciclo prima di arrivare in quel luogo di sofferenza diventando consapevoli proprio il momento prima che una sensazione spiacevole dia origine al desiderio che le cose siano diverse da quello che sono. S.N. Goenka lo chiama “imparare a osservare [una sensazione spiacevole] obbiettivamente”. Aggiunge che fra il contatto e la reazione a esso, il desiderio o l’avversione, c’è un passo cruciale: “Quando impariamo a osservare la sensazione senza reagire con brama e avversione, la causa della sofferenza non sorge e la sofferenza finisce”.
La frazione di secondo tra l’esperienza di una sensazione piacevole o spiacevole e il sorgere del desiderio per la prima o dell’avversione per la seconda è la via d’uscita, la nostra occasione di uscire dalla ruota della sofferenza. Non possiamo evitare il sorgere della sensazione o dell’impressione dopo un contatto, toccare un fornello rovente sarà spiacevole! Ma Ayya Khema dice che la pratica consiste nel vedere la sensazione semplicemente come sensazione senza possederla. Dopotutto, dice, se veramente “possedessimo” le nostre sensazioni nel senso di essere pienamente capaci di controllarle, permetteremmo a sensazioni e percezioni solo di essere piacevoli! È anche quello che intende S.N. Goenka quando dice che dovremmo imparare a osservare le sensazioni obbiettivamente.
Quando qualcuno ci passa davanti nel traffico anche se abbiamo la precedenza, possiamo semplicemente osservare che la sensazione è spiacevole e lasciare l’esperienza così, senza reagire, non è che uno dei migliaia di contatti momentanei che incontriamo ogni giorno. Non solo vedremo la verità dell’impermanenza, ma anche non sorgerà la sofferenza e, prima ancora di essercene accorti, siamo già passati al contatto successivo della giornata, che può essere un sorriso di empatia di un altro automobilista.
Questo ci introduce a una pratica che ho creato combinando gli insegnamenti della ruota della sofferenza e i quattro stati sublimi, anche se può sembrare un’associazione improbabile.
Praticare con la ruota della sofferenza e i Quattro Stati Sublimi
L’idea di questa pratica è nata da un insegnamento della meravigliosa e saggia insegnante Sylvia Boorstein, che ho già menzionato. Sylvia è una dei fondatori di Spirit Rock. Nel suo libro Happiness Is an Inside Job racconta di un soggiorno con il marito, Seymour, in una località sciistica in Europa. Guardando gli altri imparare a sciare, Sylvia ricordava quando lei e Seymour affrontavano insieme le discese prima che per la loro età diventasse rischioso. Non appena la sua mente iniziò a “oscillare”, così diceva lei (il mio oscillare sarebbe finito dritto nella spiacevole sensazione mentale dell’invidia), osservò intorno a sé tutto il divertimento in cui erano immersi gli altri e all’improvviso provò un grande piacere per la loro gioia, specialmente per quella di una bambina che stava imparando i primi rudimenti dello sci. E quindi, con la sua mente saggia, Sylvia trasformò quello stato mentale di approccio negativo nello stato sublime di gioia per la gioia dell’altro.
Dopo aver letto questo capitolo del libro di Sylvia, io e Tony parlammo di come sembri innata l’esperienza del contatto come piacevole, spiacevole, o neutra. Intendendo sia il contatto fisico che mentale: non posso trasformare in un’esperienza piacevole il contatto con un fornello rovente più di quanto possa trasformare un commento razzista in un’esperienza piacevole. La questione per me è se posso uscire dalla ruota della sofferenza a quel punto, prima che l’esperienza spiacevole di qualcosa, come il commento razzista, si trasformi in avversione, il lato “non voglio” del desiderio. Una volta che reagisco con avversione, l’attaccamento non è molto lontano e, prima che me ne accorga, ho completato il ciclo e sono “rinata” come persona così piena di rabbia da essere incapace di compiere un’azione saggia per replicare al commento.
Mentre tentavo di riposare rimuginai a lungo sul capitolo dello sci nel libro di Sylvia e la discussione con Tony. Sdraiata a letto, il corpo doleva come per i sintomi di un’influenza, il cuore martellava per l’affaticamento esasperato. Ovviamente, lo percepivo come una sensazione fisica spiacevole. La mente iniziò il suo solito movimento, l’”oscillare” di Sylvia, dall’esperienza della sensazione spiacevole all’avversione verso questa sensazione, quando compresi come trovare la via d’uscita di cui parlano S.N. Goenka e altri. In altre parole, trovai un modo per rompere il cerchio vizioso della sofferenza, spostando la mente verso uno dei quattro stati sublimi.
Sdraiata a letto, i sintomi simili a quelli influenzali erano in effetti fisicamente spiacevoli. Ma, anziché permettere distrattamente all’avversione di sorgere come avevo fatto migliaia di volte in passato, compresi che potevo scegliere dove mettere la mente. Così la spostai consapevolmente verso la gentilezza amorevole, ripetendo in silenzio: “Caro, dolce, innocente corpo, che lavori tanto per sostenermi”. Dirigere questo augurio di bene al corpo fu la mia via d’uscita da dukkha. Uscii dalla ruota della sofferenza. Ero libera dall’avversione verso la mia malattia e da tutte le conseguenze di quell’avversione, per esempio diventare e rinascere come persona amara e risentita.
Ovviamente, ero così condizionata a spostarmi immediatamente nell’avversione o nel desiderio che questa scoperta non significava non doverci più lavorare. Ogni giorno mi alleno a osservare le sensazioni obbiettivamente e certe volte non riesco a imboccare la via d’uscita. Ma pratico intensamente in quella direzione.
Prima di tutto, pratico diventando consapevole che, sì, questa malattia non è fisicamente piacevole. Poi sposto consciamente la mente a qualsiasi stato sublime funzioni per me in quel momento. Può essere che sia la gentilezza amorevole già descritta in precedenza. O la compassione, ripetendo silenziosamente: “È dura sentire questa nausea. È difficile sentirsi attaccati da un virus misterioso e non riuscire a trovare un trattamento che funzioni“. Spesso, mentre dico queste frasi, mi accarezzo un braccio con l’altra mano, una pratica che ho imparato da Thich Nhat Hanh nel suo libro The Diamond that Cuts Through Illusion. Certe volte la mia mente tende all’equanimità e dico silenziosamente: “È così che va. Il mio corpo è malato. Va bene. È così com’è”. Di recente ho sviluppato la capacità di coltivare la gioia per la gioia degli altri di modo che, sdraiata a letto, sentendo le sensazioni fisiche spiacevoli che accompagnano la malattia, mi sento felice per chi è in buona salute.
Pratico anche la gioia per la gioia degli altri seguendo l’esempio di Sylvia. Quando non posso stare con la famiglia nel soggiorno di casa e lo avverto come una sensazione o una percezione mentale spiacevole, invece di andare verso l’avversione e tutta la sofferenza che inevitabilmente ne consegue, sposto consapevolmente la mente verso mudita, provando gioia che loro possano passare del tempo insieme.
Ho anche usato questa pratica di combinare la consapevolezza della ruota della sofferenza con i quattro stati sublimi per aiutarmi nelle circostanze più difficili. Per esempio, non riuscii a dormire per due giorni e due notti consecutive. Non era insonnia. Il malessere simile a quello influenzale e l’affaticamento oppressivo, col cuore martellante, erano troppo forti perché il corpo potesse addormentarsi, come chiunque abbia un dolore e non possa quindi dormire. Quando una persona sana non dorme per un paio di notti, non si sente bene durante il giorno, ma riesce a funzionare. Io sono appena appena ritemprata quando ho un buon sonno durante la notte, vi lascio quindi immaginare come mi abbatta non dormire affatto.
Durante queste due notti insonni la mia reazione in passato sarebbe stata di passare direttamente dalla sensazione fisica spiacevole all’avversione seguita dall’infelicità. Sarei rimasta sdraiata a letto diventando sempre più frustrata e arrabbiata con il corpo. Questa volta, invece, spostai consapevolmente la mente verso gli stati sublimi.
Alle due del mattino ho invocato la gentilezza amorevole: “Dolce corpo, che stai tentando in tutti i modi di dormire”.
Alle tre la compassione: “È così difficile stare qui a letto con il bisogno di dormire e senza poterlo fare”.
Alle quattro l’equanimità: “Le cose stanno così; il mio corpo ora come ora non riesce a dormire”.
La terza notte mi addormentai.
Sono convinta che usare queste pratiche per impedire alle sensazioni spiacevoli di trasformarsi in avversione ha permesso ai miei sintomi di non aggravarsi ulteriormente e, al loro riacutizzarsi, di poter alla fine passare. Sono molto grata che la combinazione di due pratiche buddhiste mi abbia aiutato durante quel difficile periodo.
![]()
Oh, se la mia tonaca di monaco fosse grande abbastanza da avvolgere tutti quelli che soffrono in questo mondo fluttuante.
RYOKAN
Tonglen è una pratica di compassione della tradizione buddhista tibetana. Ma per me l’essenza del tonglen è nella poesia Zen di Ryokan. Ovviamente, si ispirano entrambi all’esempio del Buddha.
All’inizio della malattia accumulai ben presto una collezione di cd terapeutici di varie tradizioni spirituali. Avevano tutti in comune un’istruzione: inspirare pensieri e immagini di pace e di guarigione ed espirare la sofferenza fisica e mentale. Ma nella pratica di tonglen, l’istruzione è opposta. Inspiriamo la sofferenza del mondo ed espiriamo qualsiasi forma di gentilezza, serenità e compassione abbiamo da offrire. È una pratica anti-istintiva, e per questo la monaca e insegnante buddhista Pema Chödrön afferma che tonglen capovolge la logica dell’ego.
La pratica di tonglen giunse in Tibet dall’India nell’undicesimo secolo come parte di una serie di insegnamenti conosciuti come “I sette punti dell’addestramento mentale”, una raccolta di cinquantanove “massime” per praticare il sentiero della compassione. La pratica di tonglen è descritta nella massima: “Addestrati nel prendere e inviare alternativamente; applicali al respiro”.
Le due frasi...