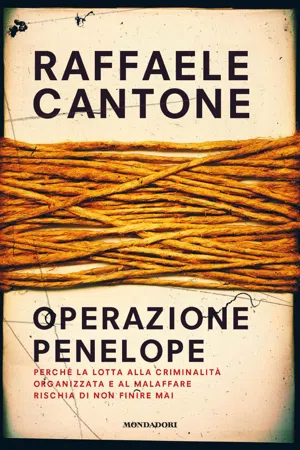![]()
Luci e ombre sull’infinito dramma campano
Le montagne di spazzatura urbana maleodorante, le folle inferocite che protestano per l’apertura di una nuova discarica, i fumi tossici che si sprigionano dai sacchetti dati alle fiamme: sono le immagini scandalose e degradanti dell’emergenza rifiuti in Campania, un disastro che torna ciclicamente a far parlare di sé, e non solo in Italia. Eppure, questo è soltanto l’aspetto più evidente di un dramma che ha ben altre dimensioni economiche e sociali, e che non basta un termovalorizzatore a far scomparire. Per provare a capire tutto ciò, bisogna andare oltre quelle visioni di abbandono, perché dietro i cumuli di «monnezza» c’è un complesso intreccio di interessi, connivenze, inadempienze e moltissimi soldi.
Uno squarcio recente su questo mondo lo ha aperto la prima delle ordinanze cautelari, quella per concorso esterno in associazione mafiosa, che ha colpito l’onorevole Nicola Cosentino. Per mesi i giornali si sono occupati del caso. Nonostante il clima di crescente assuefazione, infatti, non capita tutti i giorni che un deputato, ex sottosegretario e coordinatore di uno dei primi partiti d’Italia, venga accusato di aver favorito il clan dei casalesi. In seguito, come è noto, la richiesta d’arresto nei suoi confronti è stata respinta dalla Camera (e identica sorte ha avuto anche la seconda delle ordinanze in cui era indagato per concorso in riciclaggio per una complessa vicenda relativa all’apertura di un centro commerciale a Casal di Principe). A distanza di mesi, Cosentino si è dimesso prima dal suo incarico governativo e, molto più di recente, da quello di partito. Ma questa vicenda, al di là dei fatti che hanno interessato direttamente un politico così importante, mostra in una nuova prospettiva ciò che è diventato uno dei più grossi affari della criminalità organizzata: appunto, il business dei rifiuti.
L’ordinanza, emessa dal gip presso il tribunale di Napoli Raffaele Piccirillo, infatti, è un documento straordinario e illuminante, che fotografa una complicata trama di interessi, da un lato tra il mondo degli affari e la camorra e dall’altro tra la politica e il mondo degli affari. E non di affari qualsiasi. Al centro di tutto c’è la disperazione di Napoli e dell’intera Campania, lo smaltimento della sua spazzatura, che periodicamente soffoca interi quartieri e ha distrutto l’immagine di tutta la regione nel mondo. Ma che per alcuni, invece, è stata (e forse lo è ancora) un’inesauribile fonte di arricchimento.
Vediamo nel dettaglio che cosa raccontano le indagini. Per quanto riguarda il primo binomio – affari-camorra – l’atto giudiziario illustra il meccanismo con cui una ditta privata riusciva a entrare in società con uno dei disciolti consorzi pubblici per la gestione dei rifiuti, tramite gli stretti legami con un clan camorristico di riferimento, i casalesi. Era grazie ai boss che questa azienda si procurava tutto il necessario per operare in un campo dove non poteva vantare alcuna esperienza. Ed era sempre il clan di riferimento a creare i contatti giusti con alcuni personaggi del settore, a permettere l’acquisto degli autocompattatori (i macchinari necessari allo smaltimento) e a intervenire quando, vinto in modo irregolare l’appalto, occorreva evitare che i concorrenti esclusi impugnassero la delibera di gara. Infine, era ancora il clan che procurava una parte dei dipendenti, stabiliva la quota di tangenti da versare e forniva l’aiuto indispensabile per risolvere imprevisti d’ogni genere, frequenti in un territorio difficile come la provincia di Caserta. È il paradigma dell’impresa che si muove senza il rispetto delle regole della libera concorrenza, sostituendo il know-how tecnico con quello mafioso.
L’altro polo dei rapporti – affari-politica – non è meno preoccupante. Continuando a leggere l’atto giudiziario apprendiamo che la società, a quel punto diventata mista, cioè con partecipazioni pubbliche e private, non era gestita secondo criteri imprenditoriali, ma nemmeno nell’interesse pubblico, bensì assecondando esclusivamente le esigenze degli sponsor politici di riferimento. Questi ultimi si dividevano i posti in consiglio di amministrazione, assegnati non sulla base delle competenze ma per l’appartenenza all’uno o all’altro partito. Sempre i referenti politici, approfittando del proprio ruolo, individuavano ulteriori occasioni di lavoro, decidevano le strategie economiche, intervenivano per superare problemi burocratici e, dulcis in fundo, sceglievano chi assumere, spinti da logiche clientelari finalizzate a ottenere voti e vantaggi personali.
Un quadro sconcertante che si tinge di assurdo quando Piccirillo nella sua ricostruzione spiega che i consorzi per la raccolta dei rifiuti venivano distinti in strutture di centrodestra e di centrosinistra. Come se la spazzatura potesse assumere una colorazione ideologica, a seconda delle esigenze della politica. Ma poiché non c’è fine al ridicolo, il gip racconta anche che si era provveduto a riunire alcuni di questi centri di colore diverso, per creare un superconsorzio «arcobaleno» che avrebbe dovuto assicurare ulteriori prebende e poltrone nei consigli di amministrazione, ma soprattutto una gestione bipartisan del sistema di smaltimento della spazzatura.
Il grande business della «monnezza»
Per comprendere meglio il paradosso della ciclica emergenza che contraddistingue il sistema dei rifiuti in Campania bisogna partire da dove tutto è cominciato. Ovvero da chi avrebbe dovuto occuparsi della raccolta e dello smistamento della spazzatura, un servizio sociale primario e importantissimo in qualsiasi società evoluta. I famigerati consorzi, appunto.
Nel 2008, contemporaneamente alla nomina di Gianni De Gennaro a supercommissario straordinario per l’emergenza, l’allora governo Prodi ne aveva preannunciato lo scioglimento, ritenendoli evidentemente una delle concause della grave situazione che si era creata. Un’operazione che si è rivelata lunghissima e faticosa a causa delle enormi resistenze che ha generato.
Ma che cos’erano, in realtà, i consorzi e, soprattutto, come mai hanno finito per costituire spesso un ostacolo alla missione per cui erano stati creati?
La loro data di nascita è il 1993, quando una legge regionale ne istituì diciotto in tutta la Campania. Questi consorzi, detti «di bacino», riunivano diversi comuni adiacenti e avrebbero dovuto garantire un’ottimale e più razionale gestione dello smaltimento dei rifiuti e della raccolta differenziata, anche sotto il profilo economico.
Mutuando un sistema che aveva avuto successo in altre regioni italiane, venne introdotta la possibilità di creare società miste, pubbliche e private, di modo che il consorzio potesse meglio operare per realizzare i propri obiettivi. Purtroppo, in Campania questa esperienza si è rivelata nella pratica in gran parte dei casi decisamente fallimentare, dimostrando come strutture che in teoria dovrebbero generare una maggiore produttività, una volta operative possono diventare in alcuni casi un esempio di inefficienza.
Nella già citata relazione al Parlamento, la Commissione parlamentare antimafia ha definito i consorzi «impropri ammortizzatori sociali, a causa del pesante fardello di lavoratori non impiegati in alcuna attività connessa al ciclo dei rifiuti». Malgrado il linguaggio burocratico, la sostanza è più che comprensibile.
D’altra parte, diverse inchieste giornalistiche, tra cui un servizio illuminante della trasmissione «Report», hanno documentato come i numerosi dipendenti di quelle strutture passassero la giornata a giocare a carte, pur essendo regolarmente retribuiti, e in che modo generoso fossero pagati i membri dei consigli di amministrazione e i direttori generali. C’è di più: i consorzi avrebbero dovuto occuparsi soprattutto della raccolta differenziata, cosa che non hanno quasi mai fatto. E quando sono state create società miste, come si è visto, sono emerse in diversi casi pesanti infiltrazioni della criminalità organizzata.
Carichi di dipendenti spesso inutili, o comunque a lungo inutilizzati, e dalla fedina penale talvolta poco rassicurante, i consorzi si sono così rivelati inservibili carrozzoni, ma anche serbatoi di voti di scambio nelle mani dei clan, da gestire a favore dei politici locali.
Tutto ciò mentre i rifiuti continuavano ad accumularsi indistintamente, rendendo il loro smaltimento sempre più difficile.
Rifiuti e camorra: quali responsabilità?
Quando si parla di rifiuti in Campania, immediatamente si pensa alla camorra. È un collegamento che ormai viene automatico a molti, primi fra tutti i tanti giornalisti che a ogni crisi si precipitano a Napoli in cerca di spiegazioni nette e definitive per un disastro che invece è terribilmente complesso.
È così che si è formata l’opinione comune secondo cui «la colpa dell’emergenza è della camorra». Una convinzione radicata, che si poggia su due premesse universalmente riconosciute: «la camorra è presente in tutte le fasi del ciclo dei rifiuti» e «la camorra specula sulle emergenze».
Tale analisi, condivisa in buona fede da quanti non conoscono a fondo le vicende napoletane, in realtà sembra fatta apposta per chi non vede l’ora di allontanare da sé lo spettro delle proprie responsabilità. Mai come in questo caso, però, la logica che sta dietro a un simile ragionamento appare errata. Le due premesse sono corrette e l’esito di numerose indagini le hanno confermate, ma è la deduzione finale a essere sbagliata: la camorra non è responsabile dell’emergenza rifiuti. Un’«emergenza», è bene ricordarlo, che dura da circa vent’anni, al punto che definirla in questo modo appare persino grottesco.
Tutto ciò non significa naturalmente che i clan non siano coinvolti in ogni singola fase della gestione della spazzatura. Ovunque ci sia da lucrare, la camorra fa sentire la propria presenza e reclama la sua parte. Ma se c’è riuscita così bene, è anche perché ha potuto approfittare del disinteresse delle istituzioni preposte a controllare. Si è infiltrata attraverso le maglie larghe del sistema dei consorzi, riuscendo spesso a diventare il partner privato delle società miste, grazie alla connivenza di quelle stesse strutture che in molte occasioni hanno indetto bandi di gara «su misura», guarda caso, per le imprese dei clan.
Sono state proprio le organizzazioni criminali più strutturate a fiutare il grosso business della spazzatura, investendo in quel settore parte delle proprie risorse. Hanno iniziato con la gestione dei rifiuti illegali, favorite da una burocrazia lenta e corrotta che fingeva di non vedere i cumuli di materiali tossici e inquinanti abbandonati nei terreni incolti, nelle cave dismesse o nelle vasche teoricamente destinate a improbabili attività di itticoltura. E presto i clan sono passati ad agire alla luce del sole, con la gestione delle imprese incaricate della raccolta dei rifiuti urbani.
Il ciclico verificarsi di situazioni «straordinarie» – le discariche si esauriscono in quanto stracolme e gli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (il cosiddetto Cdr) non funzionano perché sommersi di «ecoballe», ammassi di spazzatura ibrida e potenzialmente tossica – ha imposto via via soluzioni tampone, offerte in molti casi su un piatto d’argento proprio dai clan.
Due esempi fra i tanti possono servire a dare il quadro della situazione. Il primo riguarda il trasporto dei rifiuti in siti di stoccaggio provvisori. Gestito in modo informale e senza gare d’appalto, è finito preda della camorra che vi ha convogliato i propri mezzi o quelli di padroncini «amici», gli stessi utilizzati nel settore del movimento terra, da sempre un suo monopolio.
Il secondo esempio riguarda l’aspetto più eclatante di tutta la vicenda: l’individuazione di tali siti. Molto spesso, infatti, i clan o i loro affiliati si sono procurati terreni a prezzi irrisori per poi affittarli con canoni almeno dieci volte superiori. Un plusvalore impressionante che pare voler retribuire anche la capacità di queste organizzazioni di evitare eventuali proteste da parte dei residenti. Sia la Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti, sia la Commissione parlamentare antimafia in alcune recenti relazioni hanno ricordato come i depositi di «ecoballe», che si estendono in alcune zone per chilometri e chilometri a perdita d’occhio, siano sorti senza che gli abitanti del luogo avanzassero una timida obiezione né tantomeno una pubblica protesta.
Questi «servigi» a quanto pare sono risultati molto utili a chi, avendone la facoltà, non si è mai preoccupato di risolvere strutturalmente la gestione dello smaltimento dei rifiuti in Campania. Al contrario, non pochi responsabili delle amministrazioni locali si ostinano ad affermare, seguendo una vera e propria strategia di disinformazione, che l’emergenza sarebbe stata creata ad arte appunto dalla camorra, quella stessa camorra che in passato buona parte di loro aveva liquidato come un inoffensivo fenomeno folcloristico. E intanto, la medesima classe dirigente non si faceva scrupolo di attingere a piene mani al fiume di denaro giunto a Napoli, affidando consulenze spesso incredibili e regolarizzando precari nei vari consorzi con assunzioni clientelari in vista delle elezioni. È possibile che nessuno di loro si fosse accorto che intanto la camorra si stava infiltrando nel grande business della «monnezza»?
Eppure, alcune verità erano emerse in modo inconfutabile dalle indagini della procura di Napoli. Queste ultime, infatti, avevano portato all’arresto del presidente di un consorzio di comuni della provincia di Caserta e di alcuni imprenditori soci di quella stessa società, che secondo diversi pentiti erano legati al clan dei casalesi. Quel consorzio era una società mista e non si occupava solo di raccogliere e smaltire i rifiuti, ma anche di reperire siti di stoccaggio provvisorio e di far fronte a qualsiasi emergenza in cambio di modiche spese aggiuntive. Per garantirsi il lavoro, versava al clan che operava in uno dei comuni di competenza 15 mila euro ogni mese. Non solo, aveva tra i dipendenti il figlio del boss locale che, oltre a svolgere le funzioni di sorvegliante, si occupava di consegnare al proprio gruppo camorristico la mazzetta.
I fatti dimostrano, quindi, che i clan erano presenti – e probabilmente lo sono ancora – in tutte le fasi del ciclo dei rifiuti. Ma anche la premessa «la camorra specula sulle emergenze» è stata comprovata da numerose indagini, nell’indifferenza delle istituzioni locali. Se tutto ciò è vero, dunque, appare assolutamente falso che sia la stessa camorra a creare l’emergenza. Tanto più che i clan hanno pesantemente speculato anche su altri e più gravi eventi drammatici come terremoti, frane e alluvioni, ma non per questo si può arrivare a dire che ne siano stati la causa!
Tra l’altro, soprattutto le organizzazioni più strutturate non hanno alcun interesse ad attirare i riflettori dei media sui propri affari milionari. Il loro ruolo è un altro: più semplicemente approfittano della situazione.
È dunque ora di abbandonare alibi posticci e di individuare invece le vere responsabilità. Il profumo di soldi che il sistema campano dei rifiuti emana ha attratto diversi interessi, che si sono via via aggiunti, connessi e sovrapposti a quelli della camorra.
Quante poltrone in consigli di amministrazione di consorzi, società municipalizzate e miste sono state assegnate a persone che non avevano alcuna competenza ma che potevano esibire la tessera di un partito? Quanti posti di lavoro sono stati distribuiti alla vigilia delle consultazioni elettorali, trasformando quegli stessi consorzi in scialuppe assistenziali, dove la raccolta dei rifiuti era solo un’attività marginale?
Sono queste le domande che dobbiamo porci, se vogliamo davvero capire le ragioni di un disastro che non ha ancora finito di fare danni.
Servizi segreti, discariche e boss:
i misteri del delitto Orsi
Come in ogni scandalo italiano che si rispetti, anche in quello della gestione dei rifiuti in Campania a un certo punto sembrano entrare in gioco i Servizi segreti. È un colpo di scena in realtà già emerso da tempo, ma su cui non si è ancora fatta del tutto chiarezza. Prendiamo le indagini sulle infiltrazioni del clan dei casalesi nel periodo tra il 2003 e il 2005.
In quel periodo la gestione del Commissariato per i rifiuti era appena passata dalla regione al diretto controllo del governo, con la nomina a commissario del prefetto Corrado Catenacci, cui sarebbe seguito Guido Bertolaso e via di seguito i vari altri incaricati. Ebbene, l’allora subcommissario Giulio Facchi ha raccontato ai pm della Direzione distrettuale antimafia di Napoli che in quella fase fu avvicinato in più occasioni da uomini dei Servizi segreti. E aggiunse che uno di loro, che fra l’altro lavorava in un consorzio, era stato assunto come dipendente all’interno del Commissariato per i rifiuti.
Poco tempo dopo lo stesso Facchi, facendo firmare una delibera a un «ignaro» presidente della regione, creava un superconsorzio chiamato Impregeco, che univa più strutture vicine sia a partiti del centrodestra (della provincia di Caserta) sia a formazioni del centrosinistra (di quella di Napoli). Proprio il superconsorzio «arcobaleno» di cui a lungo tratta l’ordinanza cautelare emessa contro l’onorevole Cosentino: una struttura che stabiliva vincoli e rapporti trasversali tra mondi culturalmente e politicamente lontani e che nell’idea dei suoi promotori avrebbe dovuto persino sostituire il Commissariato per i rifiuti nella gestione dell’emergenza.
Sempre in quel periodo, i fratelli Orsi, imprenditori di Casal di Principe provenienti dal settore delle costruzioni, si erano fatti largo anche in quello dei rifiuti. Alcuni anni prima avevano vinto in modo rocambolesco la gara per la gestione della società mista collegata al più importante consorzio casertano e si apprestavano a fare un ulteriore salto di qualità. Ritenuti vicini al clan dei casalesi, avevano dimostrato di sapersi muovere molto bene nel mondo paludoso della politica campana. Sostenevano economicamente e attraverso l’elargizione di posti di lavoro i partiti del centrodestra, ma non si facevano problemi a iscriversi a un partito di sinistra, se ciò poteva essere loro utile. Lo fecero, per esempio, in un comune del Casertano, Orta di Atella, il cui sindaco venne votato con percentuali bulgare molto vicine al 90 per cento. Quello stesso sindaco, in seguito, fu eletto in consiglio regionale, ma venne arrestato per corruzione e il consiglio comunale fu sciolto per infiltrazioni mafiose. In tempi recenti, però, è stato rieletto alla carica più alta del comune con un diverso partito ed è diventato anche consigliere provinciale di Caserta in appoggio al presidente, votato dal centrodestra.
Dalle indagini era anche emerso che i fratelli Orsi avevano brigato per inserire un proprio uomo nell’organigramma del Commissariato per i rifiuti, grazie ai loro rapporti con ambienti istituzionali insospettabili. Questo soggetto, malgrado nel corso degli anni sia stato più volte coinvolto in indagini, ha fatto poi una rapida carriera nel mondo dorato della protezione civile.
In quella fase, attraverso la Fibe, la società che gestisce la nettezza urbana di Napoli, il Commissariato per i rifiuti aveva affittato decine di terreni vicino a Casal di Principe per sistemare le famose «ecoballe». Il fatto è risaputo: il costo della locazione si rivelò di molto superiore al reale valore di quei siti. Inoltre, secondo quanto emerso da indagini riportate sui quotidiani cittadini, quei terreni, scelti senza il rispetto delle regole sui contratti pubblici, appartenevano a personaggi legati ancora una volta ai casalesi; ...