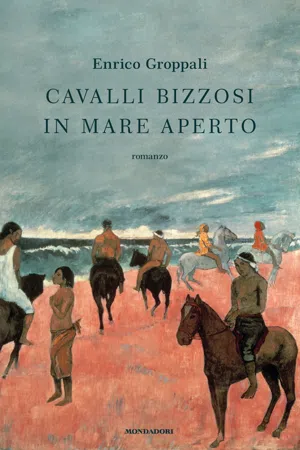![]()
Enrico Groppali
CAVALLI BIZZOSI
IN MARE APERTO
Romanzo
![]()
Questo romanzo è frutto dell’immaginazione. Gli eventi storici e i personaggi realmente esistenti o esistiti sono trasfigurati dalla lente deformante dell’autore. Per il resto, ogni riferimento a persone e fatti reali è da ritenersi casuale.
![]()
a Francesca Benedetti,
Alvia Reale,
Eva Robin’s,
Anita Bartolucci,
Gianna Giachetti,
Pamela Villoresi,
Elisabetta Pozzi,
Sabrina Colle,
Mascia Musy
le buone fate
del teatro italiano
![]()
![]()
«Non so cosa mi sia accaduto. È la verità. Non so proprio cosa mi sia accaduto!»
Gli inquirenti mi guardavano incuriositi. Non so se credessero alle mie parole o se invece fossero attratti dalle linee armoniose del mio volto, dalla curva ad arco delle mie labbra, dai miei occhi azzurri che tenevo pudicamente abbassati.
Di una cosa comunque ero certa. Il tribunale era un palcoscenico e io, l’imputata, stavo solo recitando il ruolo della vittima di circostanze avverse. Non era più il luogo in cui si amministra la giustizia, la cittadella fatta di inferriate create dall’uomo in eterna lotta contro l’uomo.
Ma forse era solo una patetica invenzione della mia mente. La mente di chi teme il castigo che gli sarà comminato e spera di allontanarlo immaginando che la sua tragedia sia condivisa dall’invisibile spettatore che, dalle tribune, lo ascolta e lo guarda.
Adesso anche il brusio compiacente fatto di mille sospiri repressi non c’era più. Il silenzio che ora mi circondava era un’impenetrabile cortina che eliminava la presenza di qualsiasi rumore. E quindi mi autorizzava a pensare che fossi sola. Ero sola a recitare il monologo che stavo improvvisando davanti a quegli sconosciuti.
Avrei preferito di gran lunga sentire il fiato dei domatori che annusano la preda sorvegliando il suo passo, condizionando i suoi gesti con la lenta rotazione delle pupille. Invece accanto a me, davanti a me, c’era il nulla.
Era questa, in fondo, la giustizia. Appurare se una data azione è stata compiuta o, al contrario, è stata solo sognata. Come se non ci fosse differenza tra l’una e l’altra possibilità. Che invece possono convivere tranquillamente in eterno. Come accade nella beata condizione di straniamento che si chiama sonno.
Questo volevo spiegare a quegli uomini, senza riuscirci. Il pensiero mi sfuggiva non appena tentavo di mettere in fila le parole adatte a formare il concetto che nel mio spirito leggevo con tanta chiarezza.
Forse mi ero sbagliata. Certo, doveva proprio essere andata così. Evidentemente qualcuno nell’ombra mi ascoltava, qualcuno dubitava di me e io non me n’ero accorta.
C’era il sole quel giorno, un bel sole primaverile che, sugli scranni occupati dai miei giudici, li ritagliava nitidi nell’aria spessa del pomeriggio. Li sentivo bisbigliare animatamente.
Era quello il mio pubblico. Che mi ascoltava compiacente con la degnazione assurda e ridicola tipica di chi non ha bisogno della deposizione dell’imputato per emettere la sentenza.
In fondo ero già stata condannata ancor prima di comparire davanti alla corte.
![]()
Mi si voleva forse negare la confessione, l’estrema possibilità consentita al colpevole? Era questa la punizione che mi avevano assegnato? Quella di non credere alla sola eccezione che potessi invocare?
Cominciai a mettere in discussione la strategia cui volevo attenermi. E finii per ammettere che spiegarsi era inutile. Parlavamo due lingue diverse. Loro facevano parte del gruppo degli umani, io di una specie non catalogabile.
Quella di chi recita nel corso dei dodici mesi che compongono l’anno tre o quattro ruoli diversi, finendo per appartenere a discorsi o a parole che mai avrei pronunciato nel corso della vita quotidiana.
Che invece nella finzione della scena, dove ogni inflessione è frutto di un paziente lavoro d’indagine, era l’unica scelta che mi fosse permessa. A scapito del mio vero io, che solo a tratti emergeva dal profondo del mio essere. Rendendo uguali e simmetrici i due emisferi che ci compongono: il cielo e l’inferno, il santo condotto al rogo e il giudice che gli ha comminato la pena.
La collettività di cui facevo parte in quanto creatura vivente era destinata a ignorarlo per sempre. Loro, i giudici, si occupano soltanto della sentenza. Qualsiasi sentenza. Quella che formulano col pensiero quando leggono di un caso stampato sui giornali. Quella che vagliano negli incartamenti. Quella che confezionano componendo l’affresco dei moventi, delle aggravanti e delle attenuanti.
Per ciò che in quel momento mi riguardava, di una sola cosa ero sicura: dubitavano di tutto ma non della mia persona. Del mio corpo, della mia voce, del mio sguardo. Anche se tenevo gli occhi bassi, sapevo che mi giudicavano, sapevo che avvertivano la tensione da cui ero pervasa, sapevo che la mia immagine non li lasciava indifferenti.
Perché io, Anna de Roberti, di professione attrice, a quarant’anni destavo ancora sensazione. Colpa del mio corpo snello, dei capelli che dal collo mi scendevano come una carezza lungo le spalle.
Colpa dell’inspiegabile timidezza che dopo tanti anni mi coglieva sempre attendendomi al varco, imprigionandomi nella trappola di un personaggio estraneo che mi soggiogava piegandomi al suo volere.
Sia quando in scena articolavo le prime battute sottovoce per giustificare la mia presenza. Sia nella vita, quando davanti ai giornalisti ero costretta a presentare quel lusinghiero ritratto di me stessa che mi ero imposta da anni.
Sia nei rari momenti d’abbandono, quando, tornata alla realtà dei fatti, a tu per tu con l’uomo di cui ero innamorata, mi accorgevo tremando di essere tradita dalle parole, dai gesti, dalle azioni che mi erano abituali e che inconsciamente ripetevo con lui.
Ero soltanto un’attrice che non riusciva mai, nonostante la tecnica acquisita, a liberarsi dalle scorie del mestiere.
Quando, spogliata dei miei personaggi, credevo di aver ritrovato quella parte di noi che non ci abbandona mai, il timore degli altri, la paura di non essere compresa, la sensazione che, se non avessi severamente controllato ogni respiro, sarei stata fraintesa, condannata, derisa mi spingeva a rifugiarmi nel ruolo orgoglioso e sprezzante di chi si sente invulnerabile.
Nel contempo mi sentivo protetta dal mio corpo, da quella corazza che neppure la morte è in grado di sciogliere quando ci consegna, irrigiditi dalla sua gelida morsa, a contatto con la terra che ci ha generato.
Anche quella volta mi ero comportata così. Tentando di spiegare cos’era successo quando, nella scena più commovente dell’Impresario delle Smirne di Goldoni, Lucrezia, la povera comica che crede di ritagliarsi un posto al sole in Oriente, dopo essersi esibita davanti al ricco mercante Alì che intende scritturare la compagnia di guitti di cui fa parte, abbraccia in un empito fraterno il più timido dei suoi colleghi.
Non doveva essere un amplesso ma un bacio affettuoso tra consanguinei, il timido contatto delle nostre labbra. E invece... Invece era accaduto l’irreparabile. Ma cosa significa irreparabile se non qualcosa che ci inibisce di tornare al primitivo stato di innocenza?
Ma nel mio caso cosa avevo fatto di irreparabile?
Irreparabile, si sa, è un aggettivo che si applica a un delitto, non a un abbraccio. Avevamo provato tante volte quella scena e non era accaduto nulla che potesse giustificare una condanna. Anche se, quella volta, mi ero stretta a quel ragazzo in modo frenetico e inconsulto.
Poi le mie dita gli avevano stracciato la camicia, le mie unghie gli si erano conficcate nella schiena e la mia voce quella sera era cambiata. Assumendo un tono fremente e concitato mentre stringevo, tentando di infondergli la vita, il corpo inerte di quel ragazzo che cercava di liberarsi dalla stretta feroce dei miei artigli.
Non era accaduto altro. Solo la sua pelle delicata era rimasta straziata dalle mie unghie, che gli avevano lasciato un arabesco di sangue. Tanto era bastato a quel pubblico di provinciali per scandalizzarsi urlando all’oltraggio al pudore, chiedendo a gran voce che la rappresentazione fosse sospesa, sollecitando addirittura l’intervento della forza pubblica.
Adesso, mentre tentavo di spiegare come si erano svolti i fatti, tutto ciò che avevo concordato col mio legale si disfaceva in un turbine di sensazioni che non avevo mai provato.
Rivedevo quella scena come una spettatrice e i fatti si alteravano, mi abbandonavano, si rifugiavano altrove. Non appartenevano più al gesto che avevo compiuto, riguardavano un’altra donna, una storia che non conoscevo, un avvenimento che non mi competeva né punto né poco.
«Ed è proprio per questo» riuscii a esclamare «che per tutta quella sera, signor giudice, ho sentito un’altra donna parlare. Tanto che dopo non so davvero cosa mi sia accaduto!»
D’improvviso, dopo la mia insolita dichiarazione, nell’aula piombò un gran silenzio. L’aria si poteva tagliare col coltello. Tutto ai miei occhi si confondeva. Poiché la donna che sulla scena si era impadronita del mio corpo non si era abbandonata a nessun gesto osceno.
Aveva solo cercato di entrare in una spelonca per fuggire dal mondo e, non avendo trovato un luogo dove nascondersi, si era aggrappata all’unico uomo che le aveva sbarrato il cammino.
«Altro dirle non so, mi creda, signor giudice. Altro davvero non so!» dissi chinando il capo, e fu allora che le lacrime mi sgorgarono dagli occhi.
Un effetto magistrale che a teatro non mi era mai riuscito. Quando sulla scena dovevo mostrarmi addolorata, vinta dalle circostanze, in preda a un’angoscia che non aveva fine io, non sapendo che fare, rimanevo assente come se il mio corpo non esistesse più. Stavo lì come una fragile creatura di sabbia che il primo refolo di vento era in grado di disperdere.
Quello, e non altro, era il gesto che mi veniva in aiuto per sconvolgere i miei tratti e offrire, a chi mi vedeva, lo spettacolo di un corpo che, per virtù propria, sussultando si disfaceva.
Invece quel pianto liberatorio fece di me un’eroina. Una recita, la mia, che convinse la corte a prosciogliermi per non aver commesso il fatto.
Uscii dal tribunale con fierezza. Non solo avevo vinto, ma mi ero conquistata un’enorme pubblicità. Adesso tutti mi chiedevano di riprendere lo spettacolo, i critici parlavano della mia arte, chiedendomi scusa per aver talvolta pensato che abusassi delle mie capacità per dimostrare un eccesso di doti. Ma queste lodi immeritate non mi convincevano. Anzi, mi davano fastidio. Tanto da spingermi a chiedere requie, riposo, silenzio.
L’immagine che mi tormentava di più era sempre la stessa: la facciata del teatro Argentina. Dove sostavo, frastornata dal traffico delle quattro del pomeriggio di una bella giornata di aprile. Quel giorno il teatro era ancora chiuso. Sembrava una cattedrale in sfacelo.
Solo dai vetri palpitava una luce fioca. Ma forse non era nemmeno una luce, erano i raggi cocenti del sole a produrre quell’effetto allucinatorio. Venivano, quei raggi, dall’interno, e adesso gettandosi sulle locandine affisse all’esterno le stavano bruciando come se fossero dei carboni ardenti.
Ma quelle, me ne accorsi ben presto, non erano locandine. Erano soltanto dei fogli di protocollo listati a lutto dove c’era scritto: «Chiuso per ordine della forza pubblica».
In quel momento, nonostante fossi stata prosciolta con formula piena, compresi che la mia carriera era finita. Anche se tutti, al contrario, mi esortavano a riprenderla come se non fosse successo nulla. Ma non era vero. Lo testimoniava la luce giunta dal fondo di quell’antro oscuro che fino a ieri, per me, si chiamava teatro.
Avevo sfidato, senza accorgermene, il demone che giace in fondo alle cattedrali, quello che ci spinge a pregare in silenzio e, subito dopo, ad articolare ad alta voce i nostri pensieri.
Ecco, adesso quel luogo mi aveva respinta. Mi ordinava di allontanarmi. E io non potevo che sottomettermi al suo potere. L’unico in grado di emettere la sentenza che competeva ad Anna de Roberti: l’esilio.
![]()
Qualche giorno dopo decisi di partire.
Quella notte, invece di coricarmi, cominciai a preparare diligentemente i bagagli. Ero rientrata a casa mentre l’orologio a pendolo dell’ingresso batteva la mezzanotte e, quando fui sicura di non aver trascurato lo stretto necessario, la luce dell’alba penetrava già attraverso le veneziane bianche, facendo impallidire il bagliore delle candele che usavo al posto dell’elettricità.
Che senso aveva ormai mettersi a letto? Prima delle sei ero già pronta. Avevo indossato un tailleur di velluto nero, e mi ero messa in testa un cappello di feltro. Ma alla fine, pensando che era ancora troppo presto per uscire, sprofondai in una poltrona lasciandomi scivolare il soprabito dalle spalle.
Misi sul giradischi l’unica musica che in quel periodo riuscivo a sopportare, il Requiem tedesco di Brahms. Poi, con un gesto meccanico, feci volar via le scarpe dai tacchi troppo alti che cominciavano a farmi male e che adesso giacevano sul tappeto.
In mano tenevo un bicchiere di bourbon. Lo bevevo a piccoli sorsi con lo sguardo fisso sulla borsetta aperta che tenevo sulle ginocchia. Solo allora m’accorsi allarmata che una delle mie calze aveva una smagliatura simile a una cicatrice. Decisi di non porvi rimedio. E prima di andare in bagno a ripassarmi con degnazione il rossetto sulle labbra mi accesi l’ultima sigaretta.
Non riuscivo nemmeno a concepire di poter fare qualcosa di diverso. Mi allontanavo volutamente da Roma e dal mio amato palcoscenico. Avevo scritto al mio compagno e a tutti i miei amici che, per ritrovare me stessa, dovevo andare in un luogo appartato dove nessuna voce estranea mi avrebbe raggiunto.
Ma presto compresi che avevo approntato quella fuga come in passato mi preparavo a una recita. Una cosa priva di senso, ora lo capivo. Stavo solo cambiando palcoscenico. Ma al tempo stesso credevo, ripudiando la mia identità, di ritrovare finalmente la pace.
Nel corso del viaggio cambiai acconciatura, mi schiarii i capelli, mi avvolsi in una tunica bianca e azzurra per nascondere il mio corpo appariscente e, al posto delle calzature, mi infilai dei sandali da anacoreta. Avevo cosparso il viso di un trucco scarno, timorosa di sporcare con l’artificio l’assoluta trasparenza del nuovo personaggio in cui volevo calarmi.
Mi diressi verso nord, in Piemonte. A Luserna San Giovanni, un posto di poche anime, sede di una comunità valdese che, come una pianta velenosa, spiccava orgogliosa tra le case di antica fede cattolica. Lì mi calai risoluta nel mio ruolo di catecumena solitaria. Facevo beneficenza con pudore e con pudore la sera tentavo con tutte le mie forze di sorprendere la voce del mio spirito.
Quello spirito che, fino a quel momento, avevo annegato in fiumi di parole che non mi appartenevano più. Credevo di aver conquistato la pace della contemplazione, quella che non avevo mai cercato. E che, strano a dirsi, per tanto tempo mi ero illusa di aver trovato nei copioni, nei libri, negli appunti che prendevo con scrupolo per mutarli il giorno dopo in spettacolo.
Adesso ero certa di aver scoperto nell’isolamento il mio vero io, che fino a quel momento avevo regalato alla massa indistinta del pubblico. Ma presto scoprii con orrore che mi ero soltanto sottoposta a un altro demone. Al posto di un nuovo copione da studiare, avevo costretto la mia vita a scomparire in una foresta di nuove voci e di nuove insinuazioni.
Invece delle battute che, sdegnosa, avevo espulso dal mio copione, mi ero impadronita di colori puri e suoni inarticolati. Il mio era un teatro immobile, fatto di barbagli di luce e di cupi venti notturni. Caddi allora in uno stato di vacua disperazione. Come potevo emergere dal pantano in cui mi ero cacciata?
Forse l’unico mezzo che avevo a disposizione era ritirarmi in me stessa, in assoluta solitudine. Per questo mi diressi ancora più a nord, verso un paese di cui ignoravo la lingua, dove per farmi capire dovevo imparare nuovi suoni, dove la disciplina dell’introspezione mi avrebbe aiutata a rinascere.
Avevo freddo, tanto freddo. Quando aprivo le labbra ed esalavo un respiro mi pareva di sentire il sapore dell’aria gelida sulla lingua come un pezzo di ghiaccio, davanti a quel cielo opaco gravido di nuvole grigie che vagavano intorno simili ad ali di uccelli stanchi.
Nonostante ciò mi rifugiai fuori dall’abitato, in cima ai monti, in quella vasta isola remota dove si ha l’impressione di essere usciti dal mondo. Dove non la mente ma il sangue ci avverte c...