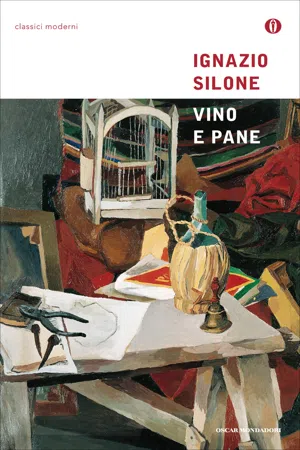![]()
![]()
Non è caso eccezionale che uno scrittore veda una persona sconosciuta intenta a leggere un proprio libro; eppure un fatto del genere, occorsomi molti anni fa, mi fece un’impressione che ricordo ancora, forse per il concorso di circostanze di cui non mi resi subito conto.
Mi trovavo in treno, fra Zurigo e Lugano, in uno scompartimento deserto. A una stazione intermedia salì una donna anziana, modestamente vestita, che dopo avermi salutato con un breve cenno della testa, prese posto accanto al finestrino, davanti a me. Appena seduta, ella trasse dalla borsa da viaggio un libro e l’aprì alla pagina segnata da un sottile nastrino. Per mio conto avevo ancora da guardare alcuni giornali e riviste e non le prestai altra attenzione; ma, dopo un po’, il mio sguardo fu attirato dalla copertina a colori del libro che la donna leggeva e mi accorsi che si trattava dell’edizione tedesca di un mio romanzo uscito un paio d’anni prima, Brot und Wein. Allora misi da parte giornali e riviste e cominciai a osservare, incuriosito, la donna che mi sedeva di fronte.
Ella era vestita e pettinata con molta semplicità, senza ornamento alcuno sulla persona, come da quelle parti si usa ancora in campagna, in ispecie nei cantoni protestanti. Malgrado i capelli grigi, il suo colorito era roseo e i suoi lineamenti erano rimasti regolari e fini; l’espressione del suo viso era intelligente aperta simpatica; in gioventù ella era stata certamente bella. Immaginai che potesse essere una maestra di scuola in pensione o la moglie di un medico; con molte probabilità era una donna forte ed equilibrata non risparmiata però dalle sofferenze.
Col pretesto di riporre un paio di riviste sul portabagagli, mi alzai per verificare a qual punto del romanzo ella fosse arrivata. Era un capitolo che mi era rimasto bene in mente, perché mi era costato non poca fatica. Da quel momento, pur facendo finta di continuare a guardare un giornale, mi posi a seguire mentalmente, pagina per pagina, direi quasi linea per linea, la lettura della sconosciuta.
Il suo viso era apparentemente impassibile; solo un paio di volte ella chiuse gli occhi durante qualche istante, per poi riprendere a leggere. Provavo un’impressione curiosa; ero di fronte a una persona sconosciuta alla quale stavo raccontando in segreto una lunga storia. Fortunatamente quella edizione del mio romanzo non recava la fotografia dell’autore; se quella donna mi avesse riconosciuto, sarei rimasto imbarazzato non poco. Infatti uno strano disagio si stava insinuando nella mia mente. La pagina che la donna leggeva non mi soddisfaceva affatto, anzi, in quel momento, mi sembrava addirittura sciocca. Perché l’avevo scritta? Se avessi potuto prevedere che una persona simile avrebbe letto il mio libro, pensavo tra me, avrei certamente tolto quella pagina, ne avrei tralasciato anche altre e avrei riflettuto di più su certe espressioni. Perché nello scrivere un libro, mi domandavo, la maggior parte degli scrittori pensa il più sovente ai colleghi e ai critici, che leggono un centinaio di libri all’anno, e non agli sconosciuti per i quali il libro può avere un’importanza personale?
Forse non avevo mai sentito, in un modo così preciso e diretto, il privilegio e la responsabilità del mestiere di scrivere, benché, posso dirlo, non fossero sentimenti nuovi per me. Mi tornò alla memoria l’imbarazzo in cui mi aveva gettato, un anno prima, la lettera di un operaio italiano, a nome di un gruppo di suoi compagni di lavoro, come lui emigrati in Svizzera. Essi stavano discutendo una certa frase d’un mio libro e, non essendo d’accordo sul modo d’intenderla, avevano deciso di rivolgersi all’autore. Ma io avevo scritto quella frase del tutto distrattamente...
La donna scese dal treno prima di me, ed io continuai per il resto del viaggio a pensare alla grande dignità e potenza della letteratura e all’indegnità della maggior parte degli scrittori, me compreso. Comunque, da quell’incontro data il mio proposito di rileggere Pane e vino con spirito critico.
L’avevo scritto, ex abundantia cordis, subito dopo l’occupazione fascista dell’Abissinia e durante i grandi processi di Mosca inscenati da Stalin per distruggere gli ultimi residui dell’opposizione. Era difficile immaginare una coincidenza più deprimente di eventi negativi. Il comportamento inumano del generale Graziani verso i combattenti e i civili etiopici, l’euforia di molti italiani per la conquista dell’Impero, la passività della maggioranza della popolazione, l’impotenza degli antifascisti, erano notizie che mi riempivano di un profondo senso di vergogna. A esso si aggiungeva l’orrore e il disgusto per aver servito durante gli anni della gioventù un ideale rivoluzionario che nella sua forma staliniana si stava rivelando, come allora lo definii, nient’altro che “fascismo rosso”. Pertanto, il mio stato d’animo era più proclive all’enfasi, al sarcasmo, al melodramma che a una pacata narrazione. Devo aggiungere che l’eccezionale, e per me del tutto imprevisto, successo del libro, m’illudeva mediocremente, sapendo che alla fortuna d’uno scritto possono contribuire talvolta più i difetti che i pregi. Ma avevo il diritto di tornarvi sopra e di correggerlo? Benché non mancassero esempi, anche illustri, in senso favorevole, io ero allora propenso a ritenere che un libro, una volta edito, non appartenga più all’autore, ma al pubblico.
Il quesito tuttavia mi si sarebbe ripresentato più tardi sotto altra luce, poiché, dopo la caduta del fascismo, i miei libri si sarebbero potuti stampare per la prima volta anche in Italia. Avrei dovuto lasciarmi sfuggire quella possibilità offertami da un ritardo che, sotto tutti gli altri aspetti, era stato per me penoso e pregiudizievole? Con buona coscienza dunque me ne giovai per una messa a punto dei libri da me pubblicati in esilio, Fontamara, Pane e vino, Il seme sotto la neve.
Come la critica ha potuto constatare, questi libri sono rimasti immutati nella loro struttura, nella loro sostanza morale, nella vicenda dei personaggi e nello stile; ma sono stati sfrondati di elementi secondari o d’ispirazione contingente e approfonditi nel loro tema fondamentale. Nessuna vanità può trattenermi dall’ammettere di aver fatto un’esperienza la quale conferma l’analogia tra lo scrivere e le altre arti, nel senso che anch’esso si impara e si perfeziona con l’esercizio.
In proposito ho anche avuto occasione di confessare che, se dipendesse da me, passerei volentieri la mia vita a scrivere e riscrivere lo stesso libro: quell’unico libro che ogni scrittore porta in sé, immagine della propria anima, e di cui le opere pubblicate non sono che frammenti più o meno approssimativi.
Devo ora specificare che cosa mi sembra di avere imparato? In primo luogo, che lo scrittore ispirato da un forte senso di responsabilità sociale è più di ogni altro esposto alla tentazione dell’enfasi, del teatrale, del romanzesco, e alla descrizione puramente esteriore delle cose e dei fatti, mentre quello che solo conta in ogni opera letteraria sono ovviamente le vicende della vita interiore dei personaggi. Anche il paesaggio e gli altri oggetti tra cui l’uomo si muove, meritano di essere menzionati solo nella misura in cui partecipano alla vita del suo spirito. E dato che il patetico non può essere espulso dalla vita umana, per renderlo sopportabile mi pare che sia sempre utile accompagnarlo con un po’ d’ironia.
Col passare degli anni è anche cresciuta in me la ripugnanza per ogni forma di propaganda. Di tutte le chiacchiere scritte sul cosiddetto “impegno” degli artisti che cosa rimane? Il solo “impegno” degno di rispetto è quello che risponde a una vocazione personale. D’altronde, è risaputo che non si può sacrificare all’efficacia la dignità dell’arte, senza sacrificare anche l’efficacia. In quanto allo stile, mi pare che la suprema saggezza nel raccontare sia di cercare di essere semplice.
Se mi sono astenuto dal fare la minima concessione alle mode letterarie sorte nel frattempo e già in via di esaurimento, non è per partito preso. Considero sciocco misurare la modernità di uno scrittore dagli espedienti tecnici di cui si serve. Credere che si possa rinnovare la letteratura con artifizi formali è antica illusione di retori. Con ripugnanza anche maggiore giudico la moda per le descrizioni erotiche a cui si dedicano, assieme a molti mestieranti attirati dal cattivo gusto del pubblico, anche scrittori di talento. A mio avviso non c’è nulla di più falso che giustificare la commercializzazione letteraria dell’erotismo in nome della libertà, pur essendo persuaso che essa non possa essere efficacemente combattuta dalla censura o da altri espedienti burocratici, ma dal disgusto che nasce da un senso serio e profondo della vita.
![]()
Il vecchio don Benedetto leggeva il breviario seduto sul muricciolo dell’orto, all’ombra del cipresso. Sul basso muricciolo che gli serviva da panca, il nero del suo abito talare assorbiva e prolungava l’ombra dell’albero. Dietro di lui la sorella tesseva al telaio, impiantato tra una siepe di bosso e un’aiuola di rosmarino, e la navetta saltava tra l’ordito di lana rossa e nera, da sinistra a destra e da destra a sinistra, accompagnata dal ritmo del pedale che sollevava i licci e del pettine che batteva la trama.
A un certo momento la sorella del prete interruppe il lavoro per osservare con malcelata ansietà un veicolo fermo ai piedi della collina. Delusa, ella riprese a tessere. Era un carro di campagna, tirato da buoi.
«Vedrai, non tarderanno» disse al fratello.
Egli alzò le spalle, fingendo noncuranza.
A destra si trovavano la strada ferrata e la via Valeria che, tra campi di fieno, di grano, di patate, di bietole, di fagioli, di granturco, portava ad Avezzano, si arrampicava fino a Colli di Monte Bove, scendeva a Tivoli e infine, come ogni fiume che sfocia in mare, conduceva a Roma; a sinistra, tra i vigneti, i piselli, le cipolle, c’era la via provinciale che si inerpicava subito tra le montagne e s’addentrava nel cuore dell’Abruzzo, nella regione dei faggi, dei lecci e dei superstiti orsi, conducendo a Pescasseroli, a Opi, a Castel di Sangro.
La sorella del prete spingeva a destra e a sinistra la navetta, senza perdere di vista le strade della valle. Ma quello che vedeva, erano persone e cose d’ogni giorno, non ciò che aspettava.
Per la stradetta provinciale, sassosa e tortuosa come il letto di un torrente inaridito, si fece avanti una giovane contadina in groppa a un piccolo asino, con un bambino sulle braccia. Su un campicello dietro il cimitero, un vecchio contadino, a capo scoperto, tracciava linee brune con un aratruccio di legno tirato da due asini. Sembrava una vecchia pantomima monotona la vita contemplata dall’orto del prete.
Don Benedetto compiva quel giorno settantacinque anni. Era un tiepido pomeriggio di fin d’aprile, la prima vera giornata tiepida dopo un inverno assai rigido. Seduto sul muricciolo dell’orto, anch’egli alzava ogni tanto gli occhi dal breviario per guardare a valle, in attesa dell’arrivo di alcuni suoi antichi allievi. I giovanotti dovevano arrivare isolatamente dalla destra e dalla sinistra, dalla parte della città e dai villaggi di montagna, dove la vita li aveva dispersi alla fine degli studi. Ma sarebbero venuti?
Al di sotto dell’orto di don Benedetto, in quell’ora del giorno, le poche case del villaggio della Rocca sembravano disabitate. In mezzo alle povere case appiccicate l’una contro l’altra, era una piazzetta angusta, lastricata di ciottoli e d’erba; in fondo alla piazzetta, il porticato basso d’una antica chiesa e sul porticato un grande rosone a trafori. Le case, le vie, la piazzetta parevano abbandonate. Attraversò la piazzetta un mendicante in cenci e tirò via senza fermarsi. Si affacciò sulla soglia d’una casa una bambina e stette a guardare; poi si nascose dietro una siepe e rimase a guardare tra i cespugli.
«Avrei dovuto forse comprare della birra» disse la sorella. «E tu avresti potuto anche farti la barba, oggi ch’è la tua festa.»
«La mia festa? Bei tempi di festa, in verità. Per i ragazzi il tamarindo è anche buono» disse don Benedetto. «Dico questo, se verranno.»
Il tamarindo veniva dalla città, in bottiglia, mentre Matalena Ricotta con le fragole, i funghi e le uova, scendeva dalla montagna.
Don Benedetto posò sul muricciolo, accanto a sé, il libro e si mise a osservare il lavoro del telaio. Se i giovanotti non fossero arrivati, che delusione per Marta, sua sorella. Gli inviti erano stati diramati da lei, in segreto, ma quella mattina aveva tutto raccontato al fratello, per trattenerlo in casa l’intero pomeriggio. E se gli invitati non fossero venuti? I due cercavano di non guardarsi, per dissimulare l’uno all’altra la propria ansietà.
«Sai che Sciancalla è tornato agli scambi in natura?» disse Marta. «In cambio di carbone ora accetta solo cipolle e fagiuoli.»
«Dopo il pasto, da qualche tempo, ho nuova...