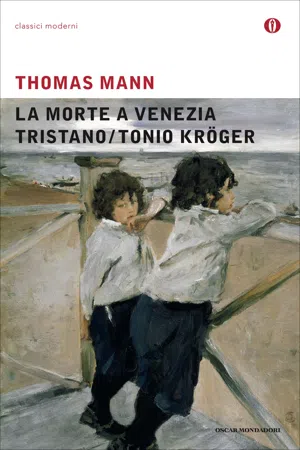
- 224 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La morte a Venezia / Tristano / Tonio Kröger (Mondadori)
Informazioni su questo libro
Un attempato professore sconvolto dalla visione di uno splendido adolescente, uno strano amore nato in un sanatorio, un'incerta vocazione letteraria che si scontra con un richiamo alla normalità borghese. Grottesco e tragedia si intrecciano paradossalmente nei tre brevi capolavori del più importante scrittore tedesco della prima metà del Novecento.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Base e Completo
- Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.
- Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi usare l’app Perlego sia su dispositivi iOS che Android per leggere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo — anche offline. Perfetta per i tragitti o quando sei in movimento.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Sì, puoi accedere a La morte a Venezia / Tristano / Tonio Kröger (Mondadori) di Thomas Mann, Emilio Castellani in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788804492603eBook ISBN
9788852031496La morte a Venezia
Traduzione di Emilio Castellani
riveduta da Renata Colorni
I
Gustav Aschenbach, ovvero von Aschenbach, come da quando aveva compiuto cinquant’anni suonava ufficialmente il suo nome, in un pomeriggio di primavera dell’anno 19..., che per vari mesi si mostrò al nostro continente con un volto tanto minaccioso, era uscito dalla sua abitazione nella Prinzregentenstrasse di Monaco per fare, da solo, una passeggiata piuttosto lunga. Sovreccitato da una mattinata di lavoro arduo e insidioso, che proprio ora esigeva dalla sua volontà il massimo della cautela, circospezione, sottigliezza e rigore, nemmeno dopo pranzo lo scrittore era riuscito ad arrestare l’intimo impulso del meccanismo creativo, quel «motus animi continuus» nel quale, a detta di Cicerone, risiede la peculiare natura dell’eloquenza; e non aveva potuto concedersi il sonnellino ristoratore che ormai gli era quotidianamente indispensabile per compensare il sempre più rapido logorarsi delle energie. Perciò, poco dopo il tè, aveva deciso di uscire, nella speranza che l’aria e il moto lo avrebbero rimesso in sesto, concedendogli una proficua serata.
Erano i primi di maggio e una falsa estate era subentrata a una serie di settimane fredde e umide. Il Giardino Inglese, afoso come d’agosto benché appena screziato di tenero verde, brulicava, nella parte vicina alla città, di gente a passeggio e di carrozze. Seguendo viottoli sempre più solitari e silenziosi Aschenbach era giunto alla birreria Aumeister, era rimasto un poco ad osservare la gente alla buona che popolava il giardinetto ai cui margini sostavano alcune vetture pubbliche e private, ma al tramonto del sole, abbandonato il parco, aveva preso, per l’aperta campagna, la via del ritorno e, poiché si sentiva stanco e dato che su Föhring si addensava un temporale, giunto al Cimitero Nord si mise in attesa del tram che lo avrebbe riportato direttamente in città.
In quel momento, per caso, alla fermata e nelle sue adiacenze non c’era anima viva. Sul selciato della Ungererstrasse, i cui binari si stendevano lucidi e deserti in direzione di Schwabing, e sullo stradone di Föhring non si scorgevano veicoli; tutto era immobile dietro le staccionate dei marmisti, dove croci, pietre tombali e monumenti, esposti in vendita, sembravano formare una seconda e inabitata necropoli, e dirimpetto la mole bizantina della cappella mortuaria giaceva silenziosa nell’ultimo bagliore del giorno. Sulla facciata, adorna di croci greche e di figurazioni ieratiche in tenui colori, spiccavano iscrizioni simmetriche a lettere dorate, appropriate citazioni bibliche sull’aldilà, come ad esempio: «Essi entreranno nella casa di Dio», oppure: «Risplenda ad essi la luce perpetua»; e nella lettura di quelle massime, nel lasciar errare il suo spirito nel trasparente misticismo che da esse si sprigionava, lo scrittore aveva trovato modo d’ingannare nobilmente l’attesa; ma a un tratto, destatosi da tali fantasticherie, egli vide lassù, sotto il portico, tra le due fiere apocalittiche poste a guardia della scalea, un uomo dall’aspetto piuttosto inusitato che impresse un corso tutto nuovo ai suoi pensieri.
Se costui fosse uscito dalla bronzea porta della cappella, o giunto inopinatamente da fuori salendo la scalinata, non era facile a dirsi; Aschenbach, senza dare molto peso alla questione, propendeva per la prima delle due ipotesi. Di media statura, magro, senza barba, e con un naso spiccatamente camuso, l’uomo apparteneva al tipo di pelo rosso, del quale possedeva la carnagione lattea e lentigginosa. Evidentemente non era di schiatta bavarese: così almeno sembrava indicare il cappello di rafia, largo e a tesa diritta, che gli copriva il capo e conferiva al suo aspetto un che di straniero, di esotico. L’uomo portava il consueto sacco da montagna affibbiato sul dorso e vestiva un abito giallognolo con martingala che pareva di loden; con l’avambraccio sinistro puntato sul fianco reggeva una mantella impermeabile grigia, e nella mano destra un bastone con la punta di ferro conficcato obliquamente nel suolo, dotato di un’impugnatura alla quale egli si appoggiava con l’anca tenendo i piedi incrociati. A capo eretto – tanto che sul collo, che scarno emergeva dal camiciotto aperto, il pomo d’Adamo spiccava nudo e forte – figgeva in lontananza lo sguardo incolore degli occhi rossocigliati, divisi da due profondi solchi verticali che armonizzavano in maniera bizzarra con il suo breve naso schiacciato. Da tutto il suo contegno, insomma – e a quest’impressione contribuiva probabilmente lo starsene là in alto, come su un piedistallo – traspariva un non so che di imperioso, di dominante, un’arditezza quasi selvaggia; fosse infatti per una smorfia provocata dall’abbaglio del sole al tramonto, o per una deformazione permanente della fisionomia, le sue labbra apparivano troppo corte, completamente ritratte dai denti, tanto che questi ultimi sporgevano bianchi, lunghi, visibili fino alle gengive.
È possibile che nell’esame, tra assorto e inquisitorio, cui Aschenbach aveva sottoposto lo straniero non fosse mancata una certa indiscrezione, perché a un tratto egli notò, in effetti, che l’uomo ricambiava il suo sguardo in modo così aggressivo e provocante, così chiaramente deciso a spingere la sfida all’estremo e a costringere lui stesso ad abbassare gli occhi, che, sgradevolmente colpito, Aschenbach si voltò e si mise a passeggiare lungo le staccionate, non senza aver preso la determinazione di astenersi totalmente dal pensare all’individuo in questione. Bastò un minuto perché lo dimenticasse. Ma ormai, o che il carattere zingaresco dell’apparizione avesse già colpito la sua fantasia, o che comunque altri influssi fisici o psichici agissero su di lui, fatto sta che ebbe la sorprendente coscienza di uno strano dilatarsi del proprio animo, qualcosa che somigliava a un’inquietudine errabonda, a una giovanile frenesia di lontananze, insomma un sentimento così vivo l’afferrò, così nuovo, o da così lungo tempo desueto e disimparato che dovette fermarsi di botto, con le mani dietro la schiena e gli occhi a terra, per indagare la natura e l’oggetto di quel turbamento.
Era voglia di viaggiare, null’altro; ma, in realtà, sopravvenuta con la violenza di un accesso, spinta al parossismo, all’allucinazione. La frenesia diventò in lui visionaria; l’immaginazione, ancora eccitata dalle ore di lavoro, foggiava esempi di tutte le meraviglie e gli orrori del multiforme orbe terrestre che ora d’improvviso si sforzava di evocare; ed egli vide, sì vide, un paesaggio, una palustre regione tropicale sotto un cielo greve di vapori, rorida, lussureggiante e mostruosa, quasi un groviglio primordiale di isole, di lagune, di lutulente anse fluviali; vide da rigogliose macchie di felci, da fondi di vegetazione grassa, tumida e convulsa, rizzarsi, di qua, di là, palme villose, e alberi bizzarramente contorti affondare nel suolo le loro aeree radici, o tuffarle in acquitrini dai riflessi verdastri, dove tra fiori natanti, bianchi come il latte e grandi come ciotole, stavano appollaiati, volgendo l’occhio immobile, uccelli di forme stravaganti, dal collo infossato tra le ali, dai becchi enormi; vide in un folto di nodosi bambù scintillare le pupille di una tigre in agguato – e si sentì battere il cuore di terrore e d’inesplicabile smania. Poi la visione dileguò; e Aschenbach, scuotendo la testa, riprese la sua passeggiata lungo le palizzate dei marmisti.
Per lo meno da quando aveva avuto i mezzi per godere a proprio piacimento dei vantaggi di girare il mondo, i viaggi erano stati per lui soltanto una misura igienica alla quale di quando in quando, sia pure a malincuore, bisogna assoggettarsi. Troppo occupato dai compiti che gl’imponevano il suo io e l’anima europea, troppo gravato dall’obbligo di produrre, troppo alieno dalle distrazioni per innamorarsi delle variopinte apparenze del mondo, si era pienamente appagato di quell’immagine che ciascuno si può figurare, senza allontanarsi molto dal proprio ambiente, della superficie terrestre, né mai l’aveva sfiorato il pensiero di lasciare l’Europa. Tanto più, poi, da quando la sua vita aveva cominciato a declinare, da quando il timore di non finire la sua opera d’artista, l’apprensione che l’ora passasse senza permettergli di terminare, di dare tutto se stesso, erano diventati qualcosa di più di una futile ubbia che si scaccia con un gesto, da allora la sua esistenza esteriore si era quasi del tutto confinata nella bella città che aveva scelto come patria di elezione e nella rustica dimora campagnola che si era costruito tra i monti e in cui trascorreva le estati piovose.
Anche ora, la ragione e l’autodisciplina cui era avvezzo fin dalla giovinezza fecero sì che ben presto quel tardivo e repentino impulso venisse moderato e tenuto a freno. Si era ripromesso di portare fino a un certo punto, prima di recarsi alla residenza estiva, l’opera ch’era diventata la sua ragione di vita; l’idea di un vagabondaggio in paesi lontani, che per mesi lo avrebbe distolto dal lavoro, sembrava talmente scapestrata e sregolata da non meritare seria considerazione. Eppure, conosceva fin troppo bene i motivi profondi di quella repentina tentazione. Tanto valeva confessarselo: l’ansia di cose nuove e lontane, la sete di sentirsi libero, sciolto da fardelli, dimentico di ogni cosa, altro non erano che un impulso a fuggire, ad abbandonare il lavoro e il luogo ove si dedicava con fredda, ostinata passione al suo servizio quotidiano. Egli lo amava, è vero, e si può quasi dire che amasse altresì la lotta snervante, ogni giorno rinnovata, tra la sua fiera e tenace volontà, messa a continuo cimento, e quel senso crescente di stanchezza che nessuno al mondo doveva percepire, che non un solo segno di imperfezione o di negligenza doveva tradire nel risultato finale. Sembrava sensato, tuttavia, non tendere troppo la corda, non incaponirsi a soffocare un’esigenza così viva e prepotente. Pensò al lavoro, ricordò il punto in cui quel giorno, come già il giorno prima, era stato costretto a interromperlo per una difficoltà che non sembrava disposta ad arrendersi né alla lunga pazienza del cesello né a un rapido colpo d’ala; la riprese in esame, si sforzò di capire come abbattere l’ostacolo o come appianarlo, finché, con un brivido di disgusto, abbandonò l’impresa. Non si trattava, è vero, di un problema eccezionalmente arduo: ciò che lo paralizzava era piuttosto il rovello della svogliatezza, che assumeva i tratti di una immedicabile incontentabilità. Senza dubbio, fin dall’adolescenza l’incontentabilità era stata per lui la condizione stessa, la prima radice del talento artistico; per amor suo aveva imbrigliato e raggelato il sentimento, che sapeva incline ad appagarsi di spensierate approssimazioni e di cose perfette a metà. Voleva forse ora il sentimento asservito prendere la sua rivincita con l’abbandonarlo, con la riluttanza a portare innanzi la sua arte, a darle ali, col rapirgli il diletto e l’incanto della forma e dell’espressione? Non che i suoi ultimi scritti fossero di cattiva qualità; in ciò, se non altro, stava il vantaggio degli anni: nella tranquilla, inalterabile sicurezza riguardo alla propria maestria. Ma di questa maestria, oggetto di un culto nazionale, proprio lui non riusciva a rallegrarsi; gli pareva che alla sua opera mancasse il suggello di un estro infiammato e giocoso, quell’impronta di gioia che è a sua volta fonte di gioia per coloro che amano le opere d’arte più di qualsiasi contenuto interiore e più di ogni pregio, per eminente che sia. Pensò con repulsione all’estate campagnola, alla solitudine nella piccola casa con la fantesca che prepara i pasti e il domestico che li serve; all’aspetto familiare delle vette e dei clivi montani che ancora una volta avrebbero circondato la sua svogliata lentezza. Era davvero necessaria una parentesi: vivere un po’ come capita, alla giornata, respirare l’aria delle grandi distanze, far entrare in circolo sangue nuovo; solo così avrebbe potuto sopportare l’estate e ricavarne buon frutto. Viaggiare, dunque: d’accordo. Oh, non molto lontano, non proprio fino al paese delle tigri, una notte in vagone letto, tre o quattro settimane di distensione in una qualunque località internazionale di villeggiatura nell’accogliente Sud...
Tali erano i suoi pensieri mentre si faceva più intenso il fragore del tram elettrico che scendeva dalla Ungererstrasse; e lui, salendo nella vettura, decise di dedicare la serata allo studio delle carte geografiche e degli orari ferroviari. Quando fu sulla piattaforma, gli venne in mente l’uomo dal cappello di rafia che gli era stato vicino durante quella sosta, comunque gravida di conseguenze; gettò un’occhiata intorno, ma non poté accertarsi se fosse rimasto lì: né dove lo aveva scorto in precedenza, né nello spazio più ampio della fermata, e neppure all’interno del tram, gli riuscì di trovarlo.
II
L’autore della limpida e possente epopea in prosa sulla vita di Federico di Prussia; l’artista paziente che con lungo studio aveva tessuto quell’arazzo popolato di figure, quella molteplice adunata di destini umani all’ombra di un’idea, che è il romanzo «Maja»; il creatore del vigoroso racconto intitolato «Un miserabile», dal quale una intera generazione di giovani aveva tratto con gratitudine l’insegnamento che la risolutezza etica è possibile al di là di ogni conoscenza, per profonda che sia; l’autore, finalmente (e con questo abbiamo in breve enumerato le sue opere della maturità), dell’appassionato saggio «Spirito e arte», che nella sua forza ordinatrice e nell’eloquenza delle antitesi aveva suggerito a critici autorevoli un raffronto immediato col trattato di Schiller sulla poesia ingenua e sentimentale: Gustav Aschenbach, insomma, era nato a L., capoluogo di un distretto della provincia slesiana, da un alto funzionario della magistratura. Tra i suoi avi si annoveravano ufficiali, giudici, funzionari pubblici, tutti uomini che al servizio del re e dello Stato avevano condotto la loro esistenza con austerità, decoro e parsimonia. Nella persona di un predicatore si era perfino, una volta, incarnato un filone di più intensa spiritualità; un sangue più impetuoso e sensuale era affluito nella casata con la generazione precedente, grazie alla madre dello scrittore, figlia di un direttore d’orchestra boemo. Da lei derivavano certi tratti di razza straniera che lo scrittore recava impressi nel fisico. A generare l’artista, questo specifico artista, era stato l’impasto tra una sobria e disciplinata coscienziosità e impulsi più oscuri e focosi.
Poiché tutto il suo essere tendeva alla gloria, anche se egli non era stato quel che si dice un genio precoce, ben presto, nella fermezza e nella pregnanza del suo personalissimo stile, si dimostrò maturo per il pubblico successo. Ancor fresco di liceo, già era un nome; dieci anni dopo, imparò a sostenere, da dietro la sua scrivania, il ruolo di rappresentanza che gli spettava, ad amministrare la sua celebrità, a redigere le sue lettere – sempre cortesi e significative – con la necessaria concisione (ché molti impegni deve fronteggiare l’uomo di successo, l’uomo degno di fiducia). A quarant’anni, sfibrato dalle fatiche e dagli alti e bassi tipici del suo lavoro, doveva tener dietro giornalmente a una corrispondenza che recava i francobolli di tutti i Paesi del mondo.
Poste a uguale distanza dal banale come dall’eccentrico, le caratteristiche del suo talento erano tali da conquistargli sia la devozione del grande pubblico sia il consenso ammirato ed esigente dei lettori più raffinati. Così, fin dall’adolescenza, sentendosi pressato da ogni parte a produrre – e anzi a produrre qualcosa di straordinario – non aveva mai conosciuto gli ozi e le beate indolenze della giovinezza. Quando, a trentacinque anni, gli accadde di ammalarsi a Vienna, vi fu chi acutamente osservò in un salotto: «Vedete, Aschenbach è sempre vissuto così» (e strinse a pugno le dita della mano sinistra), «mai così» (e lasciò pendere la mano aperta e rilassata dal bracciolo della poltrona). Nulla di più indovinato; e il fatto che la sua fibra fosse tutt’altro che robusta, e che il vivere in continua tensione non rappresentasse per lui qualcosa di innato, ma il portato di una vocazione, era ciò che conferiva alla sua moralità una nota di ardimento.
Da fanciullo, i medici, preoccupati per la sua salute, gli avevano proibito di frequentare le scuole, costringendolo allo studio privato. In tal modo era cresciuto solo, senza compagni, e tuttavia aveva presto dovuto riconoscere di essere uno di quelli che non di talento difettavano, bensì della struttura fisica che al talento è indispensabile per espandersi appieno: di quelli che sogliono dare in breve tempo il meglio di sé e nello spazio di pochi anni vedono generalmente esaurirsi la loro capacità produttiva. Ma il motto da lui adottato era «perseverare»; lo stesso romanzo su Federico il Grande non era altro, per lui, che l’apoteosi di tale imperativo, in cui gli pareva compendiata l’essenza di ogni virtù che è al tempo stesso capace di agire e di patire. E ardentemente desiderava d’invecchiare, poiché sempre aveva ritenuto che grande, completa e realmente degna di venerazione può dirsi soltanto quella carriera artistica che a ogni gradino dell’umano riesce a creare qualcosa di peculiarmente fecondo.
Deciso dunque a sostenere su fragili spalle i compiti impostigli dal suo talento e a compiere un lungo cammino, aveva più che mai bisogno di disciplina; e questa fortunatamente gli era stata tramandata dal ramo paterno. A quarant’anni, a cinquanta, come già nell’età in cui altri si abbandonano alle dissipazioni, alle stravaganze, e formulano grandi progetti per poi rinviarli a cuor leggero, ogni sua giornata iniziava con abluzioni d’acqua fredda al petto e alla schiena; dopo di che, alla luce di due lunghe candele poste in capo al manoscritto su candelieri d’argento, in due o tre ore di fervido e coscienzioso lavoro mattutino sacrificava all’arte le forze accumulate durante il sonno. Era pensabile, e anzi il segno della sua vittoria morale, che chi non lo conosceva considerasse il microcosmo di «Maja», nonché le masse multiformi che facevano da sfondo all’epos di «Federico», prodotti di un’energia gagliarda e di ampio respiro, mentre al contrario quelle creazioni erano assurte a grandezza a partire da un’infinità di piccole ispirazioni, amalgamate, strato dopo strato, grazie a un minuto lavorio giornaliero in quanto l’unica e vera radice della loro compatta perfezione risiedeva nella tenacia, nell’indefettibile volontà con cui l’artista – simile in ciò all’antico conquistatore della sua terra natale – aveva sostenuto per anni la tensione di una sola e medesima impresa, dedicando alla sua vera e propria fattura soltanto le ore più feconde e più degne.
Perché un magistrale prodotto dello spirito ingeneri un effetto immediato, profondo ed esteso, occorre che una segreta affinità, o addirittura una concordanza, leghi il destino personale del suo autore a quello comune della generazione alla quale appartiene. Gli uomini non sanno perché procurano fama a un’opera d’arte. Da quegli imperfettissimi conoscitori che sono, credono di scoprirvi chissà quali pregi a giustificazione del proprio entusiasmo; ma il reale motivo del loro favore è un imponderabile elemento di simpatia. Una volta, in una pagina poco appariscente, Aschenbach aveva espresso con chiarezza la sua convinzione che quasi tutto ciò che esiste di grande rappresenti in qualche modo una sfida, sia divenuto realtà nonostante crucci e tormenti, nonostante la miseria, l’abbandono, la debolezza fisica, i vizi, le passioni e ogni sorta di ostacoli. Ben più che una semplice osservazione, questa era un’esperienza vissuta, la formula stessa della sua vita e della sua gloria, la chiave per capire l’opera sua: perché stupirsi dunque che fosse anche la caratteristica etica, il gesto estrinseco dei suoi personaggi più peculiari?
Nel nuovo tipo d’eroe che lo scrittore mostrava di prediligere, e che riappariva sotto vari sembianti in numerose sue creature, già parecchio tempo addietro un sottile esegeta aveva individuato il concetto «di una virilità intellettuale e adolescenziale... che, stringendo i denti nel suo orgoglioso pudore, resta immobile mentre spade e lance le trapassano il corpo». Bella, geniale e precisa definizione, e solo in apparenza troppo volta a sottolineare l’aspetto passivo; giacché la fermezza di fronte al destino, l’avvenenza fra i tormenti non significano solo patire, ma sono qualcosa di attivo, un positivo trionfo; e la figura di san Sebastiano è il simbolo più bello, se non dell’arte in assoluto, per lo meno di quest’arte. Ed ecco ciò che sfilava dinnanzi agli occhi dell’osservatore di quel mondo narrato: l’elegante padronanza di sé, che fino all’ultimo istante sa nascondere agli sguardi del mondo un intimo sfacelo, la decadenza biologica; l’opaca bruttezza, sensualmente svantaggiata, che riesce a far divampare in purissima fiamma la concupiscenza che cova sotto la cenere e, addirittura, si erge trionfalmente nel regno del bello; l’esangue debilità che dagli infocati abissi dello spirito attinge la forza di gettare tutta una plebe tracotante ai piedi della croce, ai suoi propri piedi; l’amabilità del tratto nel culto vacuo e severo della forma; la vita falsa e rischiosa, l’artificio struggente e snervante del truffatore nato. Lo spettacolo di tutti questi destini e di tanti altri analoghi poteva ingenerare il dubbio che nessun altro eroismo esistesse all’infuori di quello della debolezza. E quale eroismo, del resto, era maggiormente consono all’epoca? Di tutti coloro che lavorano al limite della estenuazione, di quelli che, già consunti, rimangono eretti sotto il peso dal quale sono gravati, Gustav Aschenbach era il poeta: di tutti quei moralisti dell’operosità, che, esili di corpo e scarsi di risorse, riescono tuttavia, esasperando la volontà e amministrandosi saggiamente, a sprigionare almeno per un certo tempo una luce di grandezza. Sono numerosi, costoro: sono gli eroi del nostro tempo. Ed essi si riconoscevano tutti nella sua opera, vi trovavano la conferma, l’esaltazione, la celebrazione del loro modo di essere; e ne rendevano grazie a lui, acclamando il suo nome.
Anche Aschenbach era stato giovane e incauto come il suo tempo, e da esso mal consigliato si era lasciato cogliere in fallo, aveva preso abbagli, scoperto il fianco, recato offesa al tatto e al discernimento sia nelle parole che negli scritti; ma infine era pervenuto a quella dignità verso la quale, come soleva affermare, ogni uomo di grande talento è naturalmente sospinto e stimolato; si può dire, anzi, che tutta la sua evoluzione non fosse stata che una metodica, pervicace ascesa alla dignità oltre gli ostacoli del dubbio e dell’ironia.
Oggetto del godimento delle masse borghesi è la vivida plasticità delle immagini che non richiedono alcun impegno intellettuale mentre la gioventù, nella sua sete di assoluto, ad altro non si appassiona che ai problemi: e problematico e radicale era stato Aschenbach al pari di qualunque adolescente. Aveva ubbidito ai capricci dello spirito, dilapidato i tesori de...
Indice dei contenuti
- Copertina
- La morte a Venezia - Tristano - Tonio Kröger
- Thomas Mann
- La morte a Venezia
- Tristano
- Tonio Kröger
- Copyright