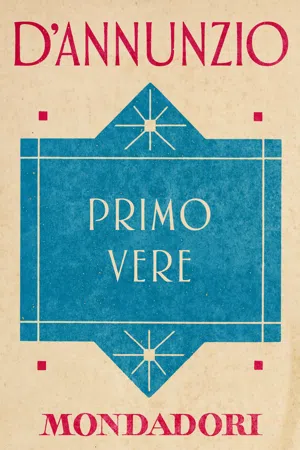1 NOTIZIA SUL TESTO
Di Primo vere uscirono tra il ’79 e l’80 due edizioni: la prima, stampata presso la tipografia Ricci di Chieti, comprendente 26 ‘barbare’ e 4 traduzioni da Orazio (Imitazioni), vide la luce nel dicembre ’79, dopo un’elaborazione durata un anno (dall’autunno ’78 all’autunno ’79); la seconda, pubblicata a Lanciano da Rocco Carabba, era compiuta in data 14 novembre 1880, e si presentava al pubblico in veste rinnovata, anche in senso quantitativo – aggiunte 43 liriche, 15 traduzioni dal latino e 4 dal greco (Tradimenti), per un totale di 76 componimenti. Travagliato e complesso, nell’uno e nell’altro caso, il costituirsi del poemetto: dall’incertezza relativa al titolo e allo pseudonimo – Periclitatio, versi di Fulvio Giovinelli; Odi arcibarbarissime di Albio Laerzio Floro; Crepuscola Eoa – odi barbare – di Albio Laerzio Floro (G. d’Annunzio); Primo vere, liriche di Gabriele d’Annunzio (Floro) – ai problemi di datazione e definizione topografica di cui dà notizia il Lanza in uno studio sui quaderni manoscritti di Primo vere (cfr. Note sull’elaborazione di «Primo vere», in QD, XXXII-XXXIII, 1962, pp. 274-292; il critico utilizza anche gli autografi pubblicati da M. Masci, Dalla Pescara all’Arno, in Gloria alla Terra!, Pescara 1963). Entrambe le raccolte furono precedute e accompagnate da scambi epistolari, utili a individuare scelte espressive e direzioni di poetica. Ci si limita a segnalare le lettere a Cesare Fontana del 20 maggio 1879, del 1° settembre dello stesso anno («[…] Mi domandi le mie poesie […] Son poca cosa! Sono lampi rosei di vita giovanile, deliri pieni di fremiti e di parole insensate, febbri ed ebrezze, serenità cerulee e caligini fosche […] ma non vi cercare la scintilla del genio […]» – segue una richiesta di interessamento per la pubblicazione del volumetto, dal titolo Crepuscola Eoa, destinata all’insuccesso –) e del 12 agosto 1880 (in Forcella, I, 89-92); quella al Chiarini del febbraio 1880 («[…] Fino al novembre del ’78 non avevo fatto un verso a garbo […] Nel Novembre […] mi fermai per tre o quattro giorni a Bologna. Avevo sentito parlare di Odi barbare, di realismo, di battaglie per l’arte […] comprai diversi volumi dal Zanichelli. Fra questi c’erano le Odi del Carducci con prefazione di G. Chiarini […] In quei giorni divorai ogni cosa con una eccitazione strana e febbrile e mi sentii un altro. L’odio pe’ versi scomparve come per incanto, e vi subentrò la smania della poesia […]» – in Guido Mazzoni, Poeti Giovani, Livorno 1888, poi Napoli 1916); quelle al Biagi del 4 giugno 1880 («[…] io mi sento forte e pieno di ingegno, e andrò avanti […] lascerò brandelli di carne viva dovunque c’è una gloria da conquistare; sarò il poeta de ’l cuore, come dice lei. Ma intanto ho bisogno di addestrarmi ad armeggiare […]») e del maggio ’81 («Mi son trovato! Eureka! Con moltissima fatica, ma mi son trovato. C’era quel mago del Carducci che mi schiacciava […] Ho avuto la forza di ribellarmi; e con un lento ma laborioso processo di selections sono venuto fuori io, tutto io. Non mi resta che spezzare gli ultimi deboli lacci e poi gettarmi nel mio mare» – in Forcella, I, 101-102).
Intenzioni, queste ultime, già anticipatrici di Canto novo. Il confronto con il Carducci è tuttavia al centro del processo ideativo e compositivo di Primo vere, e interessa per numerose ragioni. Intanto, sul piano del rapporto col pubblico, la scelta del metro barbaro e delle tematiche carducciane ‘rivisitate’ rivela una precoce capacità di captare il nuovo (le lettere al traduttore francese Hérelle si incaricheranno di dimostrare più tardi quale raffinato sociologo della letteratura si celasse in d’Annunzio). Le Odi barbare del 1877, ma anche, ad esse contemporanei, i Postuma del Guerrini, le Fantasie marine e le Canzoni moderne del Marradi (autore, tra l’altro, di una lirica dal titolo Primo vere datata 1877, vicinissima al repertorio di immagini della raccolta dannunziana), o certe predilezioni del Rapisardi per una natura lucrezianamente animata, fertile di stimoli soprattutto sul versante dell’ormai prossimo Canto novo, permettono infatti al collegiale di riscattare le letture scolastiche (i classici, Foscolo, Leopardi) favorendo le nuove propensioni dei lettori. Nella lettera citata all’amico Fontana scrive, in data 1° settembre, annunciando l’invio di trenta Odi barbare: «Manderò fra breve i due fascicoli, e il Sig. Editore potrà leggerle e farle giudicare. Credo che se ne venderebbero molte copie, non per la bontà del lavoro, ma per la curiosità che in questi giorni destano le Odi barbare nella repubblica letteraria». E occorrerebbe anche indagare nell’ambito delle letture europee, terreno sempre fertile per le prodigiose facoltà assimilatrici del poeta. Si scoprirebbero allora non solo le radici di certo gusto dell’esotismo del PRELUDIO SU ’L NILO, SEYDA (le Orientales victorhughiane in primo luogo) e l’uso, ancora ingenuo e scolastico, di autori destinati a ripresentarsi lungo l’evolversi della produzione dannunziana (Baudelaire, Shakespeare, Alfred de Musset), ma soprattutto l’affacciarsi, indiscutibile nel caso della prima redazione di FANTASIA PAGANA, dello Zola della Faute de l’abbé Mouret, tradotto in italiano solo nel 1880, ma pubblicato già nel ’75 (Ne parea che il cielo e la terra / Plaudissero al delirio sublime, ove il trasporto sensuale è già parte della «musique des choses et des êtres»: si confronti il testo francese, utilizzato poi in Canto novo ’82, I, VIII – «Et c’était une victoire pour les bêtes, les plantes, les choses, qui avaient voulu l’entrée de ces deux enfants dans l’éternité de la vie. Le parc applaudissait formidablement» [corsivo nostro]).
Per tornare intanto al Carducci e alla ricerca della ‘novità’ è opportuno ricordare che con baldanza proterva il ‘poetino’ del Cicognini gli aveva scritto: «Io voglio seguire le sue orme: voglio anch’io combattere coraggiosamente per questa scuola che chiamano nuova, e che è destinata a veder trionfi ben diversi da quelli della chiesa e della scuola del Manzoni […]». La deferenza e la stima per il Maestro sono in realtà più proclamate che profondamente nutrite, se al di là dell’imitazione di metri e strutture sintattiche, oltre che della palese ripresa di motivi e temi, la sensibilità e, si direbbe, ...