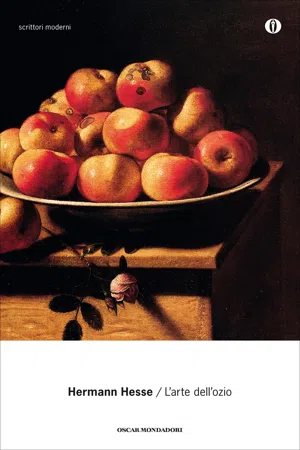![]()
Se in fondo non fossi un uomo estremamente operoso, non
so come mi sarebbe potuta venire l’idea di concepire inni
e teorie in favore dell’ozio. Gli oziosi per natura, gli oziosi
geniali, non compiono mai nulla di simile. H.H. (1928)
![]()
L’arte dell’ozio
Un capitolo di igiene artistica
Quanto più la prepotente attività industriale priva di gusto e tradizione ha assimilato anche il lavoro intellettuale, e quanto più zelanti si sono fatti gli sforzi delle scienze e della scuola nel derubarci della nostra libertà e della nostra personalità, inculcandoci fin dai più teneri anni l’ideale di uno sforzo coatto e ansioso, tanto più l’arte dell’ozio, accanto ad altre arti passate di moda, è andata in rovina, ha perso credito ed è caduta in disuso. Non che noi ne fossimo mai stati grandi maestri! Nel mondo occidentale, l’ozio elevato ad arte è stato praticato in tutti i tempi solo da innocui dilettanti.
Tanto più meraviglia il fatto che ai nostri giorni, quando un così gran numero di persone rivolge sguardi nostalgici verso oriente e con non pochi sforzi aspira ad assimilare un po’ di felicità da Shiraz e Bagdad, un po’ di cultura e tradizione dell’India e un po’ di serietà e profondità dai santuari di Buddha, capita solo di rado che qualcuno stenda la mano verso ciò che gli è più vicino e cerchi di afferrare parte di quel fascino che, mentre leggiamo i racconti orientali, sentiamo spirare verso di noi dai cortili dei palazzi mori rinfrescati dalle fontane.
Com’è mai possibile che così tanti fra noi non traggano un singolare senso di gioia e diletto da codesti libri di novelle, dalle Mille e una notte, dai racconti popolari turchi e dal delizioso Libro del pappagallo,1 il Decamerone della letteratura orientale? Come mai un giovane poeta così raffinato e originale come Paul Ernst ha seguito, nella sua Prinzessin des Ostens (Principessa d’Oriente), tali antiche orme? Come mai Oscar Wilde ha scelto di preferenza questo rifugio per la sua fantasia sovraffaticata? Se vogliamo essere sinceri, a prescindere da quei due o tre studiosi orientalisti, dobbiamo ammettere che per noi i ponderosi volumi delle Mille e una notte come contenuto non reggono il confronto con una sola delle fiabe dei fratelli Grimm o una sola delle saghe cristiane medievali. Tuttavia li leggiamo con gusto, e di lì a poco li dimentichiamo, essendo ciascuna di quelle storie così fraternamente simile alle altre, e torniamo poi a leggerli con uguale piacere.
Come si spiega ciò? Si ama ascrivere questo fatto all’affascinante e raffinata novellistica orientale. Ma così facendo sopravvalutiamo il nostro stesso giudizio estetico: se infatti, disgraziatamente, stimiamo tanto poco quei rari, genuini talenti narrativi della nostra letteratura, perché mai dovremmo rincorrere quelli stranieri? Non si tratta quindi del piacere del novellare in sé, o quantomeno non solo di questo. Nei confronti di quest’arte in generale dimostriamo invero ben poca sensibilità; quando leggiamo quelle novelle, oltre al mero contenuto, cerchiamo in verità solo stimoli psicologici e sentimentali.
Sullo sfondo di quell’arte, che ci avvince con un fascino così potente, figura principalmente l’indolenza orientale, vale a dire l’ozio sviluppato, padroneggiato e assaporato con gusto fino a diventare arte. Quando giunge il momento più avvincente della fiaba, il narratore arabo ha sempre ancora tempo in abbondanza per raffigurare, fin nei minimi particolari, una tenda reale color porpora, una gualdrappa ricamata e ornata di pietre preziose, le virtù di un derviscio o la perfezione di un vero saggio. Prima di dare la parola al suo principe o alla sua principessa, egli ci descrive con grande minuzia il color rosso e la linea sinuosa delle loro labbra, lo splendore e la forma dei loro bei denti bianchi, l’incanto dello sguardo ardito e fiammeggiante o pudico e abbassato, così come il gesto della mano fine, di un bianco immacolato e sulla quale le unghie rosee e opalescenti delle dita fanno a gara con il fulgore degli anelli cosparsi di gemme. E l’ascoltatore non conoscendo l’impazienza e l’avidità del lettore moderno non lo interrompe, ma ascolta con lo stesso entusiasmo e piacere tanto le qualità di un vegliardo eremita quanto le gioie amorose di un giovane o il suicidio di un visir caduto in disgrazia.
Nel leggere quelle novelle proviamo costantemente un senso di nostalgia e di invidia: questa gente ha tempo! Un sacco di tempo! Può impiegare un giorno e una notte a stabilire una nuova similitudine per l’avvenenza di una bella o per l’infamia di uno scellerato! E quando, la sera, una storia incominciata a raccontare verso mezzogiorno è giunta solo a metà, gli ascoltatori si coricano tranquilli, recitano la loro preghiera e cercano il sonno ringraziando Allah, perché domani sarà un altro giorno. Quanto a tempo, essi sono milionari, vi attingono come a un pozzo senza fondo, senza preoccuparsi eccessivamente di perdere un’ora, un giorno o una settimana. E mentre noi leggiamo quelle strane fiabe e novelle infinite, intrecciate l’una nell’altra, diventiamo a nostra volta singolarmente pazienti e ci auguriamo che non finiscano mai, perché per alcuni istanti siamo caduti in balia del grande incantesimo – la divinità dell’ozio ci ha toccati con la sua bacchetta magica.
Gran parte di quell’infinita schiera di persone che negli ultimi tempi, così stanca e credente, ha compiuto un pellegrinaggio a ritroso fino alla culla natia dell’umanità e della cultura, gettandosi ai piedi del grande Confucio e del grande Laotzu, è semplicemente animata da una profonda nostalgia di quell’ozio divino. Che cosa sono il fascino di Bacco che libera dagli affanni e la dolce, soporifera voluttà dell’hashish in confronto al profondo riposo di colui che fugge il mondo mentre, seduto sul crinale di un monte, contempla l’orbita della propria ombra e perde l’anima nell’ascolto del ritmo costante, sommesso e inebriante dei soli e delle lune che ruotano sopra di lui? Noi poveri occidentali abbiamo ridotto il tempo a minuscoli e minimi brandelli, di cui ciascuno conserva ancora il valore di una moneta; là invece esso continua a fluire indiviso, in una perenne corrente di flutti sufficiente a soddisfare la sete di un mondo intero, inesauribile come il sale del mare e la luce degli astri.
Lungi da me voler dare un consiglio qualsiasi all’attività della nostra industria e della nostra scienza che fagocitano l’individualità. Se l’industria e la scienza non hanno più bisogno di personalità individuali, che ne facciano pure a meno. Noi artisti, però, che in mezzo alla grande bancarotta della cultura abitiamo un’isola nella quale le condizioni di vita sono ancora discretamente sopportabili, dobbiamo obbedire come un tempo ad altre leggi. Per noi, la personalità non è un lusso, bensì condizione esistenziale, aria vitale, capitale irrinunciabile. Per artisti intendo tutti coloro che provano il bisogno e la necessità di sentirsi vivere e crescere, di essere coscienti dei fondamenti delle proprie energie e di costruire se stessi secondo leggi congenite, non compiendo quindi alcuna attività ed espressione vitale subordinata che, per sua natura e per i suoi effetti, non abbia nei confronti di quei fondamenti lo stesso rapporto chiaro e significativo di quello che in una buona costruzione intercorre fra volta e muro, fra tetto e pilastro.
Ma fin dalle origini gli artisti hanno sempre avuto bisogno di momenti d’ozio, in parte per chiarirsi nuove conoscenze e portare a maturazione il lavoro inconscio, in parte per riavvicinarsi ogni volta, con disinteressato fervore, al mondo naturale, diventando nuovamente bambini, sentendosi di nuovo amici e fratelli della terra, della pianta, della roccia e della nube. Sia che un artista componga quadri o versi sia che semplicemente voglia gustare se stesso nell’atto di costruire, comporre e creare, egli si trova sempre di fronte a inevitabili pause. Il pittore che sta davanti a una tavola su cui ha appena steso una mano di fondo e non sente ancora in sé il necessario raccoglimento e l’impulso interiore, incomincia a provare, a dubitare, a lavorare in modo manierato, e alla fine butta tutto all’aria con furia o con tristezza, si sente incapace e inidoneo a qualsiasi compito ambizioso, maledice il giorno in cui è diventato pittore, chiude la bottega e prova invidia per lo spazzino che trascorre i suoi giorni in una tranquilla attività e con la pace nell’anima. Il poeta guarda perplesso un progetto iniziato, non vi ritrova più la primitiva grandezza, cancella parole e pagine, le riscrive, getta ben presto nel fuoco anche quelle nuove, vede vacillare improvvisamente in pallide lontananze, privo di contorni, quel che prima aveva visto con chiarezza, trova improvvisamente meschini, falsi e casuali i suoi entusiasmi e i suoi sentimenti, li rifugge e invidia anch’egli lo spazzino. E così via.
L’esistenza di più d’un artista è formata per un terzo, o per metà, di simili periodi. Solo rarissimi uomini d’eccezione sono in grado di creare a getto continuo, pressoché senza interruzioni. Si vengono così a formare delle pause d’ozio apparentemente insignificanti, che, viste dall’esterno, hanno da sempre suscitato il disprezzo o la pietà degli spiriti gretti. Così come il filisteo ha difficoltà a comprendere quale lavoro immenso e multiforme possa comportare una sola ora di creatività, tanto più gli risulta arduo capire come mai un artista così bizzarro non continui semplicemente a dipingere, a dare una pennellata accanto all’altra e portare tranquillamente a termine i suoi dipinti; come mai, invece, è spesso incapace di proseguire, si stende a rimuginare e chiude bottega per interi giorni o settimane. E l’artista stesso viene sorpreso e deluso ogni volta da simili pause, ogni volta egli cade nelle stesse angosce e negli stessi tormenti, finché impara a riconoscere di dover obbedire alle proprie leggi innate e di potersi consolare all’idea che a paralizzarlo è l’affaticamento tanto quanto la sovrabbondanza. In lui sta nascendo qualcosa che di per sé preferirebbe poter trasformare oggi stesso in una bella opera visibile, ma che pure non ne vuole ancora sapere, poiché non è ancora matura, e la soluzione migliore, l’unica soluzione possibile, la porta in sé come un enigma. Non resta quindi altro che aspettare.
Per questi periodi morti ci sarebbero centinaia di bei passatempi a disposizione, fra cui, in special modo, quello di perfezionare la conoscenza di opere di illustri predecessori e contemporanei. Ma se porti in giro con te, come una spina nel fianco, un lavoro drammaturgico irrisolto, è perlopiù increscioso leggere Shakespeare, e se il primo abbozzo di un quadro si è rivelato un fallimento tale da renderti angustiato e depresso, Tiziano probabilmente ti sarà di scarsa consolazione. Soprattutto i giovani, con il loro ideale di “artista pensante”, ritengono che a questo punto la cosa migliore sia di dedicare alla riflessione il tempo sottratto all’arte, e senza alcuno scopo né profitto si perdono in ponderazioni, scetticismi e simili astrusità.
Altri, non ancora votati alla santa guerra contro l’alcol che di recente ha incominciato a registrare le sue vittorie anche fra gli artisti, imboccano la strada verso posti in cui si può bere un buon bicchiere. A questi va tutta la mia simpatia, perché il vino, come equilibratore, consolatore, calmante e dispensatore di sogni, è un dio molto più bello e raffinato di quanto non vogliano farci credere ultimamente i suoi numerosi nemici. Ma non è per tutti. Per amarlo e assaporarlo con arte e con saggezza, per apprezzare tutte le lusinghe del suo linguaggio adulatore, occorre, come nel caso di altre arti, possedere un talento naturale, e anche allora esso deve poi essere coltivato, e ove non si segua una buona scuola si giungerà raramente a una qualche perfezione. E se anche facessimo parte degli eletti, in quei tempi infruttuosi di cui stiamo parlando avremo difficilmente in tasca il denaro occorrente al degno culto di un dio.
Come trovare allora una via di scampo fra questi due pericoli – il lavoro intempestivo e svogliato e il vuoto cogitabondo e scoraggiante – salvandosi la pelle e l’anima?
Vita mondana, sport, viaggi eccetera, in situazioni del genere sono tutti passatempi vani, che in parte possono inoltre essere presi in considerazione esclusivamente da persone benestanti, e non è certo mai stata ambizione di un artista contare fra queste. Perlopiù, in tempi difficili, anche le arti affini sono solite piantarsi in asso a vicenda: il poeta che soffre per un lavoro incompiuto ritroverà ben di rado la sua pace e il suo equilibrio nel pittore o il pittore nel musicista. L’artista, infatti, può godere profondamente e appieno solo nei periodi fulgidi e creativi, mentre ora, affannato com’è, tutta l’arte gli sembra o insulsa e incolore, o soffocante e prepotente. Un’ora di Beethoven può con altrettanta facilità guarire oppure abbattere completamente colui che di tanto in tanto si sente scoraggiato e disorientato.
È in simili frangenti che sento dolorosamente la mancanza di un’arte del far niente, affermata e nobilitata da una solida tradizione. E il mio animo germanico solitamente immacolato guarda con invidia e nostalgia alla madre Asia, dove un esercizio secolare è riuscito a conferire alla condizione apparentemente informe dell’esistenza e dell’ozio vegetativi un certo ordine e un ritmo nobilitante. Posso affermare senza vanagloria di avere impiegato molto tempo a occuparmi in maniera sperimentale del problema attinente a quest’arte. Rimando a un futuro, specifico lavoro l’illustrazione delle mie esperienze acquisite in materia – basti la mia assicurazione che, in tempi critici, ho quasi imparato a praticare il far niente con metodo e grande diletto. Tuttavia, affinché eventuali artisti fra i lettori anziché passare a loro volta al poltrire metodico non distolgano lo sguardo, delusi come da un ciarlatano, sintetizzerò in poche frasi il mio primo periodo di apprendistato nel tempio di quest’arte.
1. Un giorno, spinto da un vago presentimento, presi dalla biblioteca le edizioni tedesche più complete delle Mille e una notte e dei Viaggi di Sajid Batthal, e mi sedetti a leggere – dopo un breve piacere iniziale, più o meno al termine di una giornata, le trovai entrambe noiose.
2. Riflettendo sui motivi di quell’insuccesso compresi infine che quei libri possono essere letti solo ed esclusivamente in posizione coricata o se non altro stando seduti a terra. La sedia occidentale che costringe a una posizione eretta li priva di ogni efficacia. Fra l’altro, incominciai a comprendere per la prima volta la prospettiva assolutamente differente dello spazio e degli oggetti che si acquista da una posizione sdraiata o accovacciata.
3. Ben presto scoprii che l’effetto dell’atmosfera orientale raddoppiava se, anziché leggere io stesso, facevo leggere qualcun altro (occorre tuttavia che anche chi legge stia sdraiato o accoccolato).
4. La lettura ora praticata finalmente in modo razionale produsse ben presto in me una sensazione di spettatore rassegnato che di lì a poco mi rese possibile, anche senza lettura, di rimanere in una posizione di quiete per ore intere, rivolgendo la mia attenzione a oggetti apparentemente insignificanti (le leggi che regolano il volo delle zanzare, il ritmo dei pulviscoli nel sole, la melodia delle onde sonore ecc.). Ne derivò un crescente stupore circa la molteplicità degli avvenimenti e un totale, tranquillizzante oblio di me stesso, con cui mi assicurai le basi per un salutare, mai noioso far niente.2 Questo fu l’inizio. Altri sceglieranno altri percorsi per immergersi dalla vita cosciente nelle ore dimentiche di se stessi tanto necessarie agli artisti e tanto ardue da raggiungere. Se il mio suggerimento dovesse invitare un maestro occidentale dell’ozio effettivamente esistente a parlare e a rendere noto il suo sistema, vedrei esaudito il mio più fervido desiderio.
Sul viaggiare
Quando mi fu proposto di scrivere qualcosa sulla poesia del viaggiare, in un primo tempo mi parve allettante l’idea di inveire una volta tanto di tutto cuore contro gli orrori di questa moderna attività, contro l’insensata smania per il viaggio, contro gli squallidi hotel, contro località turistiche come Interlaken, contro inglesi e berlinesi, contro la Foresta Nera nella regione del Baden deturpata e diventata costosa oltre ogni dire, contro la gentaglia delle grandi città che pretende di vivere nelle Alpi come a casa propria, contro i campi da tennis di Lucerna, contro osti, camerieri, consuetudini e prezzi alberghieri, vini locali e costumi tradizionali adulterati. Ma quando una volta, mentre ero in treno tra Verona e Padova, non nascosi a una famiglia tedesca le mie idee in proposito, venni invitato con fredda cortesia a tacere, e quando in un’altra occasione, a Lucerna, diedi uno schiaffo a un infame cameriere, venni non dico pregato, bensì costretto a viva forza a lasciare il locale di gran fretta e in modo indecoroso. Da allora ho imparato a dominarmi.
Mi sovviene inoltre che in fondo, durante i miei brevi viaggi, mi sono sempre sentito assolutamente contento e soddisfatto, e che da ciascuno di essi ho portato a casa un qualche piccolo o grande tesoro. Perché dunque inveire?
Sulla questione circa il modo in cui l’uomo moderno dovrebbe viaggiare esistono tanti libri e opuscoli, ma a mio avviso nessuno di buono. Chi intraprende un viaggio di piacere dovrebbe in verità sapere che cosa fa e perché lo fa. Il cittadino di oggi che si mette in viaggio non lo sa. Parte perché d’estate, in città, fa troppo caldo. Viaggia nella speranza di trovare, con il cambiamento d’aria, la vista di un altro ambiente e altra gente, un ristoro dalle fatiche del lavoro. Va in montagna perché è tormentato da un incomprensibile desiderio, da una oscura nostalgia di natura, terra e vegetazione; va a Roma perché è un obbligo culturale. Principalmente, però, va in giro perché così fanno tutti i suoi cugini e vicini di casa, perché in seguito se ne può parlare e si può fare i gradassi, perché è di moda e perché dopo, a casa propria, ci si sente di nuovo così meravigliosamente bene.
Tutti questi sono, è vero, motivi comprensibili e onesti. Ma perché il signor Krakauer va a Berchtesgaden, il signor Müller nei Grigioni, la signora Schilling a Sankt Blasien? Il signor Krakauer lo fa perché molti dei suoi conoscenti si recano sempre anch’essi a Berchtesgaden, il signor Müller sa che i Grigioni sono distanti da Berlino e sono di moda, mentre la signora Schilling ha sentito dire che a Sankt Blasien c’è un’aria così buona. Tutti e tre potrebbero scambiarsi reciprocamente i loro programmi e i loro itinerari di viaggio ché non cambierebbe assolutamente nulla. Di conoscenti se ne possono avere ovunque, del proprio denaro ci si può liberare in qualsiasi luogo e di posti con l’aria buona l’Europa è stracolma. Come mai allora proprio Berchtesgaden? O Sankt Blasien? Qui sta l’errore. Viaggiare dovrebbe sempre significare provare delle esperienze, ed è possibile fare esperienze preziose solo in ambienti cui si è spiritualmente legati. Una gita occasionale, un’allegra serata in una qualsiasi osteria all’aperto, una traversata in piroscafo su un qualsiasi lago non sono di per sé esperienze significative, non costituiscono un arricchimento della nostra vita, non sono impulsi duraturi di forza costante. Possono diventare tali, ma non per i signori Krakauer e Müller.
Forse, per questo genere di persone, non esiste luogo su questa terra con cui esse abbiano rapporti più profondi. Per loro, non c’è territorio, costa, isola, monte o antica città da cui siano attirati con la forza di un presentimento, la cui vista realizzi i loro più ardenti desideri e la cui conoscenza equivalga all’ac...