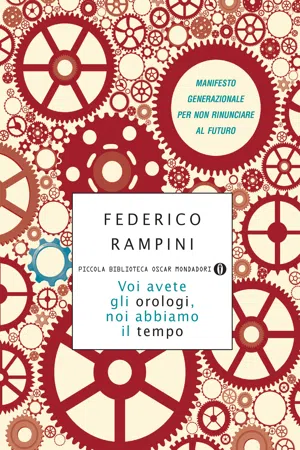Tutto cominciò con il dottor Benjamin Spock, il celebre pediatra-pedagogo americano che trasformò il modo di crescere i figli. Quando i figli eravamo noi.
Sembra banale, ma sarebbe bastata una sola delle sue regole progressiste per avviare un’autentica rivoluzione copernicana: «Allattate i bebè quando piangono dalla fame, non gli imponete orari fissi stabiliti dai manuali». Fu l’inizio del permissivismo: sta lì la vera chiave di spiegazione del nostro Sessantotto?
Correva l’anno di grazia 1946 quando Spock pubblicò la prima edizione del suo manuale di consigli ai genitori: The Common Sense Book of Baby and Child Care. Il titolo si voleva rassicurante, con quel richiamo al «buonsenso». In realtà era sovversivo, sfidava regole consolidate, capovolgeva abitudini secolari. Metteva il neonato e poi il bambino al centro dell’universo, e dell’attenzione degli adulti. Vendette quattro milioni di copie nei primi sei anni solo in America, poi trenta milioni nel mondo intero, tradotto in ventinove lingue. Per molto tempo dominò incontrastato la classifica dei best seller negli Usa. Il messaggio centrale di Spock oggi ci appare ovvio: non abbiate paura di amare i vostri figli e di mostrarglielo, l’affetto è la cosa fondamentale, molto più della disciplina. Non abbiate paura di dirgli «non lo so», la sincerità è un valore, è più importante che dare l’illusione dell’onnipotenza. Ma quando, vent’anni dopo, la Generazione Spock cominciò a rivoltarsi nelle università, a sfilare per le città d’America protestando contro la guerra in Vietnam, i conservatori misero sul banco degli imputati proprio quelle teorie pedagogiche. Un reazionario come il politico repubblicano Spiro Agnew, vicepresidente con Richard Nixon, pronunciò una frase memorabile: «La regola che il pupo va allattato quando vuole lui è diventata un dogma fino all’età di 30 anni». Fummo indisciplinati dalla nascita, allergici alle regole, perché troppo viziati, coccolati?
Altri ci hanno provato, a imitarci. Quella dopo di noi è stata chiamata Generazione X, poi seguita dalla Y, detta anche Generazione Millennial o Generazione Net. Etichette effimere, presto passate di moda, finite nel dimenticatoio, o comunque poco rilevanti. Après nous le déluge, dopo di noi viene il diluvio universale. Nessun’altra generazione può aspirare ad avere un impatto simile, per una ragione molto semplice (e non certo per merito nostro): quelli venuti dopo non sono così numerosi. Perciò l’effetto shock, il terremoto che siamo stati e che continuiamo a essere via via che transitiamo nelle varie fasi della vita, è irripetibile.
È esemplare la definizione dei baby boomer data da Wikipedia, l’enciclopedia universale online che è anche una sorta di deposito del senso comune dei nostri tempi. Wikipedia è il frutto della collaborazione volontaria di decine di migliaia di redattori, che si migliorano e correggono a vicenda. È al tempo stesso attendibile (contiene meno errori dell’Enciclopedia Britannica, molte università americane vi collaborano e ne raccomandano l’uso) e rappresentativa delle opinioni correnti. L’articolo enciclopedico dedicato a noi comincia con il ricordare che «baby boomer» non è solo un termine demografico, ma ha un significato culturale. È una generazione «che viene identificata con il rigetto o la ridefinizione dei valori tradizionali». È anche una generazione privilegiata, almeno in Occidente: «È cresciuta in un’epoca di prosperità, di aumento dei servizi pubblici, di miglioramento dell’istruzione». Di qui, una visione originariamente ottimistica la contrassegna: «Essendo più ricchi, più attivi, più sani delle generazioni precedenti, i baby boomer furono tra i primi a crescere con l’aspettativa che il mondo avrebbe continuato a migliorare». Un tratto distintivo è la coscienza di sé: «Hanno sempre pensato di essere una generazione speciale». A questo ha contribuito il fatto che «fin dalla nascita i baby boomer furono analizzati, sorvegliati, corteggiati da una nuova industria del marketing moderno, il che rafforzò la loro identità di gruppo».
Secondo alcune teorie economiche, stava scritto nel nostro Dna che avremmo provocato anche la grande crisi scoppiata nel 2008. La age wave theory (teoria dell’onda di età) aveva previsto una pesante contrazione economica con l’avvicinarsi dei baby boomer alla pensione. Dopotutto, negli Stati Uniti questo gruppo di età concentra il 50 per cento del potere d’acquisto e dei consumi.
Grandi aspettative: ecco il tema che ci portiamo dietro dalla nascita. È anche il titolo del libro che ci ha definiti una volta per tutte. Great Expectations (che evoca ovviamente l’omonimo romanzo di Charles Dickens), di Landon Jones, esce nel 1980 e conia quella definizione di baby boomer che da allora non ci ha lasciato mai. Resta il miglior condensato della nostra storia giovanile, nella punta avanzata che è l’America. Ci descrive come la prima generazione presa di mira scientificamente da Madison Avenue (la sede delle grandi agenzie pubblicitarie, quella di Mad Men per intenderci) come un mercato a sé stante. Dalla culla in poi, siamo stati i primi a essere bombardati di nuovi prodotti, nuove pubblicità, nuove mode, nuovi stili di vita, a un ritmo vorticoso. Al punto da rimanere per tutta l’esistenza, e dunque anche oggi, segnati dalla «dittatura del nuovo». Crescendo, siamo stati noi a travolgere ogni idea antica del matrimonio, fino a destabilizzare o «balcanizzare» l’istituzione della famiglia, che aveva retto per millenni. Siamo la generazione allevata in un’epoca di fiducia nel progresso, idealismo e speranza, un gruppo nel quale gli iscritti all’università sono raddoppiati rispetto ai tempi dei genitori. Perciò è questa la generazione che ha «voluto il cielo», ha sognato l’utopia al potere: grandi aspettative, appunto. Il magazine «Time» nel 1967 scelse come «uomo dell’anno» da mettere in copertina proprio il giovane baby boomer, allora appartenente alla generazione under 25, alla quale assegnava missioni ambiziose: avrebbe conquistato la luna, superato i pregiudizi razziali, inventato le città senza smog, guarito il cancro e diffuso il benessere nel Terzo Mondo. Il radioso ottimismo di «Time» può far sorridere per la sua ingenuità. Eppure, il confronto con quell’elenco di obiettivi del 1967 oggi ci consente qualche soddisfazione: dalle energie rinnovabili all’ascesa di Cindia, fino all’elezione di un nero alla Casa Bianca, il bilancio non è tutto disastroso.
Nella visione che Landon Jones formulava più di trent’anni fa, quella dei baby boomer appare anche come la prima generazione che, al raggiungimento della mezza età, non si rassegna a invecchiare: e così ha trasformato la «soluzione alla crisi di mezza età» in un nuovo business colossale. Infine: «Dopo il baby boom verrà il regno degli anziani. Quando invecchieranno loro, sarà inevitabile una restaurazione del potere e del ruolo degli anziani nelle nostre società». E così avremo bruciato definitivamente i nostri sogni di gioventù…
Già, perché i baby boomer sono stati segnati, ovviamente, anche dalla politica. Si cominciò in America, nel 1964, con il Free Speech Movement all’Università di Berkeley, la prima rivolta antiautoritaria in un campus studentesco. Seguì il Maggio parigino, con diramazioni in tutta l’Europa. Anche l’Est ebbe le sue rivolte: la più importante nel 1968 a Praga, contro l’Unione Sovietica. In Cina, negli stessi anni, la Rivoluzione culturale, benché orchestrata e manipolata da Mao Zedong, ebbe come protagonisti i giovanissimi arruolati nelle Guardie rosse, lanciati all’assalto del «quartier generale», con slogan molto simili alla nostra «ribellione contro i padri». L’onda lunga generazionale durò almeno fino al 1977, anno di forti proteste in Italia. Ovunque partorì anche mostri, ideologie violente, larvate guerre civili: l’Italia fu insanguinata negli anni di piombo, la Germania ebbe la Rote Armee Fraktion (nota anche come banda Baader-Meinhof), la lotta armata fece proseliti anche negli Stati Uniti (dalle Black Panther all’Esercito di liberazione simbionese), in Cina è tuttora un tabù il bilancio immane delle vittime della Rivoluzione culturale.
L’aspetto demografico è comunque una chiave interpretativa preziosa. Le società con «troppi» giovani sono intrinsecamente instabili, e i baby boomer erano troppi ovunque. Non a caso, in America, il massimo della conflittualità si registrò fra i giovani neri, con gli scontri razziali che divamparono negli anni Sessanta e Settanta devastando periodicamente le metropoli da Chicago a Detroit: tra gli afroamericani la «bolla» delle nascite del baby boom era stata ancora più grossa che nel resto della popolazione. In Cina, quella della Rivoluzione culturale fu l’ultima generazione con un sovrappiù di giovani; dopo la morte di Mao fu imposta la legge del figlio unico.
Oggi è facile fare del revisionismo storico, riscrivere le nostre vicende giovanili sotto il segno della delusione, o perfino del tradimento. Da apocalittici a integrati, da rivoluzionari a ceto medio, da trasgressori ad aspiranti gerontocrati… Eppure, la portata dei cambiamenti che hanno accompagnato le nostre vite è impressionante. Diritti civili, laicizzazione, liberazione sessuale, accesso all’informazione: chi può davvero rimpiangere «com’eravamo prima di noi»?
Più ancora che nella politica, è nei fenomeni sociali e culturali che la nostra generazione si distingue. Tutto comincia con il rock, la prima musica che è al tempo stesso un gigantesco fenomeno commerciale e la «bandiera ideologica» di una generazione. Tra la Summer of Love di San Francisco nel 1967 e il raduno di Woodstock nel 1969, la musica diventa messaggio politico e occasione di mobilitazioni di massa, business miliardario e controcultura, legittimazione delle droghe e di stili di vita alternativi. Segna le mode (capelli lunghi, vestiti) e lancia dei personaggi icona, capaci di conservare il successo oltre la soglia dei 70 anni. Perfino la religione viene influenzata, con la diffusione di credenze orientali come il buddismo zen. I tratti fondamentali di quella rivoluzione culturale sono definiti una volta per tutte da Daniel Yankelovich, forse il massimo studioso della gioventù americana degli anni Sessanta e Settanta: «Rifiutavano il benessere economico come fonte di libertà e dignità dell’individuo. Rigettavano l’idea che l’istruzione dovesse istradarli verso il successo materiale. Rimettevano in discussione il matrimonio, il lavoro, la famiglia, la chiesa, il patriottismo, la democrazia liberale, la competizione. Sfidavano le autorità: la legge, la polizia, l’accademia, i politici, i capitalisti. Respingevano la morale sessuale tradizionale. In alternativa ai percorsi di carriera usuali esploravano forme di vita comunitarie. Opponevano alla cultura dell’alcol la cultura delle droghe».
La famiglia è l’istituzione primordiale che ha subìto lo shock più di ogni altra. Così Landon Jones riassumeva il ciclone rappresentato dalla nostra generazione: «Appena arrivati alla soglia dell’età in cui ci si sposava, i baby boomer hanno cambiato ogni regola sul corteggiamento e sul matrimonio. Si sono sposati meno spesso dei loro genitori, e mediamente più tardi; hanno avuto meno figli; hanno divorziato molto di più. Nessun’altra generazione ha avuto un impatto così disgregante sul nucleo di base delle società».
Un altro profeta di quel tempo, Charles Reich, in The Greening of America (tradotto in italiano con il titolo La nuova America) metteva l’accento proprio sui cambiamenti di fondo, valoriali ancor più che politici: «Questa non è una rivoluzione come le altre. È una rivoluzione che parte dall’individuo, dalla cultura».
È evidente la contronarrativa che di quegli anni si può fare, ed è stata fatta, da parte dei conservatori e non solo. La trasgressione permanente della Summer of Love e di Woodstock si trasforma ben presto in un poderoso marketing consumistico, il pop tracima negli spot pubblicitari di Coca-Cola e Pepsi, jeans Levi’s e via dicendo. Il rifiuto delle autorità costituite scardina i pilastri dell’ordine sociale, contribuisce a legittimare comportamenti criminali o il terrorismo. La contestazione dell’accademia diventa «voto politico», promozione garantita, scadimento degli standard scolastici, rifiuto della meritocrazia. L’abbandono della religione e del matrimonio tradizionale crea un’epidemia di divorzi che fragilizza le generazioni successive. Il permissivismo sulle droghe alimenta dipendenze, causa un’ecatombe di vittime. A questo si aggiunge il fatto, secondo Jones, di essere stata una generazione «ossessionata dal sesso, impegnata a parlarne, a mostrarlo o a praticarlo in modo quasi maniacale, trasformandolo in uno sport ricreativo».
Queste due narrazioni alternative continuano a opporsi ancora oggi. La guerra delle culture attorno al vero bilancio del baby boom non conosce tregua. Ironia della sorte, quei conservatori che negano ogni eredità benefica della rivolta giovanile degli anni Sessanta e Settanta l’hanno saputa recuperare a proprio vantaggio. L’individualismo antiautoritario dei baby boomer, la ricerca dell’appagamento di sé, il primato della felicità personale, sono il terreno fertile che Ronald Reagan usò per la sua restaurazione conservatrice: non a caso, la sua rivolta anti-Stato. Nello stesso periodo (anni Ottanta) le Tv commerciali di Silvio Berlusconi hanno introdotto in Italia una cultura dell’edonismo amorale che scimmiottava modelli americani.
Figli dei media, sono stati i baby boomer. I primi a essere allevati dalla Tv, con la quale molti di loro hanno passato più tempo che con i genitori. «È la prima generazione di adulti» scriveva Jones «i cui atteggiamenti verso il matrimonio, la famiglia e i consumi furono plasmati durante un’intera vita davanti al televisore.» Siamo il primo gruppo ad aver potuto capire il teorema di Marshall McLuhan: «Il medium è il messaggio». Ci portiamo dietro questa esperienza originaria che ci segna nel nostro interesse ossessivo verso tutti i nuovi media: dal primo entusiasmo per Internet fino alla corsa ad abbracciare iPhone e iPad, Facebook e Twitter, siamo terrorizzati all’idea che i giovani di oggi possano essere più attrezzati di noi a capire «il nuovo Nuovo». Essendo stati abituati a fungere da pionieri per ogni esperimento, ci sembra che da questa funzione dipenda il nostro status.
Nel 1980, Jones concludeva con questa profezia: «Il gruppo che ci ha cambiati più di ogni altro continuerà a farlo finché sarà vivo l’ultimo di loro. Poiché il destino di questa generazione è di adattarsi a cambiamenti che lei stessa ha imposto al mondo, possiamo prevedere che i baby boomer anche da vecchi continueranno a introdurre innovazioni ed esperimenti negli stili di vita, nel lavoro, nella famiglia».
E così sia.
Tra i suoi adepti degli anni Sessanta figurano lo scrittore di fantapolitica Aldous Huxley, gli autori della beat generation Jack Kerouac e Allen Ginsberg. E poi la cantante Joan Baez, profetessa del pacifismo nonché per anni compagna di Steve Jobs. È una Shangri-La inventata nell’Occidente estremo. Si trova in uno scenario di sogno: uno scorcio incontaminato della costa californiana, nella foresta di Big Sur, sopra le scogliere che si affacciano sul Pacifico e si raggiungono percorrendo la Highway 1, la più spettacolare strada americana. Ma, al suo cinquantesimo anniversario, l’Esalen Institute affronta una crisi d’identità, incassa accuse di «commercializzazione» e deve ridefinirsi una vocazione originale.
Dal centro Esalen di Big Sur ha preso avvio una rivoluzione culturale dalle conseguenze profonde sulla società americana e su tutto l’Occidente. Il fascino per le religioni dell’Estremo Oriente era nato prima, con la filosofia romantica tedesca di Arthur Schopenhauer. Ma è a partire dalla fondazione di Esalen, nel settembre 1962, che l’influsso orientale diventa un trend di costume, una moda di massa, contagia lo star system, ispira eventi simbolo come il viaggio dei Beatles in India (sei anni dopo). Guarda caso, è proprio nel 1962 che muore Hermann Hesse, ed è nel decennio successivo che il suo romanzo culto Siddharta vende undici milioni di copie solo in America. È nel laboratorio di Big Sur che il buddismo zen incrocia l’ambientalismo postindustriale, la nascita dell’agricoltura biologica, l’esplosione dello yoga e del tai-chi, la loro fusione con la psicoanalisi junghiana e la teoria della Gestalt. Introducendo innovazioni in questo sincretismo, l’Esalen Institute ha «cooptato» tra le sue dottrine anche l’antica religione dei Maya. Offre corsi di astrologia in cui uno sciamano maya, Miguel Angel Vergara, spiega come il 2012 non possa essere l’anno della fine del mondo, visto che segna «il ritorno del dio serpente, Kukulkán, quindi l’inizio di un’altra New Age, un’era di illuminazione spirituale, perché Kukulkán è l’energia sacra che pulsa all’interno di ogni atomo».
Esalen resta un luogo unico, grazie alla sua fedeltà a un’idea «olistica» della cura del nostro corpo e della nostra mente. Ha conservato la tradizione originaria di una «spiritualità non religiosa», che attira verso la meditazione anche un popolo di agnostici e atei, oltre a seguaci di tutte le fedi del mondo. Ma a mezzo secolo dalla sua nascita, la prima ragione di crisi d’identità sta nel suo successo. Lo yoga ha oltre 16 milioni di praticanti in tutta l’America, a San Francisco come a New York i centri di discipline orientali pullulano in ogni quartiere. Massaggi orientali e agopuntura, medicine ayurvediche e terapie «olistiche», ashram per ritiri di meditazione nella natura: le offerte concorrenti sono ormai dappertutto, che vengano da veri specialisti o da abili ciarlatani.
Diffusione di massa e concorrenza hanno «traviato» Esalen? Basta andare sul sito del centro di Big Sur per vedere che le accuse non sono senza fondamento. I «pacchetti» offerti somigliano molto a quelli di spa resort o beauty farm, centri benessere alternativi ma di lusso. Si parte da 4880 dollari più Iva per un ritiro di 26 giorni (32 ore di «lavoro» alla settimana) che include «sedute quotidiane di yoga, meditazione e pratiche contemplative, movimenti e danza, sessioni di autocoscienza psicologica secondo il metodo Gestalt, arti marziali, coltivazione biologica nell’orto dell’istituto, bagni contemplativi». E accanto alla sistemazione più spartana nelle yurte (tende mongole) ci sono ormai soluzioni più confortevoli e lussuose, previo sovrapprezzo. A fianco di un seminario impegnativo come quello intitolato «Il cuore del buddismo», tenuto da Noah Levine, si trovano anche la possibilità di semplici sedute di massaggi da 165 dollari l’ora e l’accesso in abbonamento alle terme calde per nudisti («si accettano tutte le carte di credito»). Come non bastasse, nella vicina Carmel – celebre per il torneo di golf più esclusivo d’America e per avere avuto Clint Eastwood come sindaco – Esalen ha aperto una succursale «profanata» dall’accesso a Internet e dal permesso di portarsi i telefonini.
L’attuale presidente di Esalen, lo psicologo gestaltico Gordon Wheeler, respinge le accuse e spiega la strategia per il rinnovamento. «Dopo cinquant’anni» dice «puntiamo su una nuova vocazione sociale. Non basta trasformare l’individuo, occorre fare leva sul cambiamento di ciascuno e trasferirlo ai problemi sociali del nostro tempo. Il mondo ne ha bisogno.» Tra i corsi offerti più di recente ce n’è uno che sembra fatto per generare movimenti come Occupy Wall Street. La leggenda continua…