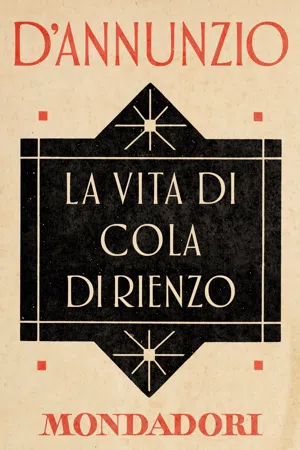1 NOTIZIA SUL TESTO
La biografia del Tribuno viene composta in un torno di mesi assai travagliati sullo scorcio del 1905. La malattia «feroce» di Alessandra di Rudinì ha bloccato a lungo l’attività di d’Annunzio: «giorni di spavento», ricorderà, trascorsi sentendo risuonare «per ore e ore nel mio povero cervello le grida dello spasimo». Avrebbe desiderato cimentarsi di nuovo nel romanzo, ma è il tempo morto delle ricapitolazioni esibite nelle Prose scelte, «libro compendiario» offerto al lettore nel 1906 durante una «sosta» creativa. Nonostante il florilegio, che dovrebbe preludere al ritorno del narratore, a riaffacciarsi è invece il drammaturgo della Nave, anche se poi la tragedia patriottica dell’«amarissimo Adriatico» cede il passo alla Fiaccola sotto il moggio, dramma storico ambientato nell’Abruzzo borbonico.
L’esito è tutt’altro che felice. Il pubblico grida «Parricida!» al figlio Gabriellino che debutta nel ruolo di Simonetto. Ben altre grida – «Arrestate l’autore!» – e un vero e proprio tumulto susciterà di lì a poco Più che l’amore, tragedia romana culminante con l’uccisione dell’usuraio che intralcia i piani di Corrado Brando. E appunto degli usurai, che chiama «scorticatori», d’Annunzio è vittima da anni, cominciando allora a profilarsi la bancarotta che lo costringerà all’espatrio. Non ultima ragione, i debiti rovinosi, del malessere che egli sa notomizzare con distacco quando dice di «avvertire sotto la pelle delle gote, nell’interno delle pàlpebre, nelle gengive il pallore del sangue impoverito, e qualcosa di convulso nella commettitura delle mascelle, e la sorda pulsazione sopra la nuca, e la vitalità febrile del cervello che non pare custodito dalla scatola del cranio ma come sostenuto in alto tra le dita divaricate d’una mano vacillante».
Esaurito e depresso, chi patisce con tanta lucidità la propria condizione ha appena licenziato La vita di Cola di Rienzo, Tribuno fallimentare, vilipeso dalla plebe romana che ne strazia il cadavere, infine «dato alla rabbia dei giudei sozzi che l’ardessero» nel loro quartiere. Visto che si tratta di un esercizio di falso-antico in cui il biografo moderno, fatta eccezione per i due primi capitoli, si limita a trascrivere, riassumendo talora e talaltra ampliando, l’anonima Cronica trecentesca oggi persuasivamente attribuita a Bartolomeo di Iacovo di Valmontone, si segnala l’aggiunta di «sozzi», assente nell’antigrafo. Già vendicativo, d’Annunzio sembra prevedere la spoliazione della Capponcina, la villa leggendaria che abita a Settignano. Il battitore d’asta farà scempio di quanto contiene aggiudicandolo al migliore offerente? Le più fosche previsioni – vedremo – si avverano e non gli resterà che rimpiangere i «belli arredi» perduti, testimoni, specie le scrivanie, della sua più fervida vena: «Non si fenderà un giorno e non renderà sangue o succhio, quel mio buon legname, se tenuto è schiavo da qualche giudìo? E per quante crazie venduto fu dai miei scorticatori […]?».
In tanta angustia e accidenti, inaugurale di una serie di Vite di uomini illustri e di uomini oscuri poi eluse, quella di Cola – si avvertiva – non è se non una riscrittura mossa dall’eccellenza della Cronica redatta nel vivido volgare laziale declassato al rango di dialetto dalla nostra annosa questione della lingua, puntualmente risolta, di secolo in secolo, a favore del fiorentino più e meno illustre. Nella stagione di Francesca da Rimini e delle prime Laudi, quando ha imboccato la via del falso-antico che resta a lungo il suo maggior registro, d’Annunzio la legge in una toscaneggiante trascrizione ottocentesca (La vita di Cola di Rienzo / Tribuno del Popolo Romano / scritta da incerto autore del secolo XIV, ridotta a migliore lezione, / ed illustrata con note ed osservazioni storico-critiche / da Zefirino Re / cesenate: / con un comento del medesimo sulla canzone del Petrarca / Spirto gentil che quelle membra reggi, Le Monnier, Firenze 1854; nella biblioteca del Vittoriale con segni di lettura a matita rossa e blu): uno dei numerosi tesori del «beato Trecento» scandagliato in lungo e in largo sotto la guida esperta, fra gli altri, di un medievista del calibro di Francesco Novati.
Ad attestarne la presenza nell’attrezzatissima officina antiquaria dello scrittore è intanto un colloquio con Silvio Benco, a Trieste, nel maggio 1902, allorché il drammaturgo, che grazie alla Duse ha riscosso un notevole successo nella città giuliana (Città morta, Gioconda e Francesca da Rimini), illustra all’amico giornalista la prosecuzione del ciclo dei «Malatesti» – il progetto di Parisina e di Sigismondo – non mancando allora di profilare «innumerevoli tragedie per l’avvenire […] istorie medievali di Firenze e di Milano e perfino un Cola di Rienzi, rinascita della romanità antica» (nell’«Indipendente», 20 maggio 1902). Tracce malatestiane conducono in effetti d’Annunzio al testo trecentesco, che dedica non pochi capitoli a Galeotto e alle vicende di Cesena, Forlì e Faenza intrecciate con quelle del Tribuno.
Al lettore infallibile nel percepire un capolavoro (e la Cronica lo è) non sfugge la sapida pronuncia sommersa che subito agisce sul poeta delle Laudi. Nelle «pratora» della Tenzone alcionia («Le lodolette cantan su le pratora / di San Rossore») affiora l’analogo di molinora, lucora, ficora, insomma dei vari neutri plurali dell’Anonimo, per non dire che le pagine su Perugia, dove il Tribuno è di stanza prima dell’ultima avventura, trovano corrispondenza nelle Città del silenzio di Elettra in cui rivive la rissosa civiltà comunale: «Maschia Peroscia»… Davvero non peregrina, la lettura della Cronica doveva risultare persuasiva anche sul piano ideologico, trovandovi d’Annunzio materia fertile per proseguire la predicazione del «nuovo Rinascimento» che lo impegna ormai da anni coinvolgendo ogni sua opera.
Il nihil maius della modernità, al culmine della sua militanza d’avanguardia, conta su illustri trascorsi: sui «Rinascimenti anteriori», innanzitutto, dell’età di Pericle e di quella di Leonardo di cui l’Italia è l’erede. Tant’è vero che nella lunga rincorsa per il suo balzo in avanti, i primi tre Libri delle Laudi (Maia, Elettra e Alcyone) recuperano il «Passato augusto» in vista di una «Vita novella» che lo protragga verso più alti traguardi. A ridosso della Vita di Cola di Rienzo, con le 48 quartine del Bronzo e i quattro sonetti A Roma, va poi affacciandosi il quarto Libro, Merope, «tutto dedicato» dichiara il poeta nel 1904 «alla figurazione e alla celebrazione del Lazio». È la bandiera che gli consentirà di succedere a Carducci, il Vate d’Italia ormai morente, e di competere con l’intelligenza d’oltralpe dove sono gli interlocutori che più gli premono. In testa a un movimento come la Renaissance latine, alla «Méditerranée de jadis», che molti rimpiangono, egli va infatti contrapponendo il rilancio, di lungo destino, del mare nostrum e insieme della civiltà rinascimentale che ha tutto da spartire con il basso Medio evo.
Difficile appurare quale sentore d’Annunzio abbia avuto degli studi sul Rinascimento di Warburg o di Burdach, mentre certa è la conoscenza di Pater sin dalla prima giovinezza, e quindi di Burckhardt. Non è comunque da escludere che nel salotto di Berenson, vicino di casa che frequenta assiduamente proprio nel 1905, molto entri in circolazione. A meno che non si tratti di un percorso originale, di cui è lecito dubitare, sono lì i presupposti che lo inducono a scegliere, quando il giovane Tom Antongini fonda in quell’anno a Milano la rivista «Il Rinascimento», la vicenda del Tribuno per i numeri inaugurali (tre puntate, 1° e 15 dicembre 1905, 5 gennaio 1906). Variante del «Leonardo» di Firenze, il «bimensile» milanese è tanto dannunziano che dovrebbe essere diretto dallo stesso d’Annunzio. Il quale si defila non senza però venir meno al compito di imprimervi una linea forte: il Rinascimento ha origine dai fermenti riformatori danteschi, francescani e gioachimiti, e insieme dalle faziose lotte comunali che provocano gare di eccellenza, tanto cruente quanto a vantaggio del progresso.
«Un mondo caldo di natività urgenti» apre non a caso la Vita. Pagine tutte di d’Annunzio, assenti nel biografo antico; e pagine capitali, in cui risiede il senso della rilettura della Cronica. Guerra e stragi, congiure e tirannide, esilio e delitti non configurano secoli bui ma una temperie ferace in cui, «imbevute di sangue», «le radici innumerevoli delle genti» producono «alla cima dell’arbore umana fiori più larghi, frutti più pesanti»: la stessa umanità fitomorfa – i caduti saranno il concime e i mutilati la potatura – destinata a ricomparire con insistenza durante la Grande guerra che il poeta-soldato saluterà infatti come catastrofe salutare, alba di un mondo nuovo.
Solo a tratti artisticamente risolta, scritta a contraggenio, la biografia dannunziana mette tuttavia a nudo procedimenti compositivi di spiccato interesse, senza contarne l’antiveggenza, fino allo sconcerto, della parabola del biografo. Con miglior fortuna, è vero, nell’epilogo, perché non a lui toccherà di essere appeso «per li piedi»; e tuttavia i discorsi alla ringhiera del Campidoglio («con savie e ordinate parole come quegli che era di retorica ordinato maestro»), e le «strane pompe» ripescate dall’«esploratore di antichità avvedutissimo», e i gonfaloni rossi con la ridda di simboli nella parata («in aspetto di processione più che di ribellione») che conducono Cola al potere senza colpo ferire, predicono a oltranza – caricaturali – eventi di là da venire. E ancora più sconcertante è la condanna del Tribuno, senza appello, tanto immediata e aggravata rispetto al giudizio dell’Anonimo da comprometterne la verosimiglianza. Ritraendolo come il guitto di un’atellana, d’Annunzio si sbizzarrisce nel repertorio ingiurioso: chi «reca messaggi» invece di «condurre eventi», «assai più famigliare con gli inchiostri e coi vini che col buon succo delle vene virili», è «spirito ossesso», «aborto ventoso», «tabellione remunerato», «notaro smanioso», «villan rifatto», «giuntatore», «ciarlone tronfio», «falso eroe», «ciurmadore», «retore fatuo», «mimo», «cialtrone», «spocchione», «uom delirante», «pusillo», «folle figuratore», «istrione stracco e rauco», «rètore sgonfio», «spirito ventoso e caliginoso», «industre gonfianùgoli», «cianciere floscio», «paone tronfio», «beone», «sbracato plebeo», «manigoldo», «matto villano», «sozzo can traditore», «poltrone».
Cominciamo a mettere a fuoco le modalità della riscrittura, secondo un andamento doppio ormai collaudato: alla replica del testo antico si somma la replica dell’apparato che lo introduce e lo accompagna. Perché d’Annunzio è sì uno «spulciatore di vietumi», come ama qualificarsi, ma lascia ad altri la fatica delle indagini d’archivio che conducono ai reperimenti e all’edizione degli amatissimi «testi di lingua». Perciò intrattiene stretti rapporti con eruditi e filologi che ruotano intorno al «Giornale storico» ricavandone indicazioni preziose, intanto, sulle ricerche in corso; saprà quindi profittare della poderosa strumentazione attraverso cui i reperti vengono di volta in volta datati, attribuiti e interpretati.
È certo questo il canale attraverso cui egli raggiunge il capolavoro dell’Anonimo, lo stesso che ha percorso per provvedersi di repertori, manuali, volgarizzamenti o lessici speciali in forze nel suo laboratorio. È pertanto probabile che il dibattito intorno alla canzone petrarchesca Spirto gentil (RVF LIII), così decisivo per Zefirino Re, l’editore della Cronica, abbia attratto d’Annunzio fino a persuaderlo alla replica. Stando anche ai primi due capitoli introduttivi, il punto di vista moderno è dichiarato, concretizzandosi poi, lungo il corso della biografia, nella continua commistione fra testo trecentesco e apparato erudito. Vestiti così i panni del filologo, egli aggiungerà di suo la perizia diegetica, nella mescolanza dei due piani, che si giova di tecniche ed espedienti provati e riprovati.
Il «but de l’oreille» di chi ha letto il romanzo naturalista con l’acribìa del narratore impegnato – dalle novelle giovanili al Fuoco – a produrre pagine competitive rispetto a Verga, Zola, Flaubert, Maupassant, Dostoevskij, si avverte in ogni capitolo della Vita, dove la trama del racconto è giocata su continue riprese, su prolessi e analessi, sull’indiretto libero o sulla sineddoche che di frequente introduce il personaggio. È la costruzione strutturale ad attualizzare La vita, più ancora degli anacronismi che la prevaricano (ad es.: «Il fuoco e la morte, le due purità del mondo») o degli scorci paesistici di consumata abilità descrittiva. Così, la Maiella, sulle cui cime Cola si traveste da eremita, è «Altare di sacrificio e d’implorazione tra i più venerandi, sollevato dall’ansia dello spirito sotterraneo verso i cieli troppo remoti», mentre l’Agro e Roma contano su trascorsi senza i quali non avremmo una resa tanto suggestiva della loro grandezza: «scorgevasi la faccia travagliata dell’Urbe con le sue basiliche e i suoi chiostri, con le sue terme e i suoi circhi, con i suoi archi imbertescati e i suoi fori trincerati, col biancicore dei suoi marmi mezzo sepolti su cui le opere di mattone rosseggiavano quasi fossero costrutte di grumo impietrato».
Quanto al linguaggio, riscrivendo la miglior lezione di Zefirino Re, d’Annunzio ne accentua il timbro toscaneggiante immettendovi una notevole quantità di dantismi. Iniziativa, anche questa, già consumata nelle Laudi e in Francesca da Rimini da cui viene tratto il repertorio pronto al riuso – repertorio sicuro quando si abbia di mira il falso-antico medievale: «grifagno», «macro», «imaginativa», «Roma vedova», «con le unghie e co’ rostri», «belletta negra», «epa enfiata». Del resto va da sé che l’Anonimo conosca Dante. L’episodio dell’idropico con l’«epa» come «liuto» (I, 11) induce a crederlo, tanto è simile al falsario del XXX canto dell’Inferno; come non è certo che l’Anonimo conosce Petrarca, così...