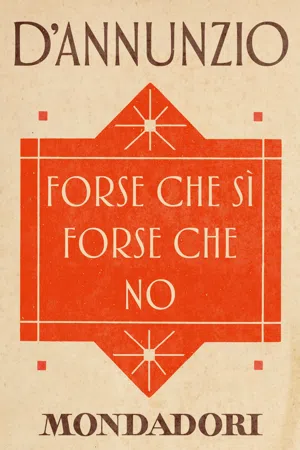![]()
1 NOTIZIA SUL TESTO
Negli anni immediatamente precedenti il primo conflitto mondiale si afferma in Europa, accanto ad altre forme narrative, il romanzo d’avventura che in Francia, in particolare, assume – ad ascoltare il Thibaudet delle Réflexions sur le roman, (Paris, 1938) – una fisionomia da genere misto, con la contaminazione di «aventure» e «romanesque».
Non è il caso di ricordare quanto d’Annunzio fosse attento agli eventi letterari francesi. Certamente la crisi del romanzo naturalistico, simbolistico, psicologico, ha una parte non piccola anche sul silenzio ideativo che il lungo intervallo tra il Fuoco e il Forse che sì forse che no consente di rilevare: si fa strada infatti in quegli anni, secondo il critico francese, un problema di energia, un problema di azione, che la generazione letteraria del decennio 1900-1910 non può non avvertire.
Sarebbe arbitrario attribuire a d’Annunzio la conoscenza, o anche solo l’interesse, per le teorie attualissime di Bergson (1907 è datata l’Evolution créatice) o di James, il cui pragmatismo riceve consacrazione ufficiale in quello stesso anno. Ma certo la concezione della vita come slancio, della coscienza come azione, dell’esperienza come mutamento e movimento riempie di sé una produzione narrativa corposa pur se di qualità non elevata, pubblicizzata comunque in quotidiani e riviste francesi a d’Annunzio ben noti, dall’«Echo de Paris» al «Gaulois», dal «Mercure de France» alla «Revue des Deux Mondes» o alla «Nouvelle Revue Française». Le sintesi, informatissime, non mancano: le elenca di recente, con abbondanza di citazioni e scrupolo documentario, il Raimond de La crise du roman (Paris, 1966), che giudica, per parte sua, la crisi del primo decennio del Novecento particolarmente grave per le sorti future del romanzo («On parlait beaucoup de la décadence et de la mort prochain du roman […]»), perso tra innumerevoli direzioni (il romanzo collettivo, il romanzo sociale o d’evasione, tra finto realismo e psicologia di bassa lega).
In ogni caso, contro il romanzo «idéaliste», si sviluppa – come sostiene in quegli anni anche Rivière – un romanzo di atti, fatti, avvenimenti: un romanzo necessariamente lungo e complesso, il «roman-dossier» al posto, o a fianco, del «roman-poème».
La riflessione consente di ritornare al Forse che sì forse che no: se la genesi della nuova fatica dannunziana è, come sempre, complessa e contraddittoria, non c’è dubbio che la novità del nuovo romanzo (quasi romanzo di romanzi) sia costituita proprio dal tentativo di attingere alla cronaca e alla attualità, moltiplicando i punti di vista a partire dalla sostituzione del protagonista unico: e non sosteneva Gide proprio nel 1911, nella prefazione a Isabelle, la necessità di un romanzo come «oeuvre déconcentrée»?
Quanto sia deconcentrato il lungo romanzo dannunziano, residuo, lo anticipiamo subito, di un ben più impegnativo progetto, sarà oggetto di verifica: importa però prendere atto di un clima comune, di una esigenza precisa di rendere, nella scrittura, la presenza e immanenza di avvenimenti il più possibile multipli attraverso personaggi legati mani e piedi «à la merveilleuse anxiété de vivre» (ancora Rivière, Le Roman d’aventure).
L’ansia di vivere, per il d’Annunzio del 1909-1910, si connetteva a precisi segnali: l’automobile, l’aereo, i mostri meccanici al centro dell’ideologia del moderno (e Romanzo dell’ala avrebbe dovuto sottotitolarsi l’avventura di Paolo Tarsis secondo il progetto di nuova edizione concordato tra lui e il Bruers nel 1936). Non si può non pensare al manifesto appena uscito sul «Figaro» di Parigi, a sancire la nascita del movimento futurista (20 febbraio 1909): ma occorre anche guardarsi dalle facili connessioni. Più significativo, certamente, può risultare l’accostamento a un precursore del movimento marinettiano, il Mario Morasso della Nuova arma. La macchina (Bocca, Torino 1905) o del Nuovo aspetto meccanico del mondo (Hoepli, Milano 1907). Amico e recensore di d’Annunzio, è portavoce, infatti, di una modernolatria tutta particolare, vicina da una parte agli ideali estetizzanti del «Marzocco» (la macchina «monumento moderno», luogo di bellezza), dall’altra trasgressiva, affascinata dal nuovo culto della velocità e tuttavia egoarchica, contemplativa insieme e imperialistica.
Un sincretismo influente su d’Annunzio: meno abile in sistematizzazioni intellettuali ed estetiche: anche il Forse che sì è luogo di contrari, spazio ampio in cui la tradizione convive col nuovo, la citazione con l’accadimento cronachistico. Né poteva essere diverso l’esito di un progetto condotto avanti tra tanti ripensamenti, con scarsa convinzione compensata come sempre da reboanti dichiarazioni epistolari: «È un romanzo di passione mortale» leggerà Emilio Treves in una missiva del 30 agosto 1908 a lui indirizzata «al cui paragone quelli della Rosa sembreranno tiepidi e timidi. Certo fu grande e sincera la mia audacia nel Trionfo della morte; ma la mia temerità presente è senza limiti, esercitata tuttavia con un vigore contenuto e di severa apparenza. Tanti anni di sintesi drammatica hanno dato al mio stile una sobrietà potente e sprezzante».
La lettera, di grande fascino, dovrà essere rimeditata, poiché vi si parla, più oltre, di stile muscolare, di animalità tenacemente perseguita, di bellezza palpabile. Ma intanto c’è da chiedersi come e attraverso quali gradi d’Annunzio sia pervenuto a quelle affermazioni.
Si muove, come sempre, da prove di titoli, che da sole potrebbero costituire il grande mosaico dell’incompiuto dannunziano: lasciati interrotti i cicli del Giglio e del Melagrano, dopo isolate confessioni a Hérelle circa l’intenzione di comporre un romanzo estraneo ai raggruppamenti già previsti (lettera del 1° novembre 1904 da Marina di Pisa) e a Emilio Treves, esuberante di tensione non metaforica (1° gennaio 1905: «In aprile mi rimetterò al romanzo con la trepidazione di un uomo che si riavvicini all’amante abbandonata. So, per esperienza, che, in questi casi, il primo amplesso è formidabile. Spero nella più vigorosa erezione per farmi perdonare l’infedeltà»), si assiste, di fatto, a un indugio compositivo protratto sino al 1907.
Si accumulano, nel frattempo, gli annunci, a partire da un’Amaranta, romanzo nuovo di d’Annunzio dichiarato dal «Corriere della Sera» dell’8 ottobre 1905 in uscita presso la Libreria Editrice Lombarda di Tom Antongini e Arnaldo De Mohr, con indicativi accenni all’assenza di personaggi autobiografici e all’ambientazione «tra le forme più nuove dell’attualità» (quella del circo, per ora, con le esibizioni di automobili «entro l’anello della morte»). Di prova in prova, tra novelle destinate a volumi mai realizzati (degli Assassini si parla in una lettera all’Antongini del 16 ottobre) e dilatate, immaginosamente, sino alla dimensione del romanzo (la Madre folle descritta il 12 novembre sempre all’Antongini e annunciata dalla rivista «Il Rinascimento» il 20 dello stesso mese), o altre depistanti rivelazioni (a un terzo romanzo «già ideato e intitolato» accenna di sfuggita un’ulteriore missiva all’Antongini dell’inizio di gennaio 1906) si rischia davvero di smarrire il filo.
Esiste infatti, da una parte, una sovrabbondanza di documenti (e si deve al Roncoroni il merito di averli pazientemente rintracciati e descritti); dall’altra la certezza di una reale crisi di ispirazione, che induce a fantasticare su ipotesi senza futuro. Si ha come sempre l’impressione che, al di là degli scopi propagandistici di uno scrittore ben attento a non lasciare impallidire la propria immagine, la girandola di invenzioni trasformi le lettere in luogo dei possibili, non senza incidenza, magari, sulle realizzazioni a venire. Come se d’Annunzio dialogasse, oltre che con un interlocutore da convincere, con se stesso; e in quel dialogo tutte le prove di scrittura esibite diventano poi l’unico modo reale, per lo scrittore delle esibizioni, di portare avanti una poetica che si caratterizza sull’accumulo e la esteriorizzazione.
L’Amaranta e la Madre folle costituiscono in ogni caso l’oggetto privilegiato degli scambi epistolari con l’Hérelle, l’Antongini, il Treves sino all’aprile del 1907, intercalandosi con notizie relative alle altre opere in cantiere (le Prose scelte, le Vite, la tragedia Più che l’amore…). Giunge pertanto inaspettato, in apparenza, l’annuncio al Treves del 5 giugno 1907: «Sto scrivendo un romanzo delizioso e breve come una stagione di primavera, sotto il titolo Forse che sì forse che no».
Non si deve pensare che la definizione del titolo corrisponda a una definita e già stabile struttura. Intanto si oscilla ancora nella scelta del genere tra «récit» e «roman», per dirla col Gide così attento, in quegli anni, alle sottili distinzioni. Nel giro di pochi giorni il tenore di una missiva al Treves è infatti subito diverso: «Ecco la mia estate» lo informa d’Annunzio il 10 giugno 1907 «Forse che sì forse che no veramente non è un romanzo ma una lunga novella abbastanza importante per occupa...