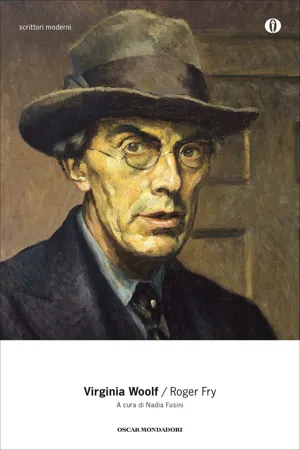![]()
![]()
I
«I primi sei anni della mia vita li ho vissuti in una casetta settecentesca al n. 6 di The Grove, Highgate. Quel giardino è tuttora per me lo sfondo immaginario di tutti, o quasi, i giardini che incontro nei libri» – così Roger Fry iniziava un frammento di autobiografia. Fermiamoci un istante sulla soglia di quella casetta di Highgate per chiederci che cosa si riesca a sapere di lui, prima che prendesse coscienza del serpente che si spencolava «dalla forca del ramo del vecchio melo particolarmente rinsecchito e fuligginoso» e dei «grandi, orientali papaveri rossi che per un caso fortunato» crescevano nel suo «personale e privato giardino».
Nacque il 14 dicembre del 1866,1 secondogenito di Edward Fry e di Mariabella, figlia di Thomas Hodgkin. Entrambi quaccheri.2 Prima di Roger, dal lato paterno, si contavano otto generazioni di Fry, a partire da quello Zephaniah, il primo a farsi quacchero, nella cui casa nel Wiltshire George Fox tenne «una riunione molto pia e pacifica, anche se gli ufficiali pubblici avevano intenzione di intervenire e interromperla, ed erano a tal fine già per strada quando, prima che arrivassero, ricevettero la comunicazione che dei ladri avevano appena fatto irruzione in una abitazione, e furono richiamati indietro con urgenza...». Era il 1663, e da quel momento in poi i Fry si professarono quaccheri e adottarono un certo modo segnatamente eccentrico nel pensare e nel vestire, per il quale, a quei tempi, subirono notevoli persecuzioni. Il primo di loro, Zephaniah, rimase per tre mesi in prigione per aver rifiutato di prestare il giuramento di obbedienza. Col passare del tempo la persecuzione si allentò; le sofferenze si limitarono allo «scherno e alla freddezza da parte della loro stessa classe»; ma qualunque cosa subissero, mantennero le loro convinzioni con assoluta coerenza. L’ingiunzione “Non giurare affatto” significava che non si poteva prestare alcun giuramento, e perciò molte professioni erano loro precluse. Alcuni dei Fry aggiunsero di loro propria iniziativa ulteriori scrupoli. Persino la professione della medicina era sgradita a Joseph, il nipote di Zephaniah, perché «non poteva non sentirsi a disagio accettando un pagamento per l’acqua contenuta nelle medicine che dispensava». Tali scrupoli – «squallidi problemi di abiti e abitudini», come Edward Fry li chiamava – tormentavano gli animi più deboli e li esponevano al ridicolo. Oscillarono sempre tra i due mondi. Uno stemma fu dapprima inciso e poi raschiato via; si ordinava della biancheria pregiata e poi la si tagliava in stracci; un tal John Eliot si ficcò in testa di offendere i costumi settecenteschi lasciandosi crescere la barba. Le arti, come le professioni, non erano ammesse. Erano proibiti non solo il teatro, ma anche la musica e il ballo; e benché «il disegno e l’acquerello fossero tollerati o incoraggiati», l’incoraggiamento era tiepido, dato che, con alcune importanti eccezioni, ancora nel diciannovesimo secolo l’unico quadro che si poteva trovare in una casa quacchera era una stampa del Trattato di Penn con gli indiani – un quadro disgustoso, come lo definì in seguito Roger Fry.
Senza dubbio la società quacchera, come scrive uno dei suoi membri, era «di vedute molto ristrette e di interessi limitati; molto borghese nel tipo di partecipanti». Ma il fatto stesso di canalizzare una così grande quantità di energie entro limiti tanto ristretti portò a risultati notevoli. La storia di Joseph Fry è la tipica storia di molti Fry. Poiché, per i suoi scrupoli, la professione medica gli era preclusa, «si diede agli affari e fondò, o contribuì a fondare, cinque imprese importanti, che si rivelarono probabilmente molto più remunerative della professione cui aveva rinunciato per motivi di coscienza». Di qui derivò una curiosa anomalia: le meno mondane tra le genti furono nondimeno ampiamente benedette dai beni mondani. Il commerciante che abitava sopra la propria bottega a Bristol o al Bartholomew Close era al tempo stesso un gentiluomo di campagna con ampi possedimenti in Cornovaglia o nel Wiltshire. Ma era un gentiluomo di tipo speciale. Era un signore che si rifiutava di pagare le decime; che si rifiutava di andare a caccia e di sparare; che si vestiva diversamente dai suoi vicini, e che, se si sposava, sposava una quacchera come lui. Così i Fry e gli Eliot, gli Howard e gli Hodgkin non solo vivevano diversamente e parlavano diversamente dagli altri, ma le diversità erano rinsaldate da innumerevoli matrimoni incrociati. Ogni quacchero che si sposava «fuori dalla società» era ripudiato. Di generazione in generazione perciò i figli di una famiglia quacchera sposavano le figlie di un’altra famiglia quacchera. Mariabella Hodgkin, la madre di Roger Fry, proveniva dal medesimo ceppo fisico e spirituale di suo marito, Edward Fry. Discendeva dagli Eliot che, come i Fry, erano quaccheri già nel diciassettesimo secolo. Anche loro avevano scansato la carriera pubblica, accumulando ricchezze considerevoli prima a Falmouth come mercanti «esportatori di sardelle e stagno a Venezia», e in seguito a Londra, dove possedevano una grande casa di famiglia in Bartholomew Close. Gli Eliot sposarono gli Howard, che erano fabbricanti di stagno, anche loro quaccheri. E fu con il matrimonio di Luke Howard, figlio di Robert, il fabbricante di lamiera stagnata in Old Street, con Mariabella Eliot, che entrarono in famiglia gli unici due nomi tra tutti quelli della ricca cronaca familiare per i quali il loro discendente Roger Fry mostrasse un qualche interesse. Il suo bisnonno, Luke Howard (1772-1864), era un uomo dal «genio brillante, ma piuttosto eccentrico» che, come molti altri Amici, essendogli negata ogni altra prospettiva, volse i suoi interessi alla scienza. Fu autore di un saggio che si proponeva «la classificazione e nomenclatura delle nuvole», che colpì l’attenzione di Goethe, il quale non solo scrisse un poema sull’argomento, ma si mise in contatto con l’autore. Mariabella Hodgkin ricordava il nonno. Sembrava, scrive, «che pensasse sempre a qualcosa di remoto... Si fermava a lungo alla finestra intento a osservare il cielo con quel suo placido sguardo sognante» e come altri tra i suoi discendenti «era un esperto di motori» e insegnò ai nipoti, nella propria officina, come manovrare pompe d’aria e macchine elettriche. Roger Fry lasciò intonsa la sua copia della storia di famiglia, ma ammetteva che avrebbe voluto saperne di più di questo ingegnoso antenato, il cui dono nello stimolare le menti altrui con speculazioni mai «del tutto confermate dalle osservazioni successive» suggerisce un’affinità di temperamento, oltre che di sangue. L’altro nome che attraeva l’attenzione di Roger Fry, anche se per motivi diversi, era quello di sua madre – Mariabella. La prima a chiamarsi così fu nel diciassettesimo secolo la figlia di un tale Blake, che sposò un Farnborough, la cui figlia sposò un Briggins, la cui figlia sposò un Eliot. Era un nome con un che di misterioso, «di origine chiaramente italiana o spagnola», e Roger Fry, che non si interessò mai agli Eliot, né a un loro possibile legame con gli Eliot di Port St Germans, o ai Weston e alla loro possibile ma improbabile discendenza da Lord Weston, conte di Portland, amava pensare che la sua ava, la prima Mariabella, dovesse il nome a un qualche legame con il Sud. Sperava che il sangue tranquillo e rispettabile dei suoi innumerevoli antenati quaccheri si fosse contaminato con una razza più focosa. Ma era solo una speranza. In più di duecento anni non c’è scandalo che si registri nella famiglia degli Eliot. Sua madre, Mariabella Hodgkin, la settima a portare quel nome, era una quacchera purosangue come tutti gli altri; e fu a Lewis, nella Casa degli Amici, in un chiaro giorno primaverile nell’aprile del 1859, che Edward Fry la sposò e se la portò nella casetta di Highgate.
Quella casa, scriveva Edward Fry, «affacciava sul giardino di Holly Lodge, della signorina Burdett-Coutt, e oltre, sui tetti di Londra... il nostro giardinetto, con un faggio rosso in un angolo, scendeva fino agli alberi del nostro vicino, e ci era molto caro in quei giorni lontani. Era un piccolo appezzamento
Non del tutto nel mondo affaccendato, né
proprio oltre.3
E il brusio della grande città* sotto di noi spesso saliva fino su in collina e ci ricordava quanto fossimo vicini al grande cuore di tutto». Fu in quella casa che gli nacquero nove figli; e in quel giardino il figlio Roger provò la sua prima passione e subì la sua prima grande delusione.
Quel giardino [scriveva Roger Fry] è tuttora per me lo sfondo immaginario di tutti, o quasi, i giardini che incontro nei libri. Tuttora il serpente si spencola verso Eva dalla forca del ramo del vecchio melo particolarmente rinsecchito e fuligginoso che cresceva in mezzo al prato. E numerose altre scene di seduzione mi sembra si siano svolte entro i suoi modesti, periferici confini. Ma fu anche il teatro di due enormi esperienze emotive, la mia prima passione e la mia prima grande delusione. La mia prima passione fu per una rigogliosa pianta di papaveri orientali rossi che per un caso fortunato si trovava proprio dentro il perimetro della mia aiuola, l’aiuola che mi era stata concessa come mio personale e privato giardino. Le piante che compravo e incollavo in terra col fango che impiastricciavo con l’annaffiatoio e una forma da giardino; i semi che piantavo – mai che mi soddisfacessero; anzi, di solito si rifiutavano proprio di crescere. Invece i papaveri erano sempre al di sopra dei miei sogni più azzardati. Il loro rosso era sempre più rosso di qualsiasi cosa potessi immaginare, quando guardavo altrove. Avevo una passione per il rosso in genere; il che, quando sviluppai un romantico attaccamento alle locomotive, mi spinse a credere di aver visto una volta una «locomotiva tutta rossa». La pianta di papavero era comunque oggetto da parte mia di una adorazione molto più sincera di quella che sapevo offrire al “buon Gesù”, e di un affetto credo più forte di quello che provassi per chiunque altro, eccetto mio padre. Ricordo una volta in cui la pianta era colma di grassi boccioli verdi, con dei piccoli lembi di seta rossa spiegazzata che spuntavano dalle fessure tra i sepali. Alcuni erano già in fiore. Mi misi in testa che niente al mondo potesse essere più emozionante che vedere il fiore che d’improvviso schiantava il guscio verde e schiudeva il suo immenso calice rosso. Congetturai che ciò sarebbe avvenuto tutto d’un tratto e dunque bisognava solo avere pazienza per poter assistere all’evento. Così una mattina rimasi a guardare un bocciolo promettente per ore e ore, ma non succedeva niente e mi stancai, così di gran fretta, per paura di tornare troppo tardi, corsi in casa a prendere uno sgabello e lì seduto continuai a stare di guardia per un tempo che mi sembrò un’eternità ed era forse mezz’ora. Alla fine fui scoperto da una mia sorella più grande e debitamente preso in giro da lei e da tutti gli adulti, quando la storia fu resa nota, perché tutte le passioni, compresa quella per i papaveri rossi, ci espongono al ridicolo.
L’altro evento fu più tragico. Fu l’orribile scoperta che la giustizia non è suprema, e l’innocenza non protegge. Era di nuovo una mattina d’estate e io stavo appoggiato alle ginocchia di mia madre, la quale, seduta su una bassa sedia di vimini, mi istruiva sui primi rudimenti di botanica. Al fine di illustrarmi una qualche questione mi disse di portarle uno dei bocci della mia adorata pianta di papavero o almeno così a me sembrò che dicesse. Ero già addestrato all’obbedienza implicita e benché a me apparisse un atto quasi sacrilego, lo eseguii. Evidentemente...4
Qui il frammento si interrompe. Ma il seguito è noto – colse il papavero e fu severamente rimproverato dalla madre per averlo fatto. Il disappunto fu enorme. Perché se era credulo e appassionato, era anche «addestrato all’obbedienza implicita»; e la persona che prima aveva preteso l’obbedienza e poi per questo lo aveva punito era sua madre. La ferita di quell’esperienza sconcertante bruciava ancora cinquanta anni più tardi. Era affine a molte altre dello stesso genere che sarebbero seguite; ma il fatto che la prima grande delusione fosse legata alla madre spiega forse l’acutezza e la persistenza dell’impressione. Lady Fry esercitava su quel ragazzo molto impressionabile e sensibile, ma anche molto logico e indipendente, un’influenza che durò ben oltre le lezioni di botanica. Come si vede dalle fotografie, era una donna di forte presenza fisica, dai bei lineamenti – le labbra risolute, il corpo vigoroso. La tradizione vuole che fosse una ragazza vivace, amante del divertimento, e capace di suscitare ammirazione, nonostante la sobrietà di stile della vita quacchera, specie degli abiti quaccheri, ancora in uso tra gli Hodgkin quando lei era giovane. Avanti negli anni – visse fino a novantasette anni – compilò un elenco di «Cose che non esistevano – Cose che esistevano: quando ero bambina». È un elenco istruttivo. Tra le cose che non esistevano elenca gli zolfanelli, le borse dell’acqua calda, le lampade da notte, gli alberi di Natale, i tabelloni della pubblicità, gli anemoni giapponesi, i materassi a molle, il gas anestetico per l’estrazione dei denti. Tra le cose che esistevano, cita la silice e l’acciaio, le candele di giunco, le prugne secche e la senna; gli zoccoli e le soprascarpe, i sagrestani e le carrozze; le stole e i manicotti (in pezzo unico); le tabacchiere e i Cartisti. Lei non ne trae nessuna conclusione; lascia dunque a noi dedurre che nella vita della ragazzina quacchera c’erano più privazioni che gioie, più austerità che lussi. Un aneddoto che ci racconta sulla sua infanzia conferma questa impressione. «Per l’occasione [una malattia che ebbe all’età di quattro anni] uno zio particolarmente gentile mi portò in regalo un graziosissimo servizio da tè (che ancora conservo) e me lo diede mentre me ne stavo nel mio lettino. Benché sicuramente lo desiderassi, chiusi gli occhi risolutamente, pervicacemente, e nonostante le lusinghe e i comandi mi rifiutai di aprirli. Lo zio se ne andò, il servizio da tè fu certamente portato via e io scomunicata con proclamata disapprovazione. Fu senz’altro una di quelle segrete inibizioni che sono parte dell’infanzia, frutto probabilmente di una violenta timidezza.» Erano anche altre le inibizioni specifiche dell’infanzia quacchera; fino alla fine della sua esistenza, si ricordò che una volta suo padre le aveva ordinato di staccare dal vestito che portava le maniche strette che allora andavano di moda, e di attaccarci invece delle maniche larghe, del tutto fuori moda, così che per strada dei ragazzacci l’avevano canzonata facendole: «Quac! Quac!». Essendo per natura molto timida e sensibile, l’effetto su di lei di tale educazione fu permanente. Dette sempre l’impressione di vivere tra due mondi, senza appartenere a nessuno dei due. Non sorprende perciò che quando il suo secondo figlio era piccolo, gli occhi le rimanessero saldamente ma penosamente chiusi alle cose che erano per lui oggetto di un’adorazione molto più sincera di quella che sapeva offrire al «buon Gesù» – papaveri rossi, locomotive rosse, e boccioli verdi con piccoli lembi di seta rossa spiegazzata che spuntavano dalle fessure tra i sepali. Eppure lui la rispettava, addestrato com’era a «un’obbedienza implicita».
Il giardino in cui ricevette la sua lezione sui primi rudimenti di botanica era circondato da altri giardini. Sotto si stendeva Kenwood, allora proprietà di Lord Mansfield; il quale Kenwood sconfinava nelle colline di Hampstead. Highgate in sé era un paesetto; e anche se, come diceva Sir Edward Fry, il brusio di Londra saliva su fino in collina, l’accesso alla grande città era difficile. Solo «un omnibus saltuario» li collegava. I «paesani» erano ancora isolati, ed esaltati. Si consideravano ancora una razza a parte. Quando Roger era bambino, il vecchio barbiere che aveva tagliato i capelli a Coleridge esercitava ancora il suo mestiere e rammentava sempre la loquacità del poeta – «Eccome, se parlava!» ripeteva; ma non era in grado di dire di che cosa. Si erano naturalmente formate delle associazioni locali. C’era una società degli scacchi, una società letteraria e una scientifica. La società di lettura si riuniva «una volta ogni tre settimane per leggere ad alta voce brani scelti da opere classiche... Tè alle 7, sandwich e frutta alle 10... e se qualche sciagurata signora, per ignoranza o poco cervello, avesse messo in tavola per cena crema e gelatine avrebbe sicuramente avuto in cambio un gentile rimprovero per la trasgressione». Qualche volta la Società si radunava dai Fry; e la guida spirituale – Charles Tomlinson, membro della Royal Society – un gentiluomo infaticabile ed erudito le cui pubblicazioni spaziano dallo Studio sul sale comune a traduzioni di Dante e Goethe, fino a opere sugli scacchi, sulla pneumatica e sull’acustica, compreso un Inverno nelle regioni artiche – se capitava di domenica sera, ascoltava anche lui Sir Edward che leggeva ai bambini il Paradiso perduto o i Diari di George Fox o un libro di Dean Stanley. Finita la lettura, Tomlinson conversava in modo incantevole, anche se per loro incomprensibile, coi bambini. E poi li invitava al tè da lui. Mostrava loro tutte le meraviglie della sua «tana». La piccola stanza, come si addiceva alla molteplicità degli interessi del proprietario, era piena di oggetti affascinanti. C’era un congegno elettrico; un’armonica; e la pila di Chladni – un’invenzione grazie alla quale la sabbia, al suono di un violino, assumeva delle forme meravigliose. Il gusto che Roger ebbe tutta la vita per gli esperimenti scientifici dev’esserne stato stimolato. La scienza, del resto, era parte dell’atmosfera di casa; l’arte «era tenuta al suo posto»; cioè, si visitava rispettosamente l’Accademia; e un paesaggio, se registrava fedelmente lo scenario di una vacanza estiva, veniva doverosamente acquistato. Così proprio attraverso Charles Tomlinson forse Roger Fry si rese conto per la prima volta di quei problemi estetici che gli sarebbero diventati in seguito tanto familiari. In quanto autore della Enciclopedia delle arti applicate Tomlinson aveva accesso ad alcune fabbriche, e portò con sé i piccoli Fry a visitare quella di candele Price, le vetrerie Powell e una fabbrica dove si tagliavano i diamanti a Clerkenwell. «Queste visite in fabbrica» scrisse la sorella di Roger, Agnes «suscitavano domande di tipo nuovo; in che cosa consistesse la buona e la cattiva arte, che tipo di ornamento fosse giustificato, e se l’uso migliore dei diamanti non fosse per i macchinari, piuttosto che per le collane. Egli ne era decisamente convinto: una spilla, diceva, può essere utile, ma un medaglione per lui era abominevole.» L’opinione di Roger riguardo cosa distinguesse l’arte buona da quella cattiva sfortunatamente non ci è riportata. Sempre grazie a Tomlinson, che era in buoni rapporti con il giardiniere capo, ogni primavera facevano una passeggiata nei boschi strettamente privati di Lord Mansfield – quel «Paradiso terrestre che vedevamo tutto l’anno dal nostro giardino, accanto al quale passavamo quasi ogni giorno, e che per una deliziosa mattina di maggio sembrava fosse nostro». Così Agnes Fry descriveva Kenwood; e Kenwood, come si vede da un altro frammento autobiografico, aveva un posto speciale anche nella memoria di Roger; non era però il ricordo delle passeggiate nel bosco a primavera, ma dei pattini d’inverno.
Un giorno di gennaio nel 1929, racconta, stava sonnecchiando quando
improvvisamente ebbi la visione5 nitida di mio padre che pattinava. Doveva essere intorno agli anni ’70, forse il ’74, e il luogo uno dei laghetti nel parco di Lord Mansfield a Kenwood, ora pubblico, ma allora completamente privato. Solo quando i laghetti gelavano le famiglie benestanti di Highgate, di cui facevamo parte anche noi, erano ammesse con un biglietto. Era un luogo meraviglioso, con i faggi che costeggiavano il bordo del laghetto, che quell’inverno erano tutti fioriti di lunghi aghi di brina, e scintillavano rosati nel basso sole invernale. Mio padre era lì, su un paio di pattini antiquati persino per quell’epoca, dei bassi pattini di legno con una lunga lama che sul davanti finiva in una elegantissima punta, esattamente come quelli che si vedono nei dipinti olandesi. Noi in parte li disprezzavamo, perché non erano alla moda e in parte li veneravamo, perché appartenevano a mio padre. Aveva un’autentica passione per il pattinaggio – era in effetti l’unica cosa che s’avvicinasse allo sport ...