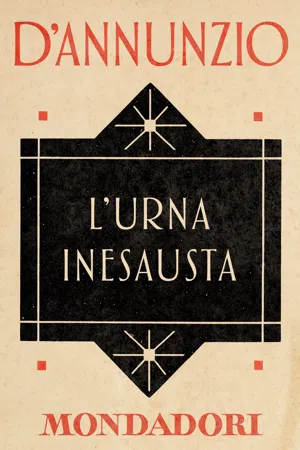1 NOTIZIA SUL TESTO
Del ciclo incompiuto della Penultima ventura fa parte anche L’Urna inesausta, il libro in cui d’Annunzio raccoglie nel 1931, per le edizioni dell’Oleandro, i testi dei suoi scritti e discorsi fiumani, dalla marcia di Ronchi alla fine del 1919. Nell’aprile 1932, il volume entrerà nell’Edizione nazionale di Tutte le Opere. Il titolo rinvia al discorso pronunciato all’indomani del referendum che segna l’acme della crisi interna provocata nel dicembre dal cosiddetto «modus vivendi». Questo compromesso proposto da Nitti tramite Badoglio ottiene il consenso del Consiglio Nazionale e della maggioranza della popolazione locale; e a favore dell’accordo si schiera anche la redazione della «Vedetta d’Italia», il quotidiano nazionalista di proprietà della famiglia Baccich, promosso da d’Annunzio a strumento di risonanza dei suoi atti di governo e dei suoi indirizzi politici. Convinto della necessità di proseguire sulla linea intransigente della ribellione, il Comandante fa sottoporre l’accordo a plebiscito, ma sospende d’imperio lo scrutinio dei voti non appena gli è chiaro l’esito favorevole all’accettazione.
Ed è certo rivelatore del suo particolare intuito della sensibilità collettiva che in coincidenza con la torbida conclusione del referendum egli stringa a sé i suoi legionari coinvolgendoli, addirittura con un ordine ufficiale ai comandi, nella stesura di un’opera sulla loro stessa avventura. Il singolare disegno Per la storia dell’impresa di Fiume e di Dalmazia, datato 18 dicembre 1919, si legge sulla «Vedetta d’Italia» del giorno 21, e vale la pena di riportarne un frammento: «Nel libro che mi propongo di scrivere sull’impresa di Fiume io voglio illustrare tutte le azioni mirabili, tutti i sacrifizi luminosi, tutte le manifestazioni di volontà tenace, di ardimento sublime e di devozione costante alla Causa che amiamo e serviamo. / L’ho promesso e lo riprometto ai compagni che mi seguirono nell’opera di liberazione e che continueranno con me lo sforzo nazionale […] Perché io possa tenere la promessa, è però necessario che nessuna delle loro azioni mi sfugga e che nessuna delle testimonianze del loro valore e del loro fervore possa essere da me ignorata. / Ordino perciò a tutti i comandi dipendenti di comunicare il mio intendimento ai vari reparti affinché ogni Comandante di reparto possa redigere una relazione particolareggiata ed esatta delle vicende alle quali i suoi uomini abbiano collettivamente partecipato. I Comandanti stessi dovranno inoltre adoprarsi perché tutti coloro che abbiano compiuto isolatamente o con altri, fuori del proprio reparto, azioni meritevoli di essere conosciute e ricordate, ne scrivano una schietta narrazione. / I racconti dovranno essere quanto mai semplici, sinceri nella spontanea efficacia delle impressioni primitive. Ogni falsa fioritura dovrà essere bandita, come ogni formalità di carattere puramente militare. Le impressioni, gli incontri improvvisi, gli aneddoti seri o burleschi dovranno essere posti in particolare risalto. Non chiedo un freddo rapporto, ma un racconto vivace, o dirò così familiare, come ognuno farebbe attorno al focolare domestico, in un crocchio di amici, all’osteria. / Ogni ufficiale o soldato, a seconda della propria cultura, delle proprie abitudini, del proprio modo di considerare la vita e gli eventi e di risentire le impressioni esteriori, racconti dunque quello che lo ha particolarmente colpito, esponga i sentimenti che si sono risvegliati in lui compiendo l’atto che lo condusse alla città Olocausta, o portandovi successivamente il contributo della propria energia».
Di là dalla proposta sperimentale di un’impresa di scrittura collettiva, il progetto fra memorialistico e narrativo sopravvive solo in qualche dichiarazione rilasciata alla stampa dopo la fine della Reggenza del Carnaro. Intanto, un esiguo manipolo di scritti da Fiume era giunto alle stampe nel 1920, in un opuscolo della Fionda, Italia e vita, che oltre al testo eponimo contiene l’Ordine del giorno ai legionari per la fine dell’anno MCMXIX (ossia il Credo che suggella l’edizione definitiva) e il trascinante appello del 12 agosto 1920 «Domando alla città di vita un atto di vita». Valore di apologia e di propaganda a uso, per così dire, interno ha invece la pubblicazione dei discorsi e delle lettere risalenti ai giorni degli scontri fratricidi del Natale di sangue, nei Documenti delle cinque giornate di Fiume (d’Annunzio battezza così l’estremo tentativo di resistenza nella città assediata), curato sotto la supervisione del Comandante da Eugenio Coselschi e stampato dalla tipografia della «Vedetta d’Italia» immediatamente a ridosso degli eventi. Nel 1922, poi, nel riaccendersi dell’interesse politico per il fiumanesimo, d’Annunzio avverte l’esigenza di rendere disponibili, in una versione scrupolosamente vagliata dall’autore, testi in Italia ancora in gran parte sconosciuti o mal noti: le bozze per il progettato volume Vallecchi, In nome del futuro, attestano l’intenzione di una pubblicazione selettiva, riguardante gli scritti di più pretto tenore ideologico. Ma tanto più dopo l’ascesa del fascismo al potere, a impedire che l’abbondantissima produzione del tempo di Fiume divenga oggetto di un’edizione organica è anche la comprensibile inibizione del Comandante sconfitto a ripresentare nella sua scansione serrata di eventi e di prese di posizione una vicenda controversa e ancora in più sensi confusa, certo esasperatamente conflittuale, di cui egli è retrospettivamente in grado di misurare a fondo anche gli errori. Di fatto, il disegno di una raccolta cronologicamente disposta non acquista consistenza se non nell’Elenco delle opere predisposto nel ’27 in vista dell’Edizione nazionale, ove figurano ai numeri LXXI-LXXV, ancora distinti dal Sudore di sangue, i cinque volumi de L’Arengo di Fiume (dal camposanto di Ronchi al cimitero di Cosala, 1919-1920); e la stessa intitolazione (ma i volumi previsti sono scesi a quattro) si ritrova in un programma editoriale per l’Oleandro vergato da d’Annunzio alla fine del 1929. Ma solo nell’agosto 1931, con l’allestimento dei primi volumi delle edizioni dell’Oleandro, gli scritti, i discorsi, i proclami della rivoluzione fiumana si compongono nel ciclo della Penultima ventura scandito in cinque libri e comprensivo anche dei testi di preparazione politica della campagna per la «Vittoria mutilata», con l’aggiunta in extremis di un sesto di «Comento» non ancora composto, il misterioso Oltre le belle bella, previsto originariamente come proemio del Sudore di sangue e quindi dell’intera raccolta.
Al Vittoriale si conservano le bozze di stampa dei tre volumi che avrebbero dovuto far seguito all’Urna inesausta: Il pugnale votivo (con i testi del periodo dal 3 gennaio al 15 giugno 1920), La riscossa dei Leoni (16 giugno-31 ottobre 1920) e Commiato fra le tombe (1° novembre-18 gennaio 1921). Secondo De Felice, cui si deve un’ampia antologia della Penultima ventura (Milano 1974), i volumi non arrivarono mai alle stampe, oltre che per ragioni di opportunità politica, per le difficoltà alla fine insormontabili inerenti alla natura stessa del materiale. Tali bozze, infatti, si originano dal lavoro di trascrizione di un dattilografo che, a parte qualche inedito recuperato negli archivi del Vittoriale, ha messo insieme una raccolta indiscriminata di testi apparsi originariamente sul «Bollettino Ufficiale» del Comando e sulla «Vedetta d’Italia»: e si tratta di un materiale quanto mai eterogeneo, comprendente anche discorsi in versione riassunta o stenografata, stralci di dichiarazioni, informative di ordine logistico o operativo, comunicati o bollettini tra burocratici e militari, lettere gratulatorie a personaggi o enti minori e anche minimi, non senza una certa quota di scritti di dubbia autenticità (al Comandante, peraltro, non era affatto estraneo l’abito di stilare referti anonimi della sua azione di governo rappresentandosi in terza persona). Ciò che si chiedeva all’autore costretto al ruolo di redattore di se stesso era dunque di sceverare, escludere, integrare, rettificare, riordinare, esattamente come accade nelle ultime fasi di lavoro febbrile per l’allestimento dell’Urna inesausta, attestate dal carteggio con il responsabile dell’edizione dell’Oleandro, Arnoldo Mondadori: «questa disperata correzione del libro secondo mette a pericolo il mio povero occhio e anche il mio cervello convulso. / Ti renderai conto della mia pena. Ho dovuto riscontrare, e poi cancellare sciocche interpolazioni, e poi abolire molte forme arbitrarie. / Sono sfinito. Ti mando le stampe oramai castigate con tanta preziosa cura che posso pretendere di avere in compenso il libro ben corretto. Altrimenti mi infurio davvero» (5 settembre 1931). E due giorni dopo: «come dicevo agli ufficiali in prossimità di Cantrida, io do “più che tutto me”. / La necessità dei continui riscontri, la esatta restituzione del testo, la introduzione di alcuni brani omessi anche dalla “Vedetta” già inclinata verso gli accomodamenti, mi affaticano l’occhio e la mano». In pari tempo d’Annunzio appronta un nuovo manoscritto dei due testi d’apertura (quello della Orazion piccola in vista del Carnaro e quello del «primo discorso dalla ringhiera, così maltrattato dagli stenografi»), che il 9 settembre invia all’editore non senza aver «aggiunto due epigrafi aggiustatissime», da Dante e da Ariosto. Il 12 settembre il volume stampato approda al Vittoriale e d’Annunzio, con un telegramma, ne dà immediata notizia a Mussolini, divenuto forse all’ultimo momento uno dei personaggi del libro. La marcia su Fiume continua ambiguamente a confrontarsi con la Marcia su Roma: «Nel secondo libro de’ miei discorsi fiumani venuto in luce oggi tu leggerai alcune parole di proposito audace e non incerto ch’io ti scrissi sul punto di partire per Ronchi e ch’io volli riferire alle mie poche genti adunate dichiarandole “a un compagno di fede e di violenza” e considerandole come un impegno da adempiere senza fallo. Il fiero accordo di allora si rinnova nella tua parola di oggi. Entrambi abbiamo tuttora cómpiti diversi ma corrispondenti: interno ed esterno. So che nessuno di noi mancherà di dominare e di forzare l’evento ignoto».
Del Pugnale votivo, il solo dei volumi incompiuti che rechi tracce cospicue della revisione 1931 (cui collaborano anche Angelo Sodini e Edoardo Susmel), esiste ora un’accurata edizione, nell’acuto G. Lancellotti, Il pugnale votivo di Gabriele d’Annunzio. Orazioni e messaggi fiumani 1921-1931, cit. Nella loro veste originaria per la pubblicazione sulla «Vedetta d’Italia» i testi fiumani dal gennaio 1920 al gennaio 1921 sono raccolti nel secondo volume degli Scritti giornalistici per i Meridiani Mondadori.←
* * *
2 L’ORAZION PICCOLA IN VISTA DEL CARNARO
Partito da Ronchi, nei pressi di Monfalcone, all’alba del 12 settembre, assieme a una colonna di granatieri comandati dal maggiore Carlo Reina, d’Annunzio pronuncia questo breve discorso di fronte a una trentina di ufficiali, all’incrocio delle strade per Fiume e per Trieste. Il momento è rievocato dal fiumano Susmel: «Aveva di fronte il sole che illuminava la sua faccia. Era di un pallore mortale ma di una ispirazione soprannaturale. La fronte, i radi baffetti, il mento erano come incrostati di polvere; ma il suo occhio era vivo e la sua voce, da prima lenta e fioca, diventò alla fine metallica. Sembrava acuta, penetrante e sonante come una lama d’acciaio» (E. Susmel, La marcia di Ronchi, Hoepli, Milano 1941, p. 396).
Benché il richiamo ai «Sette giurati della terra di Ronchi» sia esplicito, la spedizione si origina solo apparentemente dall’appello dei sette membri della brigata dei granatieri che a fine agosto hanno invocato l’intervento del poeta per risolvere il problema fiumano. Fin dal mese di marzo d’Annunzio è infatti in contatto con alcune delle personalità che più direttamente si impegneranno nella preparazione del colpo di mano: con il capitano Host Venturi, che in maggio costituirà la Legione dei volontari fiumani, e con il nazionalista Giuriati, che a partire da giugno organizzerà centri di arruolamento per volontari in diverse città italiane.
Esplicito è il riferimento alla lettera che d’Annunzio invia l’11 settembre a Mussolini (cfr. D’Annunzio-Mussolini, p. 9): definito «compagno di fede e di violenza», il capo del fascismo, dopo essere stato accusato di non sostenere in alcun modo l’impresa (ivi, 16 settembre, p. 9), il 19 settembre lancerà una sottoscrizione nazionale a favore di Fiume dalle colonne del «Popolo d’Italia».
«Vien l’odor di Roma al cuore» è un verso della Canzone del Quarnaro, inserita nel libro dedicato alla Beffa di Buccari pubblicato dai fratelli Treves nel 1918.←
3 LA PRIMA VOCE DELL’ARENGO
Superato lo sbarramento di Contrida con relativa facilità, perché i generali Zoppi, Pittaluga e Ferrero hanno preferito non opporsi con la forza alla marcia dei legionari, d’Annunzio giunge a Fiume intorno alle 11.45 del 12 settembre; con lui una colonna che ha raggiunto le duemila unità, giacché durante il percorso molti militari si sono uniti agli insorti. Il discorso, il primo di fronte alla popolazione fiumana, è pronunciato intorno alle 18 dal palazzo del Governo, dove il Comandante si reca subito dopo aver appreso di essere stato nominato governatore della città. «Alle ore 18 del 12 settembre» racconta Coselschi, segretario particolare del poeta, «tutta Fiume, sempre vibrante di un indescrivibile entusiasmo, si riversò in Piazza...