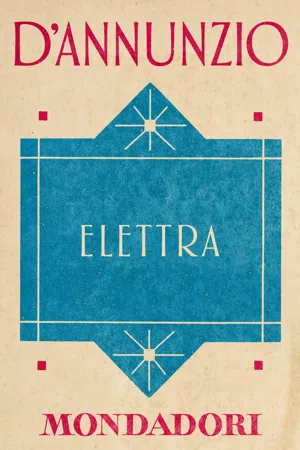![]()
1 NOTIZIA SUL TESTO
Singolare fortuna critica è stata quella di Elettra, conclusa per lo più in giudizi convergenti sui motivi della extrapoeticità, dei toni ieratici e celebrativi. Si era già mosso in tale direzione, agli albori del secolo, il Morasso dell’Imperialismo artistico (1903), recensendo favorevolmente l’ode PER LA MORTE DI GIUSEPPE VERDI e la CANZONE DI GARIBALDI come due fra i primi canti della «nuova poesia della rinascenza eroica». E si sa che per un celebratore di odi e poemi inteso a decretare, nel passaggio dal simbolico all’eroico, la positiva evoluzione dell’arte verso il mito superomistico della «serenità Omerica creatrice», incorruttibile come «le forze eterne della natura», l’amplificazione retorica non è mai sufficiente. «Grandiosa come un monumento, solenne come un sacrificio, pura come una vittoria, gagliarda come un gesto di dominio» appare così l’ode PER LA MORTE DI GIUSEPPE VERDI: al punto che le strofe, racchiudendo in «sintesi universale», come dentro «un cerchio ermetico», la perfezione dell’immaginabile, sembrano «scandere il respiro di un petto insigne, accordarsi al palpito di un magnanimo cuore, esaltarsi al voto di una volontà inflessibile». E non diverso risulta, da parte del celebratore dell’Egoarchia (1898), il giudizio sulla CANZONE DI GARIBALDI, non canto epico ma poema nel «senso moderno», alla maniera, quindi, del Carlyle e dello Whitman, dominato da «uno dei grandi tipi di eroi indigeni, di semidei autoctoni […] simbolo del perpetuarsi del genio» (non a caso all’Eroe biondo che rivisse nell’alta canzone, Maia consacra alcuni versi della sezione XVII).
Certo meno enfasi e trionfalismo è dato cogliere negli interventi critici successivi, che non si discostano tuttavia dall’analisi di una poesia adibita a eloquenza civile nazionalista e di propaganda: dalle valutazioni del Borgese («[…] un sottile filtro di menzogna attossica tutto l’organismo dell’ode. E questa menzogna è una fiacca e vuota ideologia paludata di sonore astrazioni con gran copia d’iniziali maiuscole») a quelle attente del De Michelis sul «dilagare dell’eloquenza» nel libro «raccogliticcio», o del Palmieri, sensibile anch’egli alla «discontinuità» della raccolta, nonostante i tentativi di difesa ideologica («poema dalla compatta sostanza ideale, se pur vario e diseguale nelle parti […]. Sovente l’Occasione è la musa ispiratrice […]»). E più recentemente il Roncoroni, rendendo esplicite, con lodevole chiarezza, le tendenze dicotomiche, distingue i toni di retorica bellicista da certa propensione all’«idillico», all’«elegiaco», al «voluttuoso», che non impediscono all’opera di rimanere «al di qua» dell’arte. Da una parte, pertanto, si accusa la raccolta di appartenere ad un genere (oratorio, celebrativo); e dall’altra, in luogo di indagarne la maggiore o minore coerenza e necessità interna, si giudica per lo più tale appartenenza, assunta sommariamente e in blocco, lesiva ai fini artistici, applicando così al genere un parametro valutativo e normativo per nulla contraddetto dalle poche aperture poetiche che costituiscono deviazioni rispetto al sistema.
Di fronte ai residui, tutt’altro che marginali, di idealismo impliciti in tale scissione, acquistano significato le considerazioni di un critico contemporaneo del d’Annunzio, il Brunetière, che proprio dei generi si andava interessando nell’ultimo decennio del secolo scorso (al 1890 risale L’évolution des genres dans l’histoire de la littérature), quando accenna, non senza i limiti del pensiero positivistico che il Thibaudet della Physiologie de la critique provvederà a illustrare, non solo al rapporto problematico che si instaura tra tradizione e novità, tra genere ed evoluzione, ma anche alla necessità interna dell’opera («S’il se peut que la littérature ou l’art soient l’expression de la societé, ce n’est pas là leur objet; ou du moins ils en ont un autre; et, comme la société même ou comme la religion, ils ont en eux-même leur raison d’être» – e non sarà da sottovalutare lo spunto che il Brunetière offre al poeta di Elettra ove accenna, trattando della trasformazione dei generi, all’influenza dell’orazione da pulpito del secolo XVII sulla poesia lirica di Lamartine, di Hugo, di Vigny, di Musset). La nozione rigida di genere, dopo i formalisti russi, e lo Jauss, il Bachtin, l’Auerbach, ha lasciato il campo, è noto, a una struttura dinamica di relazioni che dalle modalità di esistenza individuale dell’opera (le «disposizioni e orizzonti di gusto» di cui parla Anceschi, attive come «intenzioni all’interno del problema situazionale» proposto dal testo) si proiettano sul sistema della produzione di un autore, sulle intenzioni manifeste o latenti che esso attualizza in sé o proietta all’esterno, modificando ogni volta l’orizzonte sincronico e diacronico del fenomeno letterario. Già nel 1922 il Tynjanov, affrontando lo studio dell’ode come genere oratorio, aveva intuito, ad esempio, l’importanza della funzione che trasforma l’effetto oratorio «in un particolare principio costruttivo, una dominante, che permette di individuare nella parola poetica aspetti nuovi» ed allo stesso tempo costituisce l’orientamento «in rapporto alle serie extraletterarie più vicine», da cui dipende il caratterizzarsi dell’area semantica del testo.
Applicate ad Elettra tali considerazioni impongono una ricognizione sulle strutture che ne definiscono l’identità: se di genere si vuole parlare, ci si chiede intanto fino a che punto la raccolta lo rappresenta, in che misura l’occasione e la motivazione contingente influiscono sulla stesura, imponendo soluzioni stilistiche, ritmiche e metriche, e impegnando il produttore a rapportarsi al fruitore, al destinatario interno oltre che a quello esterno (in una lettera inedita al Tenneroni riportata dal Fatini in QD, XXIV-XXV, 1963, il poeta sollecita ad esempio un parere «intorno all’effetto dell’ode [AL RE GIOVINE] sulla massa popolare»; e del resto le lettere al traduttore francese Hérelle basterebbero a dimostrare quanto d’Annunzio fosse sensibile al problema del pubblico). Si potrà allora scoprire dove e perché l’opera è innovativa, qual sia il contesto dinamico in cui si situa, quali le linee di forza che l’attraversano e da lei si dipartono per rifluire su esperienze contigue: e sarà possibile, in tale modo, impostare un corretto approccio filologico con l’intricata rete di relazioni che collega Elettra ad Alcyone e a Maia.
Se si eccettua la sezione dedicata alle Città del silenzio, Elettra presenta un repertorio stilistico e tematico senz’altro affine ai modi dell’oratoria celebrativa, politica e liturgico-sacramentale: le odi si rivolgono ad ascoltatori chiamati a partecipare a un rituale comune di rigenerazione e purificazione (l’attesa), fondato su miti, simboli, figure storiche divenute archetipi (la patria, l’acqua, la terra, il fuoco, gli eroi…) dal carattere fortemente emozionale (la memoria collettiva). Il dialogo si sviluppa nel gioco dei pronomi (io – tu – voi – noi), che da una parte instaura una mitologia personale su cui occorrerà ritornare (l’io dell’uomo nuovo, disposto al sacrificio di sé e alla rinascita incontaminata – Io nasco in ogni alba che si leva. / Ogni mio risveglio / è come un’improvvisa / nascita nella luce: / attoniti i miei occhi / mirano la luce e il mondo; cfr. PER LA MORTE DI UN DISTRUTTORE, vv. 337-342, e con lievi varianti Maia II, vv. 127-133), dall’altra sottintende la presenza fisica di un uditorio (il voi, il tu dell’apostrofe o dell’invocazione) con cui si perviene ad un’unanimità corale (il noi), che traduce il messaggio in atto concreto e pratica comune. Linguaggio, dunque, performativo, che non esaurisce il proprio compito nella descrizione, ma è esso stesso prassi sostenuta da elementi sintattici e grammaticali: la prevalenza, ad esempio, di forme verbali al presente per favorire il momento epifanico (l’evocare, il dire, il guardare, il vedere, il sentire, l’attendere, il venire, lo stesso pregare…) ma anche l’uso variato del tempo che estende la portata semantica del verbo sino alla totalità espressiva (AL RE GIOVINE: […] Tu non dormirai [Leitmotiv ritmico] – […] Non dormimmo noi […]; Egli volle […] – Che vorrai tu […]; ALLA MEMORIA DI NARCISO E DI PILADE BRONZETTI: Ah ch’io venga […] ch’io veda […] – Verrà, verrà […] vedrà […]), oltre alle forme deittiche, gestuali, teatrali (ecco – eccomi) di cui LA NOTTE DI CAPRERA, testo destinato espressamente alla recitazione, offre il più ricco catalogo.
E accanto il ricorso agli astratti, all’antonomasia, ai modi ieratici dell’iperbole e dell’ossimoro, alla ripetizione, spesso nelle forme dell’anafora, dell’epifora, del parallelismo, dell’allitterazione, all’interrogativa retorica, al rovesciamento dell’antimetabole (ALLA MEMORIA DI NARCISO E DI PILADE BRONZETTI: Non piangere […] Ma sogna […]), alla cantilena che imita la litania o il responsorio liturgico (A DANTE: […] noi t’invochiamo! […] no...