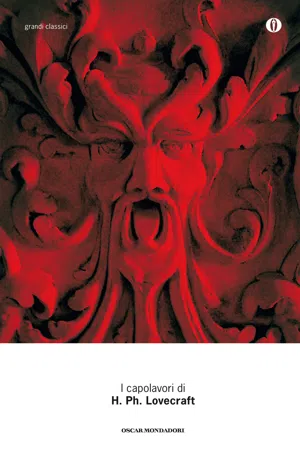
eBook - ePub
Disponibile fino al giorno 6 Mar |Scopri di più
I capolavori
Questo libro è disponibile per la lettura fino al giorno 6º marzo, 2026
- 672 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Disponibile fino al giorno 6 Mar |Scopri di più
I capolavori
Informazioni su questo libro
L'opera di Howard Phillips Lovecraft, per decenni superficialmente considerata letteratura "di genere", rappresenta in realtà un corpus narrativo capace di affascinare i lettori ben oltre i confini del fantastico. E i racconti qui racchiusi, scritti tra il 1917 e il 1935, sono testimonianza del meglio di una produzione letteraria frutto di una ricerca personale e del tutto originale, che ha saputo esprimere il buio di una condizione umana spiritualmente ferita. Un deserto dell'anima dal quale è possibile uscire solo attraverso il sogno, l'immaginazione che permette di indagare nella realtà del cosmo e nella profondità della mente. Lovecraft ci appare così come un esploratore dell'ignoto, un visionario che si è lasciato alle spalle l'orizzonte della quotidianità così come gli stereotipi della letteratura horror, con i suoi consueti scenari di tombe vuote e demoni, per approdare a un universo, esistenziale e letterario, assolutamente nuovo, fatto di ben più maestose e nello stesso tempo desolanti immagini. In un'epoca particolarmente tormentata, quella tra le due guerre mondiali, Lovecraft ci ha ricordato che l'orrore è inseparabile dall'uomo, un orrore costruito non da fantasmi e castelli maledetti, ma dal deserto del materialismo e della solitudine.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Print ISBN
9788804583301eBook ISBN
9788852031168I capolavori
Dagon
Titolo originale: Dagon, luglio 1917
Traduzione di Giuseppe Lippi
Scrivo queste note in una morsa d’angoscia e so che al termine della notte sarò finito. Senza un soldo e senza la droga che rende sopportabile la mia esistenza, non posso reggere oltre la tortura: mi butterò dalla finestra di questa soffitta. Ma la mia dedizione alla morfina non deve farvi pensare che sia un debole o un degenerato; quando leggerete queste pagine intuirete (anche se non riuscirete a comprendere del tutto) perché non mi restino che l’oblio o la morte.
Fu in una delle zone più aperte e meno frequentate del Pacifico che il piroscafo di cui ero sovrintendente cadde vittima dell’incrociatore tedesco. La grande guerra era all’inizio e le forze navali del nemico non avevano ancora ceduto completamente, come poi sarebbe avvenuto: la nostra nave venne catturata e noi dell’equipaggio fummo trattati con il rispetto e la considerazione dovuti ai prigionieri di guerra. Anzi, la disciplina dei nostri catturatori era così blanda che dopo cinque giorni riuscii a fuggire da solo, in barca, con acqua e provviste per diverso tempo.
Finalmente libero e alla deriva, non avevo alcuna idea delle acque in cui mi trovavo. Non sono mai stato un provetto navigatore e dalla posizione del sole e delle stelle potei solo concludere che ero a sud dell’equatore. Ignoravo completamente la longitudine e non erano in vista né isole né tratti di costa. Il tempo si manteneva buono e per innumerevoli giorni avanzai senza meta sotto il sole feroce, aspettando di scorgere una nave o di essere scagliato sulle sponde di una terra abitabile. Ma non si vedevano né navi né terra, e nell’immensa solitudine del mare e del cielo cominciai a disperare.
Poi, mentre dormivo, avvenne il cambiamento. Non ne conoscerò mai i particolari, perché non mi svegliai dal mio sonno agitato e fitto di sogni. Quando riaprii gli occhi scoprii di essere mezzo sprofondato in una massa disgustosa di fango nero che s’estendeva intorno a me a perdita d’occhio, e in cui la mia barca si era arenata a qualche metro di distanza.
È logico supporre che davanti a una così radicale modificazione del paesaggio la meraviglia fosse il mio stato d’animo predominante, ma in realtà ero più atterrito che sorpreso, perché in quell’aria e in quel fango putrescente c’era una qualità sinistra che metteva l’anima a dura prova. La regione pullulava di carcasse di pesci marciti e di cose meno facilmente descrivibili, che spuntavano un po’ dovunque dal fango dell’interminabile pianura; ma è assurdo sperare di trasmettere, a parole, l’orrore che gravava su quel deserto di assoluto silenzio e sconfinata vastità. Non si sentiva e non si vedeva nulla a parte l’immensa distesa di fango nero: e proprio la totale immobilità e omogeneità del paesaggio mi davano un senso di paura schiacciante.
Il sole bruciava da un cielo in cui non c’era traccia di nuvole e che sembrava nero, come se riflettesse la palude color inchiostro che si stendeva ai miei piedi. Mentre strisciavo verso la barca in secca riflettei che una sola teoria poteva spiegare la mia situazione: in seguito a un fenomeno vulcanico di inaudite proporzioni una parte del fondo oceanico doveva essere venuta a galla, esponendo regioni che per milioni d’anni erano rimaste coperte da incalcolabili quantità d’acqua. L’estensione della nuova regione era tale che, per quanto tendessi le orecchie, non sentivo nemmeno in lontananza il rumore dell’oceano e non c’erano gabbiani a banchettare sui resti di pesce.
Per diverse ore rimasi nella barca a pensare e rimuginare: inclinata su un fianco com’era, col passare del tempo cominciò a offrirmi un po’ d’ombra; il suolo sotto di me sembrò perdere una parte della sua mollezza e si asciugò quel tanto che bastava a coprire brevi tragitti a piedi. Quella notte dormii poco e il giorno seguente feci un pacco che conteneva cibo e acqua e che avrei portato con me in un viaggio d’esplorazione, alla ricerca dell’oceano scomparso e di eventuali soccorsi.
Il terzo giorno il suolo si era asciugato abbastanza per camminarci con facilità. L’odore di pesce era insopportabile ma io, oppresso da pensieri molto più gravi, non mi preoccupai di un male così trascurabile e mi incamminai coraggiosamente verso una meta sconosciuta. Per tutto il giorno avanzai regolarmente verso ovest, usando come punto di riferimento un’altura che si ergeva più di qualsiasi altro oggetto sul deserto ondulato. Di notte feci un piccolo campo e il giorno dopo ripresi ad avanzare verso l’altura, che non sembrava più vicina della prima volta che l’avevo vista. La quarta sera arrivai alla base dell’elevazione, molto più alta di quanto apparisse in lontananza; una valle la separava dal resto della pianura, dandole ancora maggior risalto. Troppo stanco per tentare un’ascesa, mi addormentai ai suoi piedi.
Non so perché i miei sogni, quella notte, fossero tanto strani, ma prima che la falce di luna calante si levasse dall’orizzonte orientale ero sveglio, in un bagno di sudore freddo e decisissimo a non addormentarmi più. Non me la sentivo di sopportare oltre le cose che avevo visto in sogno, e al chiarore della luna mi resi conto che ero stato uno sciocco a viaggiare di giorno. Senza il calore e il riflesso accecante del sole il viaggio mi avrebbe stancato molto meno: anzi, ora mi sentivo pronto a compiere la scalata che al tramonto mi aveva trattenuto. Raccolsi il pacco delle provviste e mi incamminai verso il vertice dell’altura.
Ho detto che l’assoluta monotonia della pianura era per me una fonte di terrore, ma credo di aver provato una paura anche più forte quando raggiunsi la vetta e guardai nell’incommensurabile gola, o baratro, che si stendeva dall’altro versante. Era così terribile che la luna, ancora relativamente bassa nel cielo, non riusciva a illuminarne il fondo. Mi parve di essere sull’orlo del mondo e di guardare oltre il bordo, in un abisso incommensurabile di notte e caos; e nel terrore ebbi una strana reminiscenza del Paradiso perduto, l’orrenda scalata di Satana negli sconosciuti regni delle tenebre.
Man mano che la luna s’alzava nel cielo mi resi conto che i fianchi della gola non erano perpendicolari come avevo immaginato: costoni e sporgenze improvvise offrivano un buon appiglio per la discesa e dopo un precipizio di qualche centinaio di metri il declivio si faceva graduale. Spinto da un impulso che non riesco ad analizzare, mi calai con difficoltà per il primo tratto e arrivai nel punto in cui la discesa si faceva più dolce. Poi guardai il baratro in cui la luce non era mai entrata.
Improvvisamente la mia attenzione fu catturata da un grande e singolare oggetto che si trovava sul fianco opposto della gola, il quale s’innalzava ripidamente a un centinaio di metri da me. Colpito dalla luna che ormai era sufficientemente alta, l’oggetto brillava di bianco. Che fosse soltanto un obelisco di pietra, è un fatto di cui mi accertai presto: ma giunsi alla conclusione che la sua forma e la sua posizione non potevano essere opera della natura. Esaminandolo più da vicino provai sensazioni che non è facile descrivere, perché, nonostante la sua immensa grandezza e la sua collocazione in un baratro che l’oceano aveva sommerso fin dall’alba del mondo, dava la sensazione di essere stato costruito, e forse adorato, da creature intelligenti.
Stupito e terrorizzato, ma non privo di un pizzico d’esultanza scientifica e archeologica, decisi di esaminare più attentamente l’ambiente in cui mi trovavo. La luna, vicina ora allo zenit, splendeva con fantastica chiarezza sui gradini giganteschi che sprofondavano nel burrone, e mi permise di scoprire che sul fondo c’era un corso d’acqua. Il torrente si perdeva verso sbocchi invisibili in entrambe le direzioni, ma mentre ero sul declivio mi lambiva quasi i piedi. Al di là del baratro gli spruzzi raggiungevano la base del monolito ciclopico, sulla cui superficie distinguevo sia iscrizioni che rozze sculture. La scrittura si basava su un sistema di geroglifici a me sconosciuto e diverso da tutti quelli che avevo visti nei libri: consisteva, perlopiù, di simboli acquatici stilizzati come pesci, anguille, polipi, crostacei, molluschi, balene e simili. Alcuni ideogrammi riproducevano animali marini sconosciuti al mondo moderno, ma le cui forme decomposte avevo visto sulla pianura.
Furono le sculture, comunque, a impressionarmi di più. Ben visibili, per la loro mole ciclopica, anche al di qua dell’abisso, formavano una sequenza di bassorilievi il cui tema avrebbe fatto l’invidia di un Doré. Credo che nelle intenzioni degli scultori le figure dovessero rappresentare uomini, o almeno una specie particolare di uomini, che tuttavia nuotavano come pesci nelle profondità di grotte sottomarine e pregavano davanti a un altare di pietra pure sommerso. Non oso descrivere nei particolari i loro corpi, i loro volti, perché il semplice ricordo mi fa star male. Grotteschi oltre l’immaginazione di un Poe o di un Bulwer-Lytton, nell’insieme erano maledettamente umani ma avevano mani e piedi palmati, labbra enormi e mollicce, occhi vitrei e sporgenti e altri tratti ancora più spiacevoli. Cosa alquanto strana, sembravano sproporzionati rispetto allo sfondo: una delle creature era rappresentata nell’atto di uccidere una balena che era poco più grande di lei. Fui colpito, come ho detto, dalle loro dimensioni e dall’aspetto grottesco, ma un attimo dopo decisi che doveva trattarsi semplicemente degli dèi fantastici di una primitiva popolazione di pescatori o marinai; una popolazione, peraltro, i cui ultimi discendenti erano morti milioni d’anni prima che nascesse l’antenato dell’uomo di Neanderthal o di Piltdown. Intimorito dalle prospettive che si aprivano su un passato inconcepibile anche per l’antropologo più fantasioso, continuai a rimuginare sotto la luna che gettava strani riflessi nel canale ai miei piedi.
Poi, all’improvviso, lo vidi. L’essere affiorò dall’acqua nera con un solo risucchio: vasto, ciclopico e disgustoso sfrecciò verso l’obelisco come un meraviglioso mostro d’incubo, poi abbracciò la stele con le enormi braccia scagliose e piegò la testa, emettendo una serie di suoni misurati. Credo di essere impazzito allora.
Della mia frenetica risalita sul pendio della gola e il fianco dell’altura ricordo ben poco, come pure del viaggio di ritorno alla barca. Credo di aver cantato a squarciagola e di aver riso come un pazzo quando non riuscivo a cantare. Ho confusi ricordi di un violento temporale, scoppiato poco dopo aver raggiunta la barca; comunque, so di aver sentito scoppi di tuono e altri boati che la natura emette quando è nella sua fase più violenta.
Quando emersi dalle ombre ero in un ospedale di San Francisco, dove mi aveva lasciato il comandante della nave americana che mi aveva raccolto in mezzo all’oceano, a bordo della mia barca. In delirio avevo raccontato quasi tutto ciò che avevo visto, ma alle mie parole era stata prestata scarsa attenzione. I miei salvatori non erano al corrente di fenomeni geologici o emersioni di terre nel Pacifico e io non ritenni necessario insistere su una storia che non avrebbero potuto credere. Una volta solo ho cercato un etnologo, un famoso scienziato, divertendolo con le mie strane domande sull’antica leggenda filistea di Dagon, il dio-pesce; poi, resomi conto che era legato a punti di vista quanto mai convenzionali, ho lasciato perdere.
È di notte, specialmente quando la luna è bianca e calante, che lo rivedo; ho tentato la morfina, ma la droga mi ha dato una liberazione solo temporanea e in compenso mi ha fatto schiavo. Dopo aver scritto questo resoconto, che costituirà lo spasso dei miei simili, sento che è ora di finirla. Spesso mi chiedo se tutta l’avventura non possa esser stata un’allucinazione, un attacco di febbre sopravvenuto quando, in realtà, me ne stavo sul fondo della barca e deliravo nel sole, dopo la fuga dall’unità tedesca. Questo mi domando: ma ogni volta, in risposta, vedo una scena raccapricciante e vivida come non mai. Non posso pensare al mare profondo senza rabbrividire all’idea degli esseri che forse, in questo stesso momento, si trascinano e guizzano sul fondo melmoso, intenti nell’adorazione degli antichi idoli di pietra e nell’arte di scolpire le loro detestabili fisionomie su obelischi sommersi di granito. Sogno il giorno in cui usciranno dai flutti e stringeranno negli artigli immensi i resti dell’umanità insignificante, logorata dalle guerre... il giorno in cui le terre sprofonderanno e il fondo oscuro dell’oceano salirà in superficie, nel pandemonio universale.
La fine è vicina. Sento un rumore alla porta, come se un immenso corpo viscido vi premesse contro. Non mi troverà. Dio, quella mano! La finestra! La finestra!
Nyarlathotep
Titolo originale: Nyarlathotep, inizio di dicembre 1920
Traduzione di Giuseppe Lippi
Nyarlathotep, il caos strisciante... Io, che sono l’ultimo, parlerò al vuoto in ascolto...
Non ricordo quando tutto ebbe inizio, forse mesi fa. La tensione era al massimo, spaventosa: a un periodo di sconvolgimenti politici e sociali si aggiungeva la strana, indefinibile sensazione d’un orrendo pericolo fisico. Un pericolo enorme, che gravava su tutto, come lo si può concepire negli incubi più angosciosi. Ricordo che la gente andava in giro con facce pallide e preoccupate, bisbigliando avvertimenti o profezie che nessuno osava poi ripetere consapevolmente o soltanto ammettere di aver udito. La terra era oppressa da un mostruoso senso di colpa e dagli abissi fra le stelle soffiavano gelide correnti che facevano rabbrividire gli uomini nei luoghi bui e solitari. Il corso delle stagioni aveva subìto un’alterazione catastrofica: il tepore dell’autunno indugiava ad andarsene e sentivamo che il mondo, forse l’universo, si era sottratto al controllo degli dèi o delle forze conosciute ed era passato sotto il dominio di entità inimmaginabili.
Fu in un simile momento che, in Egitto, fece la sua comparsa Nyarlathotep. Nessuno sapeva chi fosse, ma apparteneva all’antica stirpe e aveva i lineamenti di un faraone. I fellah s’inginocchiavano al suo passaggio senza sapere perché; diceva di essere uscito dal buio di ventisette secoli e di aver udito messaggi che non venivano dal nostro pianeta. Olivastro, snello e sinistro, Nyarlathotep venne nei paesi sviluppati e si diede alla ricerca di strani oggetti di vetro e metallo, che poi combinava in strumenti fantastici. Parlava molto di scienza, di elettricità e psicologia e dava tali dimostrazioni di potenza da lasciare ammutoliti quelli che vi assistevano. La sua fama dilagava: gli uomini consigliavano gli uni agli altri di vederlo, ma poi avevano paura. Dove arrivava Nyarlathotep era la fine della tranquillità e di notte risuonavano grida da incubo. Le urla generate dai sogni non erano mai state, prima d’allora, un problema pubblico, e gli uomini che avevano a cuore la sorte delle cose avrebbero voluto che si potesse proibire alla gente di dormire dopo la mezzanotte; era quella l’ora in cui le urla della città risuonavano più orribilmente sotto la luna pallida; e la luna splendeva sulle verdi acque che scorrevano sotto i ponti e sulle antiche guglie sbrecciate, nello sfondo d’un cielo malato.
Ricordo quando Nyarlathotep arrivò nella mia città, una grande, vecchia e terribile città di crimini infiniti. Un amico mi aveva parlato di lui – del fascino sottile e irresistibile delle sue rivelazioni – e il desiderio di scoprire i suoi reconditi misteri m’ossessionava. Il mio amico sosteneva che fossero tremendi, ben al di là delle mie più fantastiche supposizioni, e aggiunse che le immagini proiettate sullo schermo, nella sala buia dove Nyarlathotep teneva le sue conferenze, corrispondevano a profezie che lui soltanto osava fare, e che nel balenare dei fotogrammi venisse rubato agli uomini ciò che mai prima era stato rubato loro: ciò che soltanto negli occhi è percepibile. Seppi che in altri paesi si mormorava che chi aveva conosciuto Nyarlathotep fosse in grado di vedere cose che agli altri erano nascoste.
Nell’autunno sempre più caldo mi spinsi nella notte tra la folla che andava a vedere Nyarlathotep; mi spinsi nella notte soffocante e salii scalinate interminabili, entrando nella sala stipata di gente. Sullo schermo vidi esseri incappucciati che si aggiravano tra cumuli di rovine, volti maligni e gialli che sbirciavano dietro monumenti caduti; vidi il mondo lottare contro la tenebra, contro il flagello della distruzione che si abbatteva dallo spazio esterno. Lo vidi girare sempre più veloce, impazzito, sfrenato, intorno al sole che s’oscurava e raffreddava, poi la luce che sfarfallava sullo schermo, e nella sala, si addensò follemente sugli spettatori e i capelli della gente si rizzarono, mentre ombre grottesche e apparse all’improvviso si acquattavano sulle nostre teste.
Io, che mi credevo più freddo e meno emozionato degli altri, insinuai con un brivido che eravamo di fronte a un’impostura e che il fenomeno era dovuto all’“elettricità statica”; Nyarlathotep ci condusse allora tutti fuori, giù per scale vertiginose e nelle strade afose e deserte di mezzanotte. Urlai che non avevo paura, che mai avrei avuto paura, e altri gridarono con me per darsi coraggio. Giurammo che la città era sempre la stessa, che era ancora un posto per i vivi, e quando le luci cominciarono a spegnersi maledicemmo la compagnia elettrica e ridemmo delle maschere che erano diventate le nostre facce.
Poi ci accorgemmo che dalla luna verdastra scendeva qualcosa, e quando ogni luce si fu spenta e non rimase che il suo fioco chiarore, ci dividemmo inconsciamente in tante curiose formazioni e ci avviammo verso una meta che avevamo l’impressione di conoscere, anche se non osavamo pensarci. Camminando notammo che la pavimentazione era sbreccata e solo una traccia di metallo arrugginito indicava il vecchio percorso del tram. Un poco più avanti un tram si era rovesciato su un fianco, malconcio e senza vetri. Guardando verso l’orizzonte non si scorgeva il terzo grattacielo vicino al fiume e notammo che la sagoma del secondo era spezzata verso la cima.
Ci dividemmo in gruppi più piccoli, ognuno dei quali trascinato in una direzione diversa. Uno scomparve alla mia sinistra, in una via angusta, lasciandosi alle spalle l’eco di un gemito di terrore; un altro fu inghiottito da un’entrata della metropolitana sommersa fra le erbacce e ci lasciò con una risata folle. Il mio gruppo, invece, fu attratto verso l’aperta campagna e nelle ossa ci si insinuò un gelo del tutto estraneo a quell’autunno torrido. Scivolando nella cupa brughiera vedemmo intorno a noi il biancore infernale della neve, da cui la luna traeva maligni luccichii.
Neve intatta, inspiegabile, spinta dal vento in un’unica direzione, verso un abisso reso ancora più nero, per contrasto, dalle sue pareti scintillanti. Ora il mio gruppo sembrava più sparuto e, come in un sogno, sprofondò nel baratro... Io ero l’ultimo. Indugiando, mi trattenni sull’orlo dell’abisso perché il riflesso verde sulla neve mi agghiacciava e man mano che i miei compagni scomparivano mi pareva di udire un lamento inquietante. Ma ormai non potevo indugiare oltre: come chiamato da quelli che m’avevano preceduto, spinto dalle tremende raffiche di neve, scorato e tremante per un attimo volteggiai sul cieco vortice dell’imponderabile... poi precipitai.
Solo gli dèi che furono potrebbero stabilire se fossi ancora lucido o in preda a un muto delirio; io non sono che lo spettro di un’ombra che si contorce in mani che non sono mani e vortica ciecamente oltre le mezzanotti popolate di fantasmi d’un creato putrescente, oltre i cadaveri di mondi morti solcati da piaghe che furono città, oltre i venti sepolcrali che spazzano le stelle evanescenti e ne attenuano il chiarore. Al di là dei mondi, vaghi fantasmi di cose mostruose, indistinte colonne di templi blasfemi che poggiano su massi senza nome al di sotto dello spazio e raggiungono vuoti vertiginosi sopra le sfere della luce e della tenebra. E su tutto, in questo ripugnante cimitero dell’universo, si ode un sordo e pazzesco rullo di tamburi, un sottile e monotono lamento di flauti blasfemi che giungono da stanze inconcepibili, senza luce, di là dal Tempo; la detestabile cacofonia al cui ritmo danzano lenti, goffi e assurdi i giganteschi, tenebrosi ultimi dèi. Le cieche, mute, stolide abominazioni la cui anima è Nyarlathotep.
L’estraneo
Titolo originale: The Outsider, 1921
Traduzione di Giuseppe Lippi
Quella notte il Baro...
Indice dei contenuti
- Copertina
- I capolavori
- Introduzione - Un classico del fantastico - di Giuseppe Lippi
- Cronologia - A cura di Kenneth Faig
- Bibliografia essenziale
- Nota sui racconti
- I capolavori
- Copyright