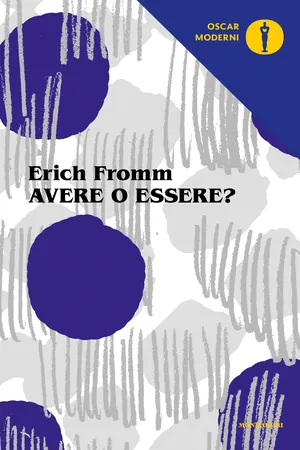
- 252 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Avere o essere?
Informazioni su questo libro
La prevalenza della modalità esistenziale dell'avere ha determinato la situazione dell'uomo contemporaneo: ridotto a ingranaggio della macchina burocratica; manipolato nei gusti, nelle opinioni e nei sentimenti dai governi, dall'industria, dai mass media; costretto a vivere in un ambiente degradato. Contro questo modello dominante, Fromm delinea le caratteristiche di un'esistenza incentrata sulla modalità dell'essere, in quanto attività autenticamente produttiva e creativa, capace di offrire all'individuo e alla società la possibilità di realizzare un nuovo e più profondo umanesimo.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Parte terza
L’UOMO NUOVO E LA NUOVA SOCIETÀ
VII
Religione, carattere e società
In questo capitolo si discute la tesi secondo cui i mutamenti sociali interagiscono con i mutamenti del carattere sociale. Sempre secondo tale tesi, gli impulsi «religiosi» forniscono l’energia necessaria a persuadere uomini e donne a provocare drastici mutamenti sociali; di conseguenza, una nuova società può sorgere solo a patto che una profonda trasformazione si verifichi nel cuore umano, che cioè un nuovo oggetto di devozione prenda il posto dell’attuale.1
I fondamenti del carattere sociale
Il punto di partenza delle riflessioni che seguono è costituito dal concetto secondo cui la struttura caratteriale dell’individuo medio e la struttura socioeconomica della società di cui l’individuo stesso fa parte sono dipendenti l’una dall’altra. Definisco carattere sociale la fusione della sfera psichica individuale e della struttura socioeconomica. (Molto tempo fa, precisamente nel 1932, mi ero servito, per esprimere questa realtà, dell’espressione «struttura libidica della società».) La struttura socioeconomica di una società plasma il carattere sociale dei suoi membri in modo tale che essi desiderano fare ciò che devono fare. D’altro canto, il carattere sociale influenza la struttura socioeconomica della società, fungendo sia da cemento inteso ad assicurare ulteriore stabilità alla struttura sociale sia, in circostanze particolari, da dinamite che tende a far saltare la struttura sociale stessa.
Carattere sociale e struttura sociale
Il rapporto tra questi due elementi non è mai statico, dal momento che, in questo nesso, entrambi agiscono da processi senza fine; ne consegue che un mutamento che si verifichi in uno dei due settori comporta il cambiamento di ambedue. Molti rivoluzionari sostengono che bisogna innanzitutto mutare radicalmente la struttura politica ed economica perché allora, in una seconda e quasi inevitabile fase, anche la mente umana subirà un cambiamento; in altre parole, che la nuova società, una volta costituita, quasi automaticamente produrrà il nuovo essere umano. Costoro non si rendono conto che la nuova élite, cui le motivazioni sono date dallo stesso carattere precedente, tenderà a ricreare le condizioni della vecchia società in seno alle nuove istituzioni sociopolitiche fatte sorgere dalla rivoluzione; e cioè la vittoria della rivoluzione segnerà la sua sconfitta in quanto rivoluzione, ancorché non in quanto fase storica che ha spianato la strada a uno sviluppo socioeconomico che procedeva a rilento e non poteva realizzarsi appieno. Le rivoluzioni francese e russa ne costituiscono esempi da manuale; ed è degno di nota il fatto che Lenin, il quale non aveva mai creduto che la qualità del carattere avesse importanza ai fini della funzione rivoluzionaria di un individuo, abbia mutato drasticamente punto di vista nell’ultimo anno di vita, quando si rese perfettamente conto delle deficienze caratteriali di Stalin e, nel suo testamento, richiese che, proprio a causa di tali difetti, Stalin non divenisse suo successore.
Al polo opposto si collocano coloro i quali sostengono che deve cambiare prima la natura degli esseri umani, cioè la loro coscienza, i loro valori, i loro caratteri, e che soltanto allora si potrà edificare una società davvero umana. La storia della nostra specie comprova che costoro hanno torto: i mutamenti puramente psichici sono sempre rimasti confinati nella sfera privata, limitati a piccole oasi, o si sono rivelati del tutto inefficaci quando la predicazione di valori spirituali si è combinata alla pratica dei valori di segno opposto.
Carattere sociale e bisogni «religiosi»
Il carattere sociale ha anche un’altra e significativa funzione, oltre a quella di servire ai bisogni che la società ha di un certo tipo di carattere e oltre a soddisfare le esigenze dell’individuo, condizionate dal carattere; il carattere sociale, infatti, deve soddisfare anche i bisogni religiosi impliciti in ogni essere umano. Mi spiego: il termine «religione», quale viene da me qui usato, non si riferisce necessariamente a una concezione di Dio o a idoli, e neppure a un sistema inteso come religione, bensì a ogni sistema di pensiero e azione condiviso da un gruppo che offra a un individuo un mezzo di orientamento e un oggetto di devozione. In effetti, se si usa la parola in questa amplissima accezione, nessuna cultura del passato o del presente, e sembrerebbe anche nessuna cultura del futuro, può essere concepita come priva di religione.
La definizione che qui se ne dà non ci dice nulla in merito ai suoi contenuti specifici. Gli uomini possono adorare animali, alberi, idoli d’oro e di pietra, un dio invisibile, un individuo ritenuto santo, un diabolico capo; adorare i propri antenati, la propria nazione, classe o partito, il denaro o il successo. La loro può essere una religione che conduce allo sviluppo della distruttività oppure dell’amore, allo sviluppo dell’autoritarismo oppure della solidarietà; essa può favorire la capacità di ragionare come pure paralizzarla. La gente può essere conscia che il proprio sistema è religioso, diverso da quelli che appartengono all’ambito profano, oppure ritenersi priva di religione, e interpretare la propria devozione a certe mete presuntamente profane, quali potere, denaro, successo, come null’altro che una preoccupazione per il pratico e il vantaggioso. Il problema non è però formulabile con la domanda: religione o no?, ma soltanto come: che tipo di religione? E ciò, sia che questa serva a favorire lo sviluppo umano, di specifici poteri umani, oppure che sia volta a paralizzare la crescita dell’uomo.
Una religione specifica, a patto che risulti efficace nella motivazione del comportamento, non è una somma di dottrine e credenze: ha radici in una specifica struttura caratteriale dell’individuo e, in quanto è la religione di un gruppo, nel carattere sociale. Ne consegue che il nostro atteggiamento religioso può essere ritenuto un aspetto della nostra struttura caratteriale, in quanto noi siamo ciò per cui proviamo devozione, che a sua volta costituisce il movente del nostro comportamento. Accade tuttavia sovente che gli individui non siano affatto consapevoli dei veri oggetti della loro devozione personale e scambino le loro credenze «ufficiali» per la loro religione effettiva, ancorché segreta. Così, per esempio, se un tale adora il potere pur professando una religione d’amore, la sua segreta religione è quella del potere, mentre la sua cosiddetta religione ufficiale, per esempio il cristianesimo, non è che un’ideologia.
Il bisogno di religione è radicato nelle fondamentali condizioni di esistenza della specie umana. La nostra è una specie a sé stante, come lo è quella degli scimpanzé, dei cavalli o dei cigni. Ogni specie può essere, ed è, definita dalle sue specifiche caratteristiche fisiologiche e anatomiche. Per lo più, si è d’accordo sulla definizione della specie umana in termini biologici; io ho avanzato l’ipotesi che la specie umana, vale a dire la natura umana, possa essere definita anche psicologicamente. Nell’evoluzione biologica del regno animale, la specie umana prende forma nel momento in cui due tendenze dell’evoluzione animale si incontrano, una di esse è costituita dalla sempre minore determinazione del comportamento a opera degli istinti (dove il termine «istinti» non è usato nell’accezione ormai superata, cioè come qualcosa che esclude l’apprendimento, bensì nel senso di impulsi organici). Anche tenendo conto delle molte opinioni controverse circa la natura degli istinti, di solito si ammette che più alto è il livello raggiunto da un animale nel processo evolutivo, tanto meno il suo comportamento è determinato da istinti filogeneticamente programmati.
Il processo di sempre decrescente determinazione del comportamento a opera degli istinti può essere concepito come un continuum, a un’estremità del quale troviamo le forme intime di evoluzione animale, con il massimo grado di determinazione istintuale; questa decresce a mano a mano che si procede lungo l’evoluzione animale, raggiungendo un certo livello con i mammiferi; cala ulteriormente in concomitanza con lo sviluppo che porta ai primati, e anche qui ci si imbatte in un grande abisso tra scimmie inferiori e scimmie antropomorfe, come R.M. Yerkes e A.V. Yerkes hanno dimostrato nel 1929 con la loro ormai classica ricerca. Nella specie Homo, la determinazione istintuale ha toccato il proprio minimo.
L’altra tendenza, reperibile nell’evoluzione umana, è la crescita del cervello, soprattutto del neopallio. Anche in questo caso, possiamo interpretare l’evoluzione come un continuum: a un’estremità, gli animali inferiori, dotati di una struttura nervosa oltremodo primitiva e muniti di un numero di neuroni relativamente ridotto; all’altra estremità, l’Homo sapiens, dotato di una struttura cerebrale più ampia e più complessa, e soprattutto di un neopallio che ha dimensioni tre volte maggiori di quelle dei nostri antenati primati, nonché di un numero di connessioni interneuroniche davvero stupefacente.
In base a questi elementi, la specie umana può essere definita come un gruppo di primati che sono emersi nel momento dell’evoluzione in cui la determinazione istintuale ha raggiunto un minimo e lo sviluppo del cervello un massimo. Questa combinazione di minima determinazione istintuale e massimo sviluppo cerebrale non si era mai verificata prima nel corso dell’evoluzione animale e, sotto il profilo biologico, rappresenta un fenomeno completamente nuovo.
Mancando della capacità di agire in obbedienza agli istinti, mentre d’altro canto possiede quella dell’autoconsapevolezza, della ragione e dell’immaginazione – tutte nuove qualità che trascendono la capacità di elaborazione mentale strumentale anche dei più intelligenti fra i primati –, la specie umana aveva bisogno di un sistema referenziale di orientamento e di un oggetto di devozione per poter sopravvivere.
Senza una mappa del nostro mondo naturale e sociale – senza cioè un’immagine del mondo e del proprio posto in esso che sia strutturato e dotato di coesione interna –, gli esseri umani sarebbero in preda alla confusione e incapaci di agire secondo uno scopo e in maniera coerente, perché non avrebbero modo di orientarsi, di trovare un punto fisso il quale permetta loro di organizzare tutte le impressioni da cui è investito ogni singolo individuo. Il nostro mondo ha per noi un senso, e noi ci sentiamo certi delle nostre idee, grazie al consenso di coloro che ci circondano. La mappa assolve alle sue funzioni psicologiche anche qualora sia errata. Ma la mappa non è mai stata del tutto errata, e d’altro canto non è mai stata neppure esatta: è sempre stata un’approssimazione sufficiente alla spiegazione di fenomeni che servono allo scopo del vivere. Solo allorché la pratica del vivere è liberata dalle sue contraddizioni e dalla sua irrazionalità, la mappa può corrispondere alla realtà.
Il fatto fondamentale è che finora non si è avuta notizia di nessuna cultura in cui non esista un simile sistema referenziale di orientamento; e ciò vale anche per ciascun individuo. Accade sovente che i singoli neghino di essere in possesso di un siffatto quadro generale e siano persuasi di rispondere ai vari fenomeni e incidenti della vita volta per volta, caso per caso, obbedendo alla guida della propria facoltà di giudizio; ma è facile dimostrare che costoro semplicemente danno per scontata la loro personale filosofia, perché ai loro occhi questa costituisce una manifestazione di buon senso, né si rendono conto che tutti i loro concetti si fondano su un sistema referenziale comunemente accettato. Quando costoro sono posti di fronte a una visione totale della vita sostanzialmente diversa, la giudicano «pazzesca» ovvero «irrazionale» oppure «infantile», considerando invece se stessi perfettamente «logici». Il profondo bisogno di un sistema referenziale risulta con particolare evidenza nei bambini. A una certa età, questi spesso elaborano il loro sistema referenziale di orientamento in maniera ingegnosa, servendosi dei pochi dati che hanno a disposizione.
Ma una mappa non costituisce una guida sufficiente all’azione; abbiamo anche bisogno di una meta verso la quale dirigerci. Gli animali non hanno problemi del genere: è il loro istinto a fornirli insieme di una mappa e di mete. Al contrario, noi, carenti come siamo di determinazioni istintuali, e in pari tempo muniti di un cervello che ci permette di pensare alle molte direzioni in cui possiamo muoverci, abbiamo bisogno di un oggetto di devozione totale, di un punto focale di tutti i nostri sforzi, che sia insieme la base costitutiva di tutti i nostri valori effettivi e non soltanto proclamati. Se un oggetto di devozione del genere ci occorre, è perché grazie a esso possiamo indirizzare le nostre energie in una direzione unica, trascendendo la nostra esistenza isolata con tutti i suoi dubbi e le sue insicurezze, e soddisfacendo insieme il nostro bisogno di dare un significato alla vita.
La struttura socioeconomica, la struttura caratteriale e la struttura religiosa sono inseparabili l’una dall’altra. Se il sistema religioso non corrisponde al carattere sociale prevalente, se è in conflitto con la pratica sociale della vita, esso non è che una ideologia; in tal caso, dobbiamo cercare al di là di esso la vera struttura religiosa, anche se può accadere che non ne abbiamo consapevolezza in quanto tale, a meno che le energie umane implicite nella struttura religiosa del carattere non fungano da dinamite e tendano a minare le condizioni socioeconomiche date. Tuttavia, poiché sempre si danno eccezioni individuali al carattere sociale dominante, si danno anche eccezioni individuali al carattere religioso dominante, e queste sono rappresentate assai spesso dalle guide di rivoluzioni religiose e dai fondatori di nuove religioni.
L’orientamento «religioso», in quanto costituisce il nucleo esperienziale di tutte le religioni «superiori», subisce per lo più gravi deformazioni nel corso dello sviluppo di queste. Non importa l’idea che gli individui a livello conscio si fanno dei loro personali orientamenti; possono essere benissimo «religiosi» senza ritenersi affatto tali, oppure non essere affatto religiosi, pur ritenendosi cristiani. Non disponiamo di un termine atto a denotare il contenuto esperienziale della religione, tale da isolarla dai suoi aspetti concettuali e istituzionali; per questa ragione, mi sono servito delle virgolette per designare «religioso» in senso esperienziale, soggettivo, indipendentemente dalla struttura sociale in cui trova espressione la «religiosità» dell’individuo.2
Il mondo occidentale è cristiano?
Stando ai libri di storia e all’opinione della maggioranza, la conversione dell’Europa al cristianesimo ebbe luogo, entro i confini dell’impero romano, sotto Costantino; a essa fece seguito la conversione dei pagani dell’Europa settentrionale a opera di Bonifacio, detto l’«apostolo dei Germani», e di altri nell’VIII secolo. Ma l’Europa fu davvero cristianizzata?
Nonostante la risposta affermativa che di solito viene data a questa domanda, un’analisi più attenta comprova che la conversione dell’Europa al cristianesimo è stata in larga misura fittizia; e che si potrebbe tutt’al più parlare di una limitata conversione al cristianesimo tra il XII e il XVI secolo, mentre per i secoli precedenti e successivi la conversione è stata, nella stragrande maggioranza dei casi, soltanto un’ideologia, oltre che una sottomissione, più o meno effettiva, alla chiesa; essa non ha comportato un mutamento interiore, cioè della struttura caratteriale, eccezion fatta per un certo numero di movimenti genuinamente cristiani.
Durante questi quattro secoli, l’Europa fu dunque sottoposta a un iniziale processo di cristianizzazione; la chiesa, cioè, tentò di imporre l’applicazione di principi cristiani per quanto riguarda la proprietà, i prezzi delle merci e l’aiuto ai poveri. Si assistette al sorgere di molte sette e di capi religiosi parzialmente eretici, in gran parte per l’influenza del misticismo che esigeva il ritorno ai principi del Cristo, tra i quali la condanna della proprietà privata. Il misticismo stesso, che ebbe il suo massimo rappresentante in Meister Eckhart, svolse dunque un ruolo decisivo in questo movimento antiautoritario e umanistico e, nient’affatto per caso, le donne assunsero una posizione predominante sia come insegnanti sia come allieve di misticismo. Molti pensatori cristiani si fecero portavoce delle idee di una religione universale o di un semplice cristianesimo non dogmatico e venne posta in discussione persino la concezione biblica di Dio. Gli umanisti, teologi e non, del Rinascimento, con la loro filosofia e con le loro utopie, continuarono a seguire l’indirizzo del XIII secolo, e in effetti tra il tardo Medioevo, il cosiddetto Umanesimo, e il Rinascimento vero e proprio, è impossibile individuare una linea divisoria netta. Mi servirò di una citazione da Frederick B. Artz, che ne dà un quadro sintetico, per delineare le caratteristiche spirituali del pieno e del tardo Rinascimento:
Per quanto riguarda la società, i grandi pensatori medioevali ritenevano che tutti gli uomini siano uguali agli oc...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Prefazione
- La Grande Promessa, il suo fallimentoe nuove alternative
- Parte prima - Come comprendere la differenza tra avere ed essere
- Parte seconda - Analisi delle differenze fondamentali tra le due modalità esistenziali
- Parte terza - L’uomo nuovo e la nuova società
- Bibliografia
- Copyright
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Avere o essere? di Erich Fromm, Francesco Saba Sardi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Psicologia e Filosofia sociale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.