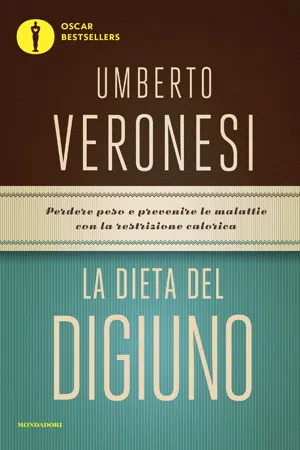Quando mi hanno chiesto di scrivere un libro sull’alimentazione, mi sono stupito. Un digiunatore come me, un vegetariano, una persona che fra le tante passioni della vita non ha mai messo il cibo, come potrebbe dare un contributo utile e reale? Per parlare di alimentazione, infatti, è necessario conoscere l’argomento, e ciò mi è concesso dalla lunga vita di scienziato e dalle ricerche sulla prevenzione, sulla biochimica dell’alimentazione e soprattutto sull’interazione tra il cibo e il nostro corpo. Ma è anche utile, forse, avere una visione della stessa alimentazione un po’ differente dalla mia. Non leggerete in queste pagine che mangiare è un piacere: considero un piacere l’aggregazione tra persone, il pensiero condiviso insieme alle parole, anche in occasioni conviviali, ma il cibo in sé non è un piacere, almeno per me.
Tuttavia, nella società attuale, nei paesi industrializzati che hanno quasi dimenticato cosa significhi avere fame e lottare per sopravvivere agli stenti, una riflessione sull’alimentazione può offrire tante opportunità di ragionamento e stimolare anche il progresso, l’evoluzione. Forse può aggiungere maggiore cultura e consapevolezza rispetto al cibo. Oggi mangiare per noi è scontato, come scontato è lo spreco: possiamo perfino permetterci di scegliere, inventare, sperimentare, perché è molto improbabile che ci manchino le risorse fondamentali per il sostentamento. Mangiare è un atto istintivo e ovvio che abbiamo trasformato in rito, elemento culturale, piacere, oggetto di ricerca, demone e divinità.
Proviamo dunque a ritornare alla scienza, alle origini. Alimentarsi è un bisogno, questo è certo. Senza mangiare non si vive (si può digiunare per alcuni giorni, non indefinitamente), ma anche mangiando troppo, allo stesso modo, si riduce la prospettiva di sopravvivenza. Mangiare pochissimo o per niente fa male, ma fa altrettanto male mangiare troppo.
Alimentarsi con criterio dovrebbe fare parte dei doveri che si inculcano nella mente dei bambini nei primi anni di vita. Siamo in un’epoca che vive enormi scissioni: ci sono divisioni sociali e differenze economiche scandalose tra paesi; ci sono iniquità nella distribuzione degli alimenti che derivano da scelte dissennate e da una scala di priorità che non ha mai tenuto conto dell’essere umano e del suo diritto di vivere in uguaglianza e pace. Eppure anche nella nostra società, dove comunque la miseria non può essere paragonata a ciò che si vive nel cosiddetto terzo mondo, l’ignoranza e la trascuratezza hanno portato al caos assoluto in materia di gestione alimentare e, dunque, di salute pubblica. Alimentazione e salute hanno infatti un legame molto stretto, che si conferma ogni giorno di più e trova riscontro nei dati della ricerca scientifica.
Se vogliamo parlare di amore, mangiare è uno degli atti più istintivi dell’amore. L’amore dei genitori per i figli in ogni specie animale, l’amore per il proprio partner (quante volte i modi di dire ci ricordano che per tenerci un uomo o una donna dobbiamo anche «prenderlo/a per la gola»?), l’amore per gli animali, per gli amici, per i conoscenti che vogliamo conquistare, vezzeggiare, incuriosire… l’amore per il cibo in se stesso! Mangiare può essere una passione, un vero e proprio talento: quanti grandissimi cuochi ci vengono in mente, quante persone che hanno saputo creare piatti indimenticabili e rinomati nel mondo… Ma c’è anche l’amore per il benessere del corpo e della psiche: amare se stessi dovrebbe prevedere una cultura alimentare rigorosa, nella quale applicare ciò che si è scoperto grazie alla divulgazione dei risultati della scienza. Circa il 50% delle malattie più gravi e invalidanti è riconducibile allo stile di vita, e stile di vita significa anche alimentazione. Ecco perché diventa ovvio che scegliere di alimentarsi correttamente rappresenti una specie di assicurazione sulla vita: magari non ci dà la certezza di non ammalarci, ma ci aiuta a rafforzare le probabilità di salute e costituisce comunque un forte baluardo nella ripresa rapida e nella tolleranza delle terapie in caso di malattia. Anche questo è amore. L’alimentazione racchiude una grande dose di amore.
Prima di proseguire, penso sia utile puntualizzare un termine che scatta immediato e istintivo parlando di cibo e salute: «prevenzione». Si dice infatti che mangiare bene sia una forma di prevenzione, ma cosa significa ciò precisamente?
La prevenzione primaria è quel che posso fare io per rendere minore il rischio di ammalarmi: un comportamento, una sostanza da assumere o da evitare che allontanino la malattia dal mio futuro. L’elisir di lunga vita! Un esempio evidentissimo è evitare di fumare, per ridurre il rischio di tumore e di malattie cardiovascolari; un altro esempio è scegliere di mangiare bene e poco ogni giorno, per far sì che le mie probabilità di salute siano le più alte per tutta la vita. La prevenzione secondaria, invece, corrisponde alla diagnosi precoce: non sa agire sulle cause di una malattia, non fa nulla per evitare il suo manifestarsi, ma è in grado di scoprirla quando è talmente piccola e iniziale da non avere ancora provocato danni all’organismo. Ecco che quindi la mammografia, il PAP test, la TC spirale nei fumatori, il controllo dei nei della pelle sono tutti esempi di prevenzione secondaria.
Con la prevenzione non si ha la certezza assoluta di non ammalarsi, e infatti questa è la critica più frequente (e banale) che sento muovere ai suggerimenti preventivi: perché mai dovremmo adottare uno stile di vita corretto se poi ci ammaliamo ugualmente? «Certezza», una parola che ha poco senso in ogni ambito dell’esistenza, e in medicina meno che mai. Sapete che non è certo che guarisca nemmeno un raffreddore? Tuttavia, la parola «certezza» può essere sostituita, con maggiore realismo e con un’accezione positiva, da «probabilità»: quale probabilità vogliamo avere di vivere a lungo e bene? Quale probabilità accettiamo che un nostro stile di vita scorretto ci faccia ammalare precocemente, rispondere male alle cure e morire prima di quanto avremmo desiderato? Fare prevenzione è investire in salute, sapendo che nessuno ci fa firmare un contratto di sicura ed eterna giovinezza, ma un piano di investimento in benessere, quello sì.
Ci alimentiamo o ci nutriamo?
Un’altra puntualizzazione necessaria è la differenza tra alimentazione e nutrizione. L’alimentazione è un atto consapevole e cosciente, è la scelta di introdurre nel nostro corpo cibi che ci danno energia, sotto forma di calorie. Nella definizione popolare corrisponde a: «Mangio per tenermi su», dove il «tenersi su» significa rifornirsi di calorie, di forza energetica appunto. La nutrizione invece non è un atto consapevole e cosciente, anche se (almeno in parte) dovrebbe diventarlo: si tratta dell’introduzione nel nostro corpo, attraverso il cibo, di sostanze ed elementi fondamentali per la loro efficacia biologica. I cibi si differenziano per contenuto e composizione. Parliamo di vitamine, oligoelementi, sali minerali: sono tutte sostanze vitali per noi, presenti in quantità variabile in ciò che mangiamo. Le introduciamo nell’organismo grazie alla nutrizione; forse non ne siamo consapevoli, ma esse ci aiutano a vivere.
Tante persone si alimentano, o addirittura si sovralimentano, ma non si nutrono, e le conseguenze di ciò possono essere gravi. Alimentarsi senza essere consapevoli della presenza o dell’assenza nei cibi di elementi e sostanze per noi vitali (alimentarsi senza nutrirsi, in definitiva) espone a molti rischi. Pensiamo all’epoca in cui i cinesi mangiavano quasi esclusivamente riso; in effetti si alimentavano, ma non si nutrivano: mancava in particolare nella loro dieta la vitamina A, la cui carenza cronica portava a forme irreversibili di cecità.
Ecco perché la cultura alimentare è alla base della salute. Non è ammissibile alimentarsi senza essere consapevoli di quanto e di come ci si nutra. Così come non è ammissibile alimentare senza nutrire chi è in difficoltà! Ricorrere a pillole, supplementi e integratori non è necessario (se non in casi rarissimi identificati dai medici), perché la nutrizione, in realtà, è possibile e semplice grazie alle informazioni che ci vengono offerte dai ricercatori.
Alimentarsi non è nutrirsi. Non abbiamo bisogno solo di energia, ma anche di tanti componenti chimici legati alla nutrizione. La salute e la malattia dipendono dalla loro corretta assunzione, che è una conseguenza di ciò che decidiamo di mangiare.
Piccola storia dell’alimentazione
Capita che chi è vegetariano tenti di ricostruire la storia dell’alimentazione per spiegare la propria scelta: i primi uomini erano vegetariani, quindi dovremmo esserlo anche noi. Una ricostruzione di questo genere è poco scientifica perché non tiene conto dell’evoluzione.
Siamo ciò che i nostri geni stabiliscono, ma anche ciò che suggeriscono l’ambiente e la necessità. Che i primi uomini mangiassero solo vegetali è vero, ma è altrettanto vero che la caccia e la cottura della carne degli animali hanno potuto diffondersi solo quando l’addomesticamento del fuoco e la costruzione di utensili lo hanno consentito. A prescindere dall’anatomia e dalla fisiologia dei primi uomini, a un certo punto la carne è entrata a far parte delle nostre abitudini alimentari. Per me la scelta vegetariana è etica, è un segno di evoluzione, di elevazione del pensiero, e non rimanda a un passato che conosciamo in parte e che non può certo giustificare il nostro oggi.
I nostri più lontani antenati sono detti ominidi e avevano la caratteristica di adattarsi bene ai cambiamenti alimentari. Dall’Africa si diffusero al resto del pianeta, acclimatandosi a ogni latitudine. Non erano cacciatori ma raccoglitori (alcuni li definiscono «opportunisti»): trovavano cioè il cibo nell’ambiente dove vivevano. Pensiamo a quali strumenti siano necessari per uccidere un animale e quali invece permettano di alimentarsi senza la fatica e il pericolo della caccia: si intuisce facilmente che la fonte preferenziale di cibo per Homo (l’ominide vissuto tra due milioni e duecentomila anni fa in Africa, Europa e Asia) non fossero belve feroci ammazzate durante vivaci e ardimentose sessioni di caccia. Homo raccoglieva radici, frutti, bacche, tuberi e uova; gli animali che facevano parte della sua alimentazione erano molto piccoli oppure già morti per altre cause.
Quando il fuoco diventò un amico, cioè quando si scoprì come dominarlo e usarlo sotto controllo, anche l’alimentazione gradualmente poté cambiare. Si parla di circa quattrocentomila anni fa. Homo diventò cacciatore: quasi centocinquantamila anni fa, l’uomo di Neanderthal (estinto circa quarantamila anni fa) era ormai cacciatore, nomade e mangiava grandi quantità di carne.
Il nostro progenitore più diretto, simile a noi per anatomia, è l’Homo sapiens: si differenzia dalle specie affini per lo sviluppo del cervello e l’organizzazione dei neuroni, oltre a possedere uno scheletro più gracile e una dentizione ridotta. L’Homo sapiens comparve circa duecentomila anni fa in Africa orientale e da lì si spinse in ogni regione del mondo. Per la verità non è chiaro se l’Homo sapiens sia una specie che, diffusa in tutto il pianeta, abbia sostituito le specie allora esistenti, oppure se ciascuna delle attuali popolazioni umane sia derivata dalla specie arcaica che in quella regione specifica abitava. Gli studi più recenti sembrano confermare che l’Homo sapiens sia stato il progenitore di tutta la specie umana.
L’evoluzione cerebrale e la stazione eretta (vera e propria rivoluzione) permisero l’espansione in territori prima inaccessibili e la costruzione di utensili più complessi che favorirono (tra l’altro) un’alimentazione più variata. Stazione eretta, fuoco e utensili: ecco la base per la sopravvivenza. La stazione eretta facilitò il movimento e le migrazioni, che furono anche conseguenza delle condizioni climatiche. Il clima, infatti, era determinante per la possibilità di stabilirsi nelle diverse aree geografiche. Pensiamo alle glaciazioni: l’estensione del ghiaccio e le temperature tremendamente basse che per secoli caratterizzarono una grande superficie della Terra influenzarono l’evoluzione dell’uomo, le sue abitudini di vita (e d’alimentazione) e le migrazioni.
Il nostro pianeta ha vissuto glaciazioni in diverse epoche geologiche. Una glaciazione è composta da fasi di avanzamento (periodi glaciali) e arretramento dei ghiacci (periodi interglaciali). L’Europa ha avuto quattro glaciazioni principali: Günz, Mindel, Riss e Würm. La glaciazione di Würm, terminata circa diecimila anni fa, è la più recente: dalla sua fine il livello del mare è aumentato mediamente di un centimetro l’anno. Durante quest’ultima glaciazione in Europa i ghiacci si estendevano dal Polo Nord alla latitudine di Londra; le Alpi erano coperte da un’unica calotta di ghiaccio che sul versante settentrionale andava fino al Rodano, e su quello italiano arrivava alla pianura, scavando laghi glaciali come il lago Maggiore, il lago di Iseo, il lago di Como, il lago di Garda. In Piemonte, allo sbocco della Val di Susa, il fronte del ghiacciaio formò le colline di Avigliana e Rivoli; il ghiacciaio della Valle d’Aosta, invece, giungeva fino all’attuale Ivrea.
Immaginatevi le conseguenze dell’avanzare e del ritrarsi dei fronti ghiacciati: significava che il clima e i territori si rendevano più o meno favorevoli all’esplorazione e agli insediamenti umani. Durante le glaciazioni i mari regrediscono, ma nei periodi postglaciali avviene il contrario: al culmine dell’ultima glaciazione, per esempio, l’abbassamento del livello del mare arrivò fino a 100 metri, e ventimila anni fa, là dove oggi c’è lo stretto di Bering, una striscia di terra collegava l’America settentrionale all’Asia. Insomma, possiamo comprendere come e perché l’Homo sapiens sia riuscito a compiere imprese come l’attraversamento di quello stretto e il popolamento del continente nordamericano. Altrove, gruppi provenienti dall’Asia sudorientale si spinsero fino in Melanesia e Australia. La fauna a disposizione era ricchissima e purtroppo indifesa. Dopo la glaciazione di Würm il ritiro dei ghiacci rese accessibili zone prima inaccessibili e l’uomo imparò a nutrirsi con ciò che l’ambiente metteva a disposizione, animali compresi.
Nei millenni successivi vi furono epoche di carestia e di maggiore benessere: i ritrovamenti di scheletri e di resti umani e animali testimoniano come l’alimentazione fosse composta da vegetali e proteine animali, con fluttuazioni che hanno fatto pensare a momenti in cui alcune risorse si esaurirono a causa, per esempio, di una caccia indiscriminata.
Nel Neolitico si verificò poi una grande rivoluzione alimentare, che viene definita «domesticazione delle piante e degli animali». Il maiale (per primo), la capra, la pecora e i bovini furono addomesticati e, quasi contemporaneamente, si ottennero anche le prime forme domestiche di orzo, grano, lenticchie e piselli. Nacque l’agricoltura (sembra in Mesopotamia), si ebbe un aumento demografico e la formazione di villaggi permanenti. Anche il corpo dell’uomo si adattò al cambiamento: la dimensione dei denti si ridusse e la carie, favorita dal consumo di cereali, aumentò. La salatura delle carni si era diffusa già da qualche tempo: si aggiunsero le tecniche per immagazzinare il cibo (cereali, legumi) e produrre formaggio. E nacque probabilmente il vino, con la scoperta della possibilità di utilizzare alcune resine vegetali come conservanti. La rivoluzione si diffuse rapidamente dal vicino Oriente all’Occidente: l’agricoltura si adattava benissimo alle diverse aree geografiche e l’economia divenne agricola quasi ovunque. Gli esperimenti di coltivazione e conservazione riguardarono tutte le specie vegetali.
Sulla salute si ebbe tuttavia una conseguenza che sembra quasi paradossale: il maggiore ordine garantito dall’agricoltura e dall’allevamento di alcuni animali portò alla sedentarietà e a una minore varietà di cibo, dunque a carenze nutritive. L’uomo raccoglitore e cacciatore mangiava ciò che riusciva a trovare ed era in sostanziale equilibrio con la natura, quindi poteva variare; l’uomo agricoltore e allevatore, al contrario, si limitava a consumare il cibo che aveva nel proprio piccolo territorio, perdendo così la capacità di muoversi per procacciarsi alimenti adatti alla sopravvivenza. Non dimentichiamo che, soprattutto con le tecniche primitive, solo alcune specie vegetali e animali si prestavano a una domesticazione. In alcune epoche la carenza fu tale da ridurre la vita media delle persone. Inoltre l’agricoltura era faticosa, ancora più faticosa rispetto alla caccia, e dipendeva dai capricci del clima e dalla qualità dei terreni. Per incrementare la produzione nelle epoche di carestia l’uomo pensò che più braccia avrebbero contribuito a migliorare la situazione: ecco allora che la natalità continuò ad aumentare, aggravando di fatto le necessità alimentari in un circolo vizioso che nei periodi di pessimo raccolto si rivelò disastroso.
L’uomo si era scontrato con la difficoltà di addomesticare la natura: finché si era trattato di convivere con animali e vegetali in un reciproco rispetto (salvo le necessità di sopravvivenza) l’espansione era stata quasi facile; ora invece il controllo, cioè la volontà di supremazia sulla natura, aveva complicato tutto. Furono necessari secoli per ritrovare un equilibrio e comprendere che anche agricoltura e allevamento dovevano avere regole, rispettare i cicli naturali e non forzare ciò che per definizione non può essere forzato: la vita.
Adesso facciamo un salto di secoli: dalla nascita dell’agricoltura le coltivazioni si moltiplicarono; creatività, fantasia e necessità economiche portarono a sperimentazioni sempre maggiori, fino alla nascita di un commercio che, in tempi decisamente più recenti, ha dato origine all’industria alimentare. Se cercate notizie sull’industria alimentare siete costretti a addentrarvi in un labirinto difficile da percorrere con coerenza, ed è inevitabile che sia così. Esistono differenze geografiche e nel ritmo di sviluppo, ma anche differenti filosofie commerciali che solo di recente si sono attenuate in una tendenza alla globalizzazione del mercato.
La produzione industriale di alimenti è frutto dell’evoluzione della società, ma ne è anche origine o almeno cofattore: l’industria produce ciò che più «funziona» e piace alla gente, ma è anche in grado di influenzare le preferenze, le scelte e quindi le abitudini alimentari di ciascuno. In qualche modo decide cosa mangeremo nei prossimi giorni, mesi, anni. Avete qualche dubbio in merito? Pensiamo agli alimenti per bambini, che devono essere sani, sostanziosi, privi di effetti nocivi: la loro produzione di massa risponde alle esigenze delle famiglie, che ormai hanno poco tempo e scarso interesse per la preparazione di pietanze con ingredienti specifici e con un giusto dosaggio di zuccheri, sale, grassi e proteine; ma al contempo è anche fortemente in grado di creare, proprio nei bambini, un «gusto» ...