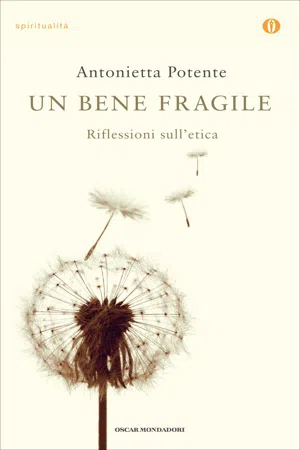![]()
![]()
Ciò che segue è la descrizione di uno spazio familiare non solo a me. Il lettore partendo da questo potrà ripercorrere gli spazi più quotidiani della propria casa e quindi della propria vita. Questo percorso dove non sono mai nominate persone è un esercizio in cui è importante imparare a osservare e riconoscere piccoli e grandi dettagli. Esercizio grazie al quale i luoghi recuperano il loro significato e diventano eloquenti spazi che svelano molto di più di quanto possiamo immaginare.
Appena arrivati ci si trova di fronte a un portone fatto di tavole di legno verniciate di scuro con sfumature tra il marrone e il nero, una specie di cancello che si apre su un giardino ordinato in mezzo a rose, gerani... I suoi colori variano in base alle due stagioni che qui, dove vivo da più di dieci anni, scandiscono il tempo: lunghi periodi di siccità e corte stagioni di piogge.
Lo sguardo si posa subito sull’irregolare facciata della casa e incontra un’altra porta con sopra due finestre: una bocca tra due occhi. Da un lato la cucina, dall’altro la biblioteca. Questa faccia ampia e asimmetrica mi ricorda il volto di uno dei personaggi dipinti da Mirò, o forse quello di un quadro di Pablo Picasso: due artisti che spezzano la monotonia della prospettiva e della simmetria.
Come ogni viso, è segnato dal tempo, perché nel tempo è stato fatto: l’assommarsi progressivo di materiali e interventi, in accordo con la disponibilità dell’ambiente e dell’economia di chi vi abita. Il tetto non è molto sporgente per non privarsi della salutare luce del sole e della freschezza delle piogge che trasformano le tegole in strumenti musicali che ritmano le giornate insieme alle grondaie.
Tutto l’insieme sembra a malapena appoggiarsi su una superficie che, nell’immaginario di chi, come me, è nata sulla costa ligure, potrebbe essere acqua e mare, invece è solo terra. Un terreno da cui talvolta spuntano mais, fave, spinaci o eleganti nardi profumati tra lunghe file di lavanda o alti alberi di eucalipto.
I primi a occupare questo spazio, l’ingresso della casa, sono i cani. A volte sono sospettosi, altre sono riconoscenti, precedono l’ospite e lo accolgono con benevolenza.
Sulla destra un altro dettaglio: un piccolo spazio dove risiede la «memoria del fuoco»1 e che ricorda l’evoluzione dell’umanità, dei ritrovati della tecnica e delle sue tradizioni, una vera e propria tèchne o arte, che oggi convive con la nuova tecnologia. È il luogo dove ancora si può cucinare a legna. Questo spazio dove si cucina a legna è una memoria reale, non un ricordo o un pezzo da museo, in quanto spazio ancor oggi utilizzato; uno spazio che tesse un legame fortissimo tra il presente e il passato. Qui solo la persona più anziana della casa può entrare e renderlo attuale senza alcuno sforzo ideologico o culturale, ma solo con la semplicità e familiarità di consueti gesti ancestrali, con la legna e con il fuoco. Ma anche utilizzando il gas per cucinare non si dovrebbe mai dimenticare che esso è più antico di noi e che è alla base di molte metamorfosi umane socio-culturali e anche politiche ed economiche.2
Tutto ciò costituisce già di per sé un’introduzione all’etica, fatta di acqua, di fuoco o energia; fatta di tempo e soprattutto della quotidianità del suo presente; una lunga preparazione di rituali umani ignoti a tutti, meno a chi li vive.
Entrare in una casa allora è un po’ come accedere all’universo simbolico e pratico di ciò che, nel discorso comune di un gruppo umano, viene chiamato etica. Un mondo che a volte sentiamo nostro e che in altri casi invece semplicemente osserviamo dal di fuori o solamente visitiamo, senza che ci appartenga veramente o ci riguardi in maniera diretta.
![]()
Se proseguiamo la visita della casa ci troviamo di fronte al patio. Il termine “patio”, che indica un cortile interno caratteristico delle case spagnole, per alcuni deriva dal latino patera che, confrontato con il sanscrito patram e il greco potèr, significa “vaso, recipiente per bere”; per altri invece verrebbe dal verbo patere, che significa “essere aperto, esposto”.1
Il patio ha per lo più forma quadrata e su di esso si affacciano le porte di varie stanze: un incrocio di spazi, tra privato e pubblico, proprio come l’etica. Un reticolo che rende l’idea dell’intreccio di dimensioni umane: chiusura e apertura, intimità ed estroversione. Sì, perché il patio a prima vista sembra uno spazio chiuso; in realtà sul patio si aprono delle porte: aperture che consentono il passaggio, che permettono di entrare e uscire a seconda delle necessità. Si tratta di un elemento tipico dell’architettura coloniale dei paesi dell’America latina, caratterizzata da uno stile rurale dove gli ambienti sono collegati fra loro attraverso uno spazio esterno. Sebbene si tratti di una casa edificata secondo uno stile che rispecchia canoni tradizionali, è di recente costruzione.
Questo ci permette di capire che una casa, come l’etica, va oltre la logica del tempo; ciò che la caratterizza non è solo uno stile architettonico specifico ma anche e soprattutto lo stile di chi la abita nel presente. È qualcosa che in accordo con lo spontaneo fluire del tempo presente, il tempo che si conosce, si va progressivamente facendo.
È nel patio comunque che si giocano le dimensioni esistenziali della vita umana. Ogni porta infatti si apre su una diversa dimensione: la cucina, dove ogni giorno si prepara il cibo (quando ciò non avviene all’esterno), si mangia, si condivide il momento iniziale e finale della giornata; le camere, i luoghi del riposo, del sonno, della sosta e della tregua, forse tra gli spazi più intimi della vita di ciascuno di noi; il bagno, il luogo della cura del corpo, del suo benessere e della sua armonia fisico-estetica... Insomma tutti elementi che fanno parte dell’etica e che analizzeremo uno a uno nel corso della riflessione. Elementi che, come abbiamo accennato nella prima parte, a volte sono stati riconosciuti, altre occultati con altri bisogni o esigenze, tra moralismi di ogni sorta.
È comunque in questo patio quasi geometrico che si profila un movimento, il movimento della vita di chi lo abita. Le porte infatti si aprono o si chiudono su spazi che rimandano ai vari interessi di coloro che abitano nella casa: spazi di cui ha bisogno il corpo (per mangiare, dormire, prendersi cura di sé) ma anche la mente, come la biblioteca o lo studio, votati a interessi più intellettuali e interiori; e spazi legati a esigenze di sopravvivenza materiale, quindi pensati sulla base di interessi di natura economica, come il luogo dove si conservano le erbe medicinali o gli attrezzi per la campagna.
Il patio è anche una porta, aperta o chiusa, sulla natura; nel patio abita un giardino con fiori e alberelli, l’unico spazio forse dove la natura si può ancora controllare, coltivare armoniosamente, curare, potare, accudire. Uno spazio in questo caso ridotto, ma che proprio per questo suggerisce l’idea di casa: combinazione di angoli e figure definite; geometria di uno spazio che rivela la possibilità di programmare, suddividere, ordinare e creare rapporti tra interiorità ed esteriorità propri dell’essere umano, liberandolo da tutte le patologie culturali che lo isolano dagli altri, ma al tempo stesso difendendo il suo bisogno di volontaria e salutare solitudine quale garanzia della propria identità.
Quando si guarda una casa è importante osservarne non solo la struttura complessiva ma anche i particolari perché sono questi che rivelano molto di più di quanto tutto l’insieme possa fare. Si tratta di una vera e propria “morfologia domestica”, cioè di uno studio delle forme della casa nei suoi infiniti dettagli. Studio che a sua volta rivela la morfologia stessa di coloro che la abitano.
Il materiale originario della nostra casa è l’adobe: un impasto di terra, acqua, pietruzze e paglia; coperto successivamente da un rivestimento in calce e, infine, dalla novità di un intonaco. Cambiamento di colori in sintonia con i nostri sentimenti e la nostra voglia di abitare, ma anche di proteggersi da fastidiosi insetti che potrebbero annidarsi in fessure lungo le pareti. Attualmente i colori della nostra casa sono in armonia con il paesaggio che la circonda: si tratta di tonalità calde.
La casa, come l’etica, occupa un posto privilegiato nella vita dell’umanità qualora non sia considerata solo come uno strumento del vivere o un oggetto utile per un fine specifico. La casa è infatti molto di più di un semplice strumento per la nostra sopravvivenza. Se la considerassimo solo come tale dovremmo piuttosto paragonarla alla morale e non all’etica. Questa limitante visione strumentale della casa, che preclude infinite possibilità per la vita del singolo individuo e di intere comunità, corrisponde infatti all’idea di una morale rinchiusa nell’ambito ristretto della legge, della norma, che come la casa che ci difende dalle intemperie o dai nemici, offre un “riparo” da possibili errori con il rischio però di soffocare la creatività e il senso di responsabilità dell’uomo.
Non è così per l’etica, itinerario di ricerca costante, sforzo di una crescita interiore ed esteriore per imparare a vivere. Con il filosofo Emmanuel Lévinas possiamo affermare che «il compito privilegiato di una casa non consiste nell’essere il fine dell’attività umana, ma piuttosto nell’esserne condizione e, in questo senso, l’inizio...».2
La casa, come l’etica, è sempre un punto di partenza, la premessa di un modo di stare nella storia o di dialogare con essa che non è solo la mia storia, ma quella di tutti e di tutto.
La casa, come l’etica, è uno spazio frapposto tra noi e il mondo che ci circonda. Non solo un riparo, ma un luogo scelto per riprendere in mano i fili profondi della vita; un ritirarsi nell’intimità per cogliere meglio gli stimoli incessanti che la storia privata e pubblica ci invia come puntuali messaggi.
La casa è possibilità di apertura, non è solo rifugio intimistico, tempo e spazio necessari per non camminare nella storia di fretta, o come estranei o semplici turisti o ospiti. Arriviamo a casa per riposare, ma anche per vivere; nella casa ci sono gli elementi indispensabili per tornare a riaffrontare la vita il giorno successivo, il presente e il futuro.
Nella casa viviamo una dimensione meno frenetica e competitiva, meno “eroica” e solenne, non esercitiamo una professione, ma siamo semplicemente noi stessi; il che equivale a essere, come afferma Lévinas, una semplice realtà anonima lanciata all’esistenza come una pietra dietro alle proprie spalle.3
L’etica è invito ad abitare nel mondo e a muoversi in esso non solo perché abbiamo dei ruoli, ma per il desiderio di stare nel mondo e con il mondo.
L’etica infine è riconoscere che la casa è un diritto di tutti: un essere umano senza casa, senza uno spazio dove fare ritorno, è un essere incompleto. E non si può chiamare casa un dormitorio pubblico, un accampamento o un ghetto, luoghi di emergenza e sopravvivenza, di vita clandestina messa a tacere.
Tutto ciò si chiarirà parlando delle stanze che compongono la casa; e poiché ogni spazio rimanda a qualche aspetto della vita umana sia individuale sia collettiva, avremo modo di affrontare nel corso del libro varie problematiche legate alla politica, all’economia e all’ambiente.
![]()
Uno spazio allungato, che evoca la possibilità per un gruppo umano di estendersi nell’accoglienza; lo spazio di uno dei gesti più comuni, alimentarsi; il tutto simboleggiato dal tavolo allineato alla parete, un esteso rettangolo.
La luce è soffusa, in un gioco di chiaroscuri che si rifrangono sulle pareti color ocra. Gli oggetti rivelano uno spazio dove si prepara qualcosa, ma anche si conserva ciò che serve per vivere. Oggetti che talvolta hanno una funzione solo decorativa, utili per creare uno stile. Diverse tonalità di colori, disposizione disarmonica di sedie pronte a essere spostate e aumentate, ogniqualvolta si aggiunge qualcuno al rituale del pasto.
Un angolo affacciato sul mondo, la televisione, strumento che annichilisce la mente, ma al tempo stesso necessario accessorio in un mondo oramai dominato dalla tecnologia satellitare. Odori e aromi, secondo le ore del giorno; un po’ di frutta sul tavolo, mosaico di elementi inanimati, rappresentazione di una “natura morta”.
Quando si parla di cucina si pensa a un luogo in cui si preparano e si cuociono i cibi, come ricorda la stessa etimologia, un luogo dove, anticamente, il protagonista era il fuoco, il calore. E il calore non è solamente una sensazione legata alla temperatura, ma anche una condizione climatica che l’essere umano subisce e crea al tempo stesso. In senso figurato è premura, amore, accoglienza... un’energia, perché l’etica è anche possibilità e creazione.
L’energia in fisica può essere definita come possibilità di un corpo di compiere un lavoro; come tutto ciò che si può trasformare in calore. In ambito filosofico troviamo il termine enèrgheia, parola adoperata da Aristotele nel senso di “azione efficace, capacità di agire”.
Nel mondo dell’etica non possiamo restare immobili. L’etica è capacità espressiva che ricerchiamo costantemente, consapevoli che questo fa parte dello sforzo esistenziale della vita.
In genere pensiamo che l’energia sia qualcosa che occupa uno spazio fisico. Talvolta, però, timidamente, ci sospingiamo fino ad affermare che il mondo dello spirito è un mondo di energia, anche se di rado riusciamo a comprendere veramente che la vita etica è una manifestazione importante dell’energia umana. Forse nel corso dei secoli questo è ciò che le culture hanno rivendicato maggiormente: essere fonte di energia, di calore, di trasformazione per vivere e creare storia.
Tra fisica e tecnologia troviamo varie forme di energia: meccanica, chimica, nucleare, elettrica, luminosa, termica, biochimica, eolica, idraulica, mareomotrice, geotermica, solare; a me piacerebbe aggiungere una forma di energia poco conosciuta ma affascinante: quella umana.
Secondo un ben noto principio della termodinamica l’energia non si crea né si distrugge, ma si trasf...