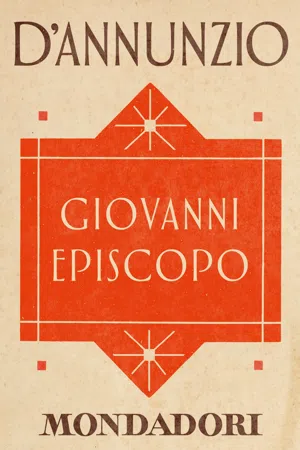![]()
![]()
Illustre signora, mia cara amica, questo piccolo libro che io vi dedico non ha per me importanza di arte; ma è un semplice documento letterario publicato a indicare il primo sforzo istintivo di un artefice inquieto verso una finale rinnovazione.
Fu scritto a Roma nel gennaio del 1891, dopo quindici mesi di completo riposo intellettuale trascorsi in gran parte fra ozii torpidi ed esercizii violenti dentro una caserma di cavalleria. La persona di Giovanni Episcopo era già stata da me osservata e studiata con intensa curiosità, due anni innanzi. Il filosofo Angelo Conti l’aveva conosciuta per la prima volta nel gabinetto d’un medico, all’ospedale di San Giacomo. Io, quel nobile filosofo e il pittore simbolico Marius de Maria avevamo poi frequentato una mortuaria taverna della via Alessandrina per incontrarci col doloroso bevitore. Alcune circostanze bizzarre avevano favorito il nostro studio. (Angelo Conti appunto aveva provveduto la siringa e la morfina pel povero Battista!) Ma il raro materiale, raccolto con la maggior possibile esattezza, era rimasto grezzo in alcune pagine di note.
Voi, così costante e così fiera lavoratrice, non conoscete forse i gravi turbamenti che porta nella conscienza dell’artefice una lunga interruzione del lavoro. Uscito dalla servitù militare, io durai fatica a riprendere le antiche consuetudini dello spirito, ad acquistare una nozione precisa del mio nuovo stato interiore, a raccogliermi, quasi direi a ripossedermi. Compresi allora come sia profonda e inevitabile su noi l’azione pur degli estranei da cui tante diversità ci separano, e come sia più difficile preservare la nostra persona morale che il nostro corpo dai rudi contatti delle moltitudini per mezzo a cui viviamo o passiamo. Nulla, mia cara amica, nulla di quanto crediamo nostro ci appartiene.
Il cavalleggere abituato a restare in sella dieci ore di séguito e a sciabolare in corsa il vento aveva una specie di ripugnanza fisica contro l’immobilità della sedia, contro l’irritante esercizio della scrittura. Alcune settimane plumbee passarono su un malessere indefinibile nel quale spuntavano e si dissolvevano di continuo piccole energie fatue, come le piccole bolle nell’acqua mantenuta in un bollore leggero ma costante da un lento fuoco.
Mi pareva che tutte le mie facoltà di scrittore si fossero oscurate, indebolite, disperse. Mi sentivo in certe ore così profondamente distaccato dall’Arte, così estraneo al mondo ideale in cui un tempo avevo vissuto, così arido, che nessuna instigazione valeva a scuotermi dall’inerzia pesante e triste in cui mi distendevo. Qualunque tentativo riescì vano: nessuna lettura valse a fecondarmi. Le pagine predilette, che un tempo avevano provocato nel mio cervello le più alte ebrezze, ora mi lasciavano freddo. Di tutta la mia opera passata provavo quasi disgusto, come d’una compagine senza vitalità, la quale non avesse più alcun legame col mio spirito e pure mi premesse d’un intollerabile peso. Certi brani di stile, in qualche mio libro di prosa, mi facevano ira e vergogna. Mi parevano vacue e false le più lucide forme verbali in cui m’ero compiaciuto.
Mai artefice ripudiò la sua opera passata con maggior sincerità di disdegno, pur non avendo ancóra in sé l’agitazione dell’opera futura né la conscienza del nuovo potere.
Ma in noi esseri d’intelletto un lavorio occulto si compie, le cui fasi lente non sono percettibili talvolta neppure in parte dai più vigili e dai più perspicaci. Se sul nostro intelletto pende di continuo la minaccia spaventevole o d’una improvvisa lesione o d’una progressiva degenerazione degli organi, in compenso questi medesimi fragili mutevoli organi sono mossi al servizio dell’Arte da attività misteriose e prodigiose che a poco a poco elaborano la materia quasi amorfa ricevuta dall’esterno e la riducono a una forma e a una vita superiori. E l’una e l’altra possibilità, la tragica e la felice, hanno comune il campo oscuro ed immensurabile della nostra inconscienza bruta.
Una sera di gennaio, stando solo in una grande stanza un poco lugubre, io sfogliavo alcune raccolte di note: – materiale narrativo in parte già adoperato e in parte ancóra vergine. Una singolare inquietudine mi teneva. Se bene io fossi occupato alla lettura, la mia sensibilità era straordinariamente vigilante nel silenzio; e io potei osservare, nel corso della lettura, che il mio cervello aveva una facilità insolita alla formazione e alla associazione delle imagini più diverse. Non era quella la prima volta che accadeva in me il fenomeno, ma mi pareva che mai avesse raggiunto un tal grado d’intensità. Incominciavo a vedere, in sensazione visiva reale, le apparenze imaginate. E l’inquietudine si faceva, di minuto in minuto, più forte.
Quando lessi sul frontespizio di un fascicolo il nome di Giovanni Episcopo, in un attimo, come nel bagliore d’un lampo, vidi la figura dell’uomo: non la figura corporea soltanto ma quella morale, prima di aver sotto gli occhi le note, per non so qual comprensiva intuizione che non mi parve promossa soltanto dal risveglio repentino d’uno strato della memoria ma dal segreto concorso di elementi psichici non riconoscibili ad alcun lume d’analisi immediata.
Allora quell’uomo dolce e miserabile, quel Christus patiens, si mise a vivere (innanzi a me? dentro di me?) d’una vita così profonda che la mia vita stessa ne restò quasi assorbita.
Mai, signora, mai da creatura terrestre avevo ricevuta una più violenta commozione. Mai avevo assistito a un più alto e più spontaneo miracolo dell’intelligenza: alla perfetta ricostituzione d’un essere vitale nello spirito di un artefice repentinamente invaso dalla forza creatrice. Mai Giovanni Episcopo era stato più vivo.
E con lui Giulio Wanzer, Ginevra, Ciro, il vecchio, respiravano, palpitavano: avevano i loro sguardi, i loro gesti, le loro voci, un odore umano, qualche cosa di miserevolmente umano che doveva rendere indimenticabili i loro aspetti. E ciascun episodio del dramma doveva aver la potenza di suscitare un brivido non somigliante ad alcun altro. E quella corsa del padre e del figlio, sotto il sole feroce, nel silenzio, nel deserto, a traverso i terreni ingombri di macerie, fra le pozze di calce abbacinanti; e quel loro entrare nella casa muta, luminosa e vacua; e quell’aspettazione misurata mortalmente dai palpiti delle loro arterie; e il grido selvaggio, e il fanciullo avviticchiato al gran corpo di quel bruto, e i colpi di coltello in quella schiena possente, e lo schianto, e il gorgoglio del sangue; e l’agonia di Ciro, in quella stanza, nel crepuscolo, al conspetto dell’ucciso; e poi, nell’ore che seguirono, il padre solo con quei due cadaveri… Ah, mia cara amica, perché ebbi una sì fiera visione e feci una sì debole opera? Perché su la pagina quel gran flutto di forza si attenuò e si spense?
La mattina dopo, mi misi al lavoro. Lavorai con una strana energia, per alcuni giorni, senza altra interruzione che quella del sonno e dei pasti. E avevo sempre d’innanzi agli occhi viva, specialmente nella notte, la figura di Giovanni.
Ecco, mia cara amica, la genesi di questo piccolo libro che io vi dedico. Penso che troverete qui i primi elementi di una rinnovazione proseguita poi nell’Innocente con più rigore di metodo, esattezza di analisi, semplicità di stile.
Tutto il metodo sta in questa formula schietta: – Bisogna studiare gli uomini e le cose DIRETTAMENTE, senza transposizione alcuna.
Ma chi vorrà studiare? Quanti ancóra in Italia intendono il significato di un tal verbo? Quanti sentono la necessità di rinnovarsi? Quanti hanno fede nella loro forza e sicurezza nella loro sincerità?
Pure, non mai come oggi fu imperioso il dilemma: – O rinnovarsi o morire.
A voi, signora, a voi che ricercando il meglio date in Italia l’esempio di una operosità così virile, dedico dunque un documento publicato a indicare il primo sforzo istintivo di un artefice inquieto; il quale tanto è appassionato dell’Arte che non può rassegnarsi a morire.
Ave.
G. d’A.
Napoli: nell’Epifania del 1892.
![]()
Ego autem sum vermis, et non homo;
opprobrium hominum, et abjectio plebis.
Omnes videntes me, deriserunt me…
PSALM. XXI, 7, 8.
Judica me secundum justitiam tuam.
PSALM. XXXIV, 24.
Dunque, voi volete sapere… Che cosa volete sapere, signore? Che cosa vi debbo dire? Che Cosa? – Ah, tutto! – Bisognerà dunque che io vi racconti tutto, fin dal principio.
Tutto, fin dal principio! Come farò? Io non so più nulla; non mi ricordo più nulla, veramente. Come farò, signore? Come farò?
Oh Dio! Ecco… – Aspettate, vi prego, aspettate. Abbiate pazienza. Abbiate un poco di pazienza; perché io non so parlare. Se pure mi ricorderò di qualche cosa, non ve la saprò raccontare. Quando ero tra gli uomini, ero taciturno. Ero taciturno, anche dopo che avevo bevuto: sempre.
No, non sempre. Con lui, parlavo; soltanto con lui. Certe sere d’estate, fuori di porta, o nelle piazze, nei giardini publici… Metteva il suo braccio sotto il mio, quel povero braccio scarno, così esile che quasi non lo sentivo. E andavamo insieme, ragionando.
Undici anni – pensate, signore – aveva soli undici anni; e ragionava come un uomo, era triste come un uomo. Pareva che sapesse già tutta la vita, che soffrisse tutte le sofferenze. La sua bocca conosceva già le parole amare, quelle che fanno tanto male e che non si dimenticano!
Chi dimentica qualche cosa? Chi?
Io vi dicevo: non so più nulla, non mi ricordo più nulla… Oh, non è vero.
Mi ricordo di tutto, di tutto, di tutto. Capite? Mi ricordo delle sue parole, dei suoi gesti, dei suoi sguardi, delle sue lacrime, dei suoi sospiri, dei suoi gridi, d’ogni atto della sua esistenza, dall’ora che è nato all’ora che è morto.
È morto. Sono già sedici giorni che è morto. E io vivo ancóra! Ma io debbo morire; quanto più presto è possibile, io debbo morire. Il mio figliuolo vuole che io vada. Tutte le notti viene, si siede, mi guarda. È scalzo, povero Ciro! Bisogna che io stia con gli orecchi tesi per accorgermi del suo passo. Continuamente, da che si fa buio, sto in ascolto; continuamente. Quando mette il piede su la soglia, è come se lo mettesse sul mio cuore; ma piano piano, senza farmi male, oh, tanto leggero… Povera anima!
È scalzo, ora, tutte le notti. Ma, credetemi, mai mai nella sua vita, mai è andato scalzo. Ve lo giuro: mai.
Vi dirò una cosa. State bene attento. Se vi morisse una persona cara, fate che nella cassa non le manchi nulla. Vestitela voi, se potete, con le vostre mani. Vestitela tutta quanta, minutamente, come se dovesse rivivere, levarsi, uscire. Nulla deve mancare a chi se ne va dal mondo; nulla. Ricordatevene.
Ecco, guardate queste scarpette. – Avete figliuoli? – No. Ebbene, voi non potete sapere, voi non potete intendere che cosa sieno per me queste due scarpette logore che hanno contenuto i suoi piedi, che hanno conservata la forma dei suoi piedi. Io non saprò dirvelo mai, nessun padre ve lo saprà mai dire; nessuno.
In quel momento, quando entrarono nella stanza, quando vennero per portarmi via, tutti i suoi abiti non erano là, su la sedia, accanto al letto? Perché io non cercai altro che le scarpe, ansiosamente, sotto il letto, sentendomi scoppiare il cuore al pensiero di non trovarle; e le nascosi, come se dentro ci fosse rimasto un poco della sua vita? Ah, voi non potete intendere.
Certe mattine fredde, d’inverno, all’ora della scuola… Soffriva di geloni, povero bambino! D’inverno aveva i piedi tutti piagati, sanguinanti. Io gli mettevo le calze, io gli mettevo le scarpe. Sapevo fare tanto bene. Poi, nell’allacciare, chino a terra, sentivo che le sue mani appoggiate su le mie spalle tremavano già di freddo. E io mi indugiavo… Voi non potete intendere.
Allora, quando morì, era questo l’unico paio; questo che vedete. E io glielo tolsi. E, certo, egli fu seppellito così, come un poverello. Chi gli voleva bene, fuori che il padre?
Ora, tutte le sere, io prendo queste due scarpette e le poso l’una accanto all’altra, su la soglia, per lui. S’egli le vedesse, passando? Le vede forse, ma non le tocca. Sa forse che io diventerei ...