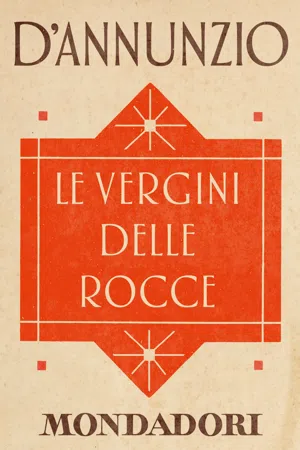Il romanzo-poema è genere diffuso presso la letteratura simbolistica francese degli anni ’90, incline a dissolvere le tradizionali categorie estetiche per far luogo, all’interno del racconto, alla dimensione lirica. L’avvio – afferma il Raimond de La crise du roman (Paris, Librarie J. Corti 1966) forte delle argomentazioni di Rémy de Gourmont e di Fernand Gregh – va assegnato al d’Annunzio del Piacere, dell’Innocente, del Trionfo della morte, con la prefazione ben nota. E se tale è il giudizio sul ciclo dei Romanzi della Rosa, si può, per estensione, comprendere l’unanimità di pareri espressi dalla critica d’oltr’alpe sul nuovo romanzo del ’95, quelle Vergini delle rocce che esasperano il processo di stilizzazione sino ai confini ultimi della prosa poetica. «Symphonic délicate» per il Tissot, diversissima dal carattere delle precedenti opere dannunziane, orchestrata nei modi di una «beauté plus musicale» (Les sept Plaies et les sept Beautés de l’Italie contemporaine, Paris, Perrin, 1900); collezione di «morceaux lyriques» per il Bovet di Lyrisme, épopée, drame (Paris, Colin, 1911); ma soprattutto evento testuale eccedente la tipologia tradizionale, secondo un De Vogüé particolarmente propenso ai distinguo: «Le Cycle du Lys nous révèle l’écrivain sous un nouvel aspect […] L’artiste s’adresse cette fois à un public plus restreint, curieux avant tout de rares jouissances esthétiques. Les Vierges des Rochers n’ont pas d’intrigue romanesque, les Romans du Lys ne sont pas des romans. C’est une grande douceur de penser que le plus avisé critique devra renoncer à cataloguer ces livres dans un genre défini» (Histoire et poésie, Paris, Colin, 1898). Non romanzo, ma reliquiario di silenzio, solitudine, passato; e ancora non romanzo ma contemplazione pittorica, «ballet spirituel»: occorrerà ritornare sulle indicazioni che l’autorevole partigiano della Renaissance latine allineava con singolare acume nella recensione precoce del dicembre 1895.
Più perplesso, o più intricato dei suoi critici, appare il d’Annunzio della preistoria testuale, se lo si sorprende all’altezza del 1893, in piena fase elaborativa del Trionfo della morte, incerto sulla direzione futura: «Lavoro anche a un altro romanzo (casto)» scrive a Emilio Treves il 21 febbraio «che sarà pubblicato nella Revue des Deux Mondes tradotto». Niente che possa autorizzare a ipotesi fondate, tanto più che la notizia sul romanzo casto (identificabile forse con quella Madonna di Pompei cui si accenna nella lettera del 29 giugno) si alterna con insistiti propositi circa una «Vita di Gesù» cui non è certo estranea certa moda «galilea» della fine secolo, affascinata in primo luogo dalla narrativa russa.
E ci si riferisce, è ovvio, a quel Loti che proprio il Tissot dell’intervista a d’Annunzio colloca in rilievo, con la sua Trilogia mistica, in particolare il Désert, la Galilée, interpretati dal d’Annunzio, sulla scia di costellazioni analogiche, come favolose «taches d’humidité» affini a quelle che i discepoli di Leonardo studiavano sui vecchi muri. Pura lievitazione d’immagini, dunque: e il discorso porterebbe lontano. Ma non ci si potrà impedire di pensare per un istante all’interesse per il Nazareno inserito poi nelle Vergini in antitesi alla figura socratica e filtrato attraverso Nietzsche; a un interesse già vivo nel 1893, anche se con connotati diversi, estetizzanti e non ideologici: «Nella Vita di Galileo c’è una meravigliosa materia d’arte. Come mai nessun artefice della parola ha pensato che si potrebbe, fuori d’ogni critica e d’ogni esegesi, scrivere una Vita di Gesù secondo la leggenda e la tradizione ma ornandola di tutte le bellezze d’uno stile possente? Io vorrei scrivere la vita del Cristo con lo stesso metodo con cui scrivo i miei romanzi […]» (lettera a Emilio Treves, 7 marzo 1893 da Resina).
Accanto alla tematica religiosa, componente certo non secondaria nell’economia del futuro romanzo-poema, si sviluppavano nei mesi successivi altre tendenze, unificate tuttavia in un segno comune, se si dà credito alla lettera all’editore del 25 maggio 1894: «Se il mio ministro delle finanze per economia mi impedirà di intraprendere il lungo viaggio desiderato [in Palestina] mi metterò subito a comporre un romanzo nuovo su uno dei quattro schemi che ho già pronti. Sceglierò, forse, uno schema di pura idealità. Dopo tante depravazioni e tanta violenza, voglio prendermi un bagno nell’acqua di virtù».
E siamo a Cor Cordium, primo di una trafila di titoli approntati tra la primavera e l’autunno del ’94. Ne sono interessate numerose lettere al Treves e al traduttore francese Hérelle, che elenchiamo nei loro passaggi essenziali: «Ieri preparai la carta pel nuovo romanzo e scrissi: Capitolo I. Il romanzo s’intitola probabilmente “Cor Cordium”. E sarà molto empoignant. Spero di averlo finito per ottobre. Sarà di mole mediana» (a Emilio Treves, s.d.). Notizia subito confermata il 6 giugno e poi il 3-6 agosto in due missive a Hérelle: «Qui è la grande estate. Ieri feci il mio primo bagno di mare. E ieri scrissi in cima a una pagina bianca: Capitolo I, per cominciare il nuovo romanzo che sarà intitolato forse Cor Cordium»; «[…] Noi potremo offrire al Ganderax, senz’altro, il romanzo futuro che, per ora, chiameremo Cor Cordium». Da Cor Cordium alle Tre principesse, per assecondare il desiderio dell’editore: «[…] mi obbligo a consegnarvi [il romanzo] entro il mese di novembre […] è intitolato, credo definitivamente, Le tre principesse. Ho abolito, per voi, il titolo latino. Il nuovo titolo mi sembra, nel tempo medesimo, poetico e attraente […]. Io in questo mese non ho lavorato moltissimo, per il caldo e per le distrazioni; ma avrò un settembre di meravigliosa energia […] E m’auguro di poter venire in ottobre a portarvi il manoscritto […]» (23 agosto 1894, a Emilio). Gli premeva la definizione del contratto («Vi prego ad ogni modo di farmi sapere qualche cosa intorno al nostro contratto per le Tre principesse, che è ancora sospeso» – lettera del 5 ottobre da Francavilla) per un romanzo che, nel frattempo, rivelava nei frenetici mutamenti di titolo «perplessità» e «inquietudini». Significative le lettere del novembre: «[…] Il romanzo che scrivo non è più intitolato Les trois princesses, ma La Trinité», confessa a Hérelle il 5, adducendo a pretesto il bisogno di differenziarsi da Maeterlinck, autore, si vedrà presto, davvero centrale nell’ideazione delle Vergini: comprensibile, dunque, lo scrupolo che la coincidenza non venga denunciata sin dal titolo (Les sept princesses erano già apparse a nome del prosatore belga, responsabile di un altro imbarazzante precedente: il romanzo l’Intruse). E poi di seguito la tonalità ludica («[…] Il titolo del romanzo che scrivo, è mutato ancora! La vierge sage, la vierge folle et la vierge morte. Ridete? […]» – lettera dell ’11) e quella riflessiva, che approda a una consapevole dichiarazione di poetica: «[…] Resta la ragione di questo romanzo a cui lavoro. Io dovrei tener per me segrete le mie perplessità d’artista e le mie ricerche inquiete, ma vi comunico volentieri tutti gli ondeggiamenti del mio pensiero […] Quando trovai il titolo La Trinità, pensavo al comun carattere sacro dei tre titoli in serie. Poi mi venne a mente il trabaccoIo del Martyr che si chiama appunto Trinité, e il titolo cadde in disgrazia, perché mi sembrò un nome di barca peschereccia. Il titolo che vi comunicai ieri non mi dispiacerebbe, appunto per quel miscuglio di raffinatezza e d’ingenuità, essendo nel tempo medesimo naïf et recherché. Ma dovrebbe essere scritto su un frontespizio di stile antico, in una edizione magnifica […] Perché voi comprendiate il sentimento che m’inspira, vi dirò che questo romanzo è tutto penetrato di poesia, è anzi un vero e proprio poema, rispondendo appunto alle origini poetiche del “roman”. Gli avvenimenti reali vi appaiono trasfigurati da significazioni alte e complesse. Le tre figure delle Vergini si muovono su un fondo di paesaggio che è in accordo con l’ardore e con la desolazione delle loro anime. Una catena di rocce acute si svolge sul loro orizzonte disegnandosi nel cielo, ora azzurre, ora bianche e raggianti, ora purpuree come fiamma, tra delicate e rosee come il più fine dei coralli. Pensate un poco alla Vierge aux rochers di Leonardo […] Ed ecco suggerito un titolo poetico e breve: Le Vergini delle Rocce, Les Vierges aux Rochers» – lettera del 12).
Il passo è fondamentale, e va pazientemente decodificato. Intanto l’accenno alle radici poetiche del romanzo andrà inteso proprio come radicale messa in discussione dei modelli narrativi preesistenti: il bisogno di modificare la forma della finzione diviene subito rifiuto della trama («[…] Ne s’agissait plus de raconter une histoire» chiosa il Raimond «mais de tout dire») in favore della libera invenzione di uno spazio e un tempo assoluti. Lo spazio del romance, ove nulla accade tranne «le souci du lieu, de l’heure, de la saison», ove lo sguardo accarezza i particolari enumerandoli, mentre i gesti si fissano e si concludono su di sé, e l’azione è rito di iniziazione, cerimonia magica: il luogo, si accennava, della stilizzazione. Ne daremo, tra poco, le coordinate, individuando possibili fonti: per ora importa sottolineare che l’idillio delle Vergini, probabile nucleo iniziale dell’opera, va gradualmente trasformandosi nell’intenzione dell’autore in poema proprio in forza di una urgenza, una tensione stilistica che tentano la via dell’elaborazione sperimentale. Si spiega allora l’insistenza di certe affermazioni, ribadite da d’Annunzio innanzitutto a se stesso: il poema, di lì a poco, è divenuto tragico, è anzi propriamente tragedia («[…] Il mio nuovo romanzo» scrive il 24 dicembre ad Hérelle «incomincerà col primo numero del Convito. Ma voi non riconoscerete l’opera quale io ve la rappresentai a Venezia. S’è profondamente trasformata, non tanto nella favola quanto nello spirito che dentro vi circola. Doveva essere quasi un idillio malinconico, ed è invece una tragedia in cui scoppiano le più fiere energie umane […]»). L’adeguazione stilistica al mutare della materia narrativa si rivela di fatto faticosa: di lettera in lettera le confessioni, gli sfoghi aumentano in frequenza e intensità, specie quando il disegno compositivo si allarga verso l’ideazione di una cornice ideologica, quel Proemio così difficilmente riconducibile in apparenza allo sviluppo diegetico. «Questa opera» – lo sfogo è rivolto ancora all’Hérelle – «[…] è faticosissima. In questi giorni ho dovuto rileggere e meditare quattro o cinque dialoghi di Platone, e il Convito di Xenophonte, per estrarne alcune idee che debbono servire di fondamento a un capitolo di sintesi morale». Il compito del traduttore diverrà improbo, stando ancora agli avvertimenti dannunziani: «Sono curiosissimo della sorpresa che vi farà la prima parte delle Vergini. Ah! mio povero amico, quale immane fatica sarà per voi la traduzione! Ho adoperato uno stile latino, a grandi periodi pieni zeppi di proposizioni incidentali, e bisognerà conservare alla traduzione questo carattere un po’ oratorio. Converrà rileggere qualcuno dei vostri classici più eloquenti» (10 gennaio 1895). Si delinea con sempre maggiore chiarezza la difficile fusione tra motivo contemplativo e motivo oratorio, l’ibrido connubio tra arte pura e impegno propagandistico: un puzzle di difficile soluzione, che invano la perentoria voce dell...