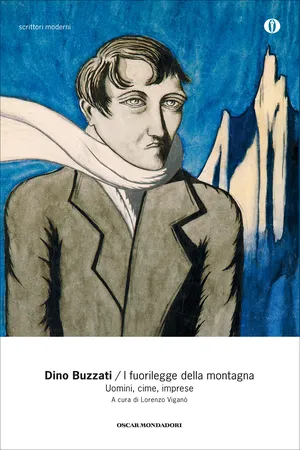![]()
... per chi guarda dal fondo delle valli, che colore risulta? È bianco? giallo? grigio? madreperla? È color cenere? È riflesso d’argento? È il pallore dei morti? È l’incarnato delle rose? Sono pietre o sono nuvole? Sono vere oppure è un sogno?
Ma le Dolomiti cosa sono?
![]()
In certe giornate limpidissime di autunno, perfino dai tetti più alti di Venezia si possono distinguere, anche senza bisogno di binocolo, le Dolomiti. Non solo il loro confuso profilo di montagne, misteriosa barriera che chiude il Nord (e al di là che cosa esiste? quali mondi si stenderanno di là della muraglia?). Ma se ne riconosce anche il colore. Dalle 11 del mattino a pomeriggio inoltrato una piccola macchia lucente risplende infatti all’orizzonte. È la faccia sud dello Schiara, una delle poche grandi pareti dolomitiche che guardano direttamente la pianura.
Di che colore? Si può trovare un aggettivo esatto per definire quella tinta così diversa da tutte le altre montagne, che al sottoscritto, ogni volta che ci fa ritorno e la rivede, provoca un trasalimento interno, risollevando ricordi struggenti? No, un aggettivo preciso non esiste. Più che di un colore preciso, si tratta di una essenza, forse di una materia evanescente che dall’alba al tramonto assume i più strani riflessi, grigi, argentei, rosa, gialli, purpurei, viola, azzurri, seppia, eppure è sempre la stessa, così come una faccia umana non cambia anche se la pelle è pallida o bruciata.
A dimostrare quanto è inafferrabile il colore delle Dolomiti sta un singolare fenomeno: che noi si sappia, esse rappresentano l’unico spettacolo della Natura col quale i pittori, per quanto bravi, non ce l’hanno mai spuntata. Fare nomi sarebbe perfino ingeneroso. Perché quando un artista è riuscito a fissare sulla tela la luce vera che in una cert’ora mandava la montagna – qualche rara volta è accaduto – andava perso tuttavia tutto il resto: la struttura, i lineamenti, la somiglianza insomma; e il risultato si riduceva a un appunto coloristico, a un abbozzo insufficiente. E quando invece – come l’inglese Compton, uno dei pochi – l’artista riusciva invece a «prendere» la somiglianza, a definire cioè la forma in modo persuasivo, il colore gli sfuggiva.
Avvicinatevi, vi prego, esaminate attentamente questo spettacolo che per noi Italiani è diventato di ordinaria amministrazione, e non ci facciamo più caso, eppure senza ombra di dubbio è una delle cose più belle, potenti e straordinarie di cui questo pianeta disponga. Soltanto per vederlo di sfuggita meriterebbe di venire apposta dall’Australia. E quando ci mostrano in fotografie a colori o in cinerama le rupi dello Zion o del Yosemite Park, in America, celebrate in tutto il mondo, a noi, scusate, viene semplicemente da ridere.
Risaliamo, se non vi dispiace, la valle del Piave che, a parte le Dolomiti, è una valle affascinante, piena di incanti veneziani e, in alto, una atmosfera di romanticismo rimasta intatta dai secoli andati. Le propaggini del Grappa, i colli Euganei, poi ben presto si innalzano altri rilievi più massicci. La stretta di Fener. Sono vere montagne ormai, anche se verdi. Qua e là si notano dirupi, brevi pareti a picco. Ma niente di speciale; salti di roccia come se ne vedono in tutte le Prealpi.
Soltanto dopo Feltre, all’improvviso, verso sinistra, la prima Dolomite. È il Sass da Mur, ben pochi la conoscono. Ansiosi dei picchi più famosi, i viaggiatori passano oltre, senza neppure rallentare. Eppure è una Dolomite già perfetta, con tutti i segni della grande razza, gli apicchi rosa e gialli, le cenge orizzontali spolverate di bianco, i coni di ghiaia, la nudità, le rotte creste. Guardatela un momento, fissatevi bene in mente quella tinta, la ritroverete tale e quale nell’empireo.
Scompare il Sass da Mur, nascosto da una quinta della valle. Ecco, sempre a sinistra, un’altra rupe: la parete ovest del Pizzocco, picco ambiguo il quale dopo poco, quando ci si gira intorno, perde ogni prestanza dolomitica. Ormai, da Feltre a Belluno, è un accavallarsi ininterrotto di sagome precipitose e strane. Monti a piramide e a focaccia frammezzati da strapiombi, pascoli miti, tenebrosi precipizi. Ma, Dolomiti, niente.
La seconda vera grande Dolomite, con i colori e l’architettura in regola, è lo Schiara, sopra Belluno. Egli porta a sinistra, sulla spalla, un gingillo graziosissimo, un monolite di quaranta metri, che si chiama Gusella del Vescovà, ago del vescovo cioè.
Ma in Cadore non siamo ancora entrati. Queste sono le mura del perimetro. La porta d’ingresso si apre, stretta e cupa, poco più sopra di Belluno; chiusa da monti che di Dolomiti hanno ben poco, benché selvaggi: con l’erba che li ricopre fino in cima ma ripidi, di bizzarre forme, con lastronate oblique, spacchi, protuberanze dirupate, becchi, corni. A difesa del regno stanno i gregari d’altre razze, con faccia selvatica e camusa, scontrosi, arcigni, dai muscoli tozzi e pesanti. I cavalieri, i nobili, i principi, i sovrani stanno dietro, invisibili ancora. Fra poco li vedrete.
Fra poco lo spettacolo comincia. Dalla strada infossata sulla quale incombono sempre più tetri e inospitali i fianchi di questi monti (che pure hanno un loro nome e una cima aperta ai venti, e forse sono abitati dagli spiriti e sanno forse meravigliose storie di spettri, di briganti e di eremiti, ma che nessuno ama), gli sguardi tendono continuamente in su, cercando il principio della grande saga dei cosidetti monti pallidi. Ma non si vedono che sinistri valloni, barbacani ricoperti di cespugli, scoscendimenti disperati, forre, cucuzzoli, gibbosità dalla fisionomia proterva.
Il sipario si apre dopo Perarolo, quando si è superata la salita della Cavallera, la strada sbocca dall’umido antro della valle e la natura improvvisamente cambia, con scenari di prati, abeti e larici: Cadore!
Allora, nel giro di pochi chilometri, le Dolomiti esplodono veramente tutto intorno biancheggiando sopra i dossi verdi e, se risplende il sole, vi appaiono come una immagine di felicità piena e solenne.
Sono ormai tante, che si stenta a rendersene conto. Il Duranno solitario, la bastionata fantastica di Vedorcia e di Toro, in fondo il Ciastellin, a sinistra i giganti delle grandi famiglie nobiliari, con schierate le Marmarole in prima fila («Care al Vecellio»? E perché? Un’espressione fortunata senza dubbio che ci terrà compagnia tutta la vita. Ma ai tempi di Tiziano le montagne, Dolomiti comprese, non interessavano, non esistevano neanche si può dire, erano soltanto delle immense cose incomode e complessivamente ostili. Sono stati i romantici a scoprirle. Del fatto, assolutamente certo, che Tiziano non le avesse capite e non se ne curasse, è prova la completa assenza delle Dolomiti nei suoi quadri. E sostenere, come molti fanno, che son le Marmarole le rupi di maniera sullo sfondo della Presentazione al tempio, significa non saper che cosa siano le Dolomiti e soprattutto dubitare del Maestro; delle vere Marmarole, quelle generiche montagne non hanno assolutamente né la forma, né il colore, né lo spirito cioè la cosa che soprattutto importa).
Non c’è qui spazio per poter fare le presentazioni in piena regola. Dopo le Marmarole, viene Sua Maestà l’Antelao, scortato dalla Torre dei Sabbioni, la Cima Scotter, la Croda Marcora, mentre a sinistra, dopo le propaggini del Bosconero, comincia a giganteggiare il Pelmo, seduto sul trono come un dio. Lo spettacolo ha questo di drammatico: che la tensione, per così dire, è progressiva. Le Dolomiti esterne infatti, le prime che si incontrano, per quanto splendide, non hanno la terribilità e la potenza di quelle che ci aspettano più in su. Lo stesso Antelao, che pure è la cima più alta del Cadore, lo stesso Pelmo che è fra i massimi colossi, hanno poco di inquietante e minaccioso. Ma già il successivo apicco della Croda Marcora che al mattino fiammeggia formidabile, sospeso sopra Borca, ha già un volto differente, dalle pieghe sinistre e dure. Nella maestà della fanfara trionfale cominciano a mescolarsi dei rintocchi profondi e cupi, e questo motivo impressionante a poco a poco salirà di tono, di cima in cima, fino a tuonare con implacabile potenza fra le muraglie a strapiombo delle Cime di Lavaredo o sotto le ciclopiche colonne della Tofana di Rozes, o fra le sghembe vertigini, intarsiate di ghiaccio, della Croda dei Toni.
Ci siamo, dunque. Da Calalzo a Cortina, da Cortina a Misurina, per esempio, poi ancora più su, sempre con l’auto, fino al piedestallo dei picchi celebri il cui ritratto in cartolina è diventato banale addirittura come la Torre di Pisa o il Ponte di Rialto. Eccoci, per esempio, ai piedi delle Cime di Lavaredo, al rifugio Caldart, dove si arriva in macchina. Di qui, una passeggiata, niente di più, fino alla forcella Lavaredo. Poca fatica. E allora si spalancano le prospettive di un santuario allucinante. Le parole diventan poverelle di fronte alla spaventosa rigidità di quelle mura immense, bieche e solitarie.
Ma fin qui si è visto solo quello che le fotografie turistiche riproducono in migliaia di esemplari. Per capirle, le Dolomiti, veramente, occorre un po’ di più. E non vogliamo dire arrampicate in piena regola. Bastano i sentieri. Entrare, avventurarsi un poco fra le crode, toccarle, ascoltarne i silenzi, sentirne la misteriosa vita.
Se ci si trova dentro a una parete – e non occorre che sia di sesto grado, ce ne sono di quelle attraversate da comode cenge su cui corrono sentieri sicurissimi – si comincia a decifrarle, queste rupi, a distinguerne la personalità e le voci. Da lontano sembravano lisci e compatti fortilizi tutti d’un pezzo. Ora non si riconoscono più, hanno perso la forma, si sono frantumati in un intrico di guglie, di spaccature, di massi pencolanti, di segreti recessi pieni di intimità, di architravi che vacillano, di allarmanti baldacchini, di diruti altari, di precipitosi botri, di pilastri dall’equilibrio inverosimile.
Adesso si cominciano a intravedere gli ingredienti di cui è composto l’indescrivibile colore. Sono le ghiaie bianche, sparse sui ballatoi, sui terrazzini, sulle minime sporgenze. Battute dal sole, esse risplendono, e riverberano intorno una diffusa luce. Proprio a queste ghiaie candide è dovuto in gran parte la magnificenza delle rupi, la loro serenità sontuosa; tanto è vero che d’inverno, quando la neve le ricopre, i picchi risultano alquanto immiseriti.
Poi ci sono i colori delle rocce. Quelle grigio-chiare dove le pareti sono rotte. Quelle bianche, levigate dai ghiacci dei millenni. Quelle nere e viscide, coperte dai licheni, nelle tenebrose fenditure. Le grigio-scuro, pulite, solidissime, perfette, butterate qua e là da piccoli buchi tondi come orbite, senza neppure un sassolino negli interstizi tanto rigorosa è la verticalità della struttura (delizia massima degli arrampicatori). Le rocce gialle, per lo più malferme e perfide, risparmiate dalla pioggia perché piegate in fuori a strapiombo o riparate da soverchianti tetti; sinistro colore giallo che per i rocciatori è sinonimo di passaggio maledetto. Ci sono poi le rocce rosse, ancora peggio, ancora più marcie e impraticabili. E infine i mille straordinari abbellimenti: minuscole caverne, nidi di gnomi forse, scavate negli apicchi; lugubri strisce di antichi stillicidi; cicatrici, di un candore quasi osceno, lasciate da qualche notturno crollo; pulpiti da predicatore sospesi sulle voragini, fessure che come enigmatiche iscrizioni tagliano in diagonale le pareti; macigni da ciclope in bilico che sporgono proiettando nell’abisso lunghe ombre; occhiaie nere che trasformano i pinnacoli in devastati teschi; facce di cane, monaci incappucciati, scontrose vergini, guerrieri del Duecento, preti, ceree statue che sulle creste confabulano, vitrei fantasmi di calcare erosi dal vento, che si sporgono in fuori e guardano, guardano fissamente.
E da tutto questo, per chi guarda dal fondo delle valli, che colore risulta? È bianco? giallo? grigio? madreperla? È color cenere? È riflesso d’argento? È il pallore dei morti? È l’incarnato delle rose? Sono pietre o sono nuvole? Sono vere oppure è un sogno?
Introduzione a AA.VV., Olimpiade nelle Dolomiti, Aliroma, Milano 1956
![]()
Esco dalla casa, attraverso il prato che c’è davanti, e mi volto. Tutte le estati, quando torno alla nostra casa di campagna qui a due passi da Belluno, al mattino esco, attraverso il prato che c’è davanti alla casa e quando sono arrivato in fondo, mi volto. Allora vedo lo Schiara.
È una bella giornata, il cielo è quasi completamente sereno, so benissimo che più tardi le nuvole verranno ma per adesso non ce ne sono, del resto anche se è una giornata coperta è difficile che lo Schiara sia nascosto dalle nubi e questa è una cosa che una volta mi dispiaceva come se fosse il segno che lo Schiara non era una grande montagna, infatti le vere grandi montagne basta che ci sia in ballo una vaga idea di cattivo tempo perché si coprano tutte di una massa di schifosissime nubi e allora non si vede più niente. E io scrivo lo Schiara anziché la Schiara, mi dispiace se è sbagliato, Piero Rossi l’altro giorno mi ha dimostrato che il nome è femminile, ma per tutta la vita ho continuato a dire lo Schiara e adesso è troppo tardi per cambiare.
Quando ero ragazzo lo Schiara mi faceva una specie di tenerezza, perfino di pena, proprio perché avrei voluto essere ancora più orgoglioso di lui e il mondo non me lo permetteva.
Ci tenevo moltissimo che lo Schiara fosse un’autentica dolomite, il fatto che il posto dove ero nato si trovasse ai piedi di una autentica dolomite mi pareva che dovesse valorizzarlo enormemente in tutti i sensi, ma il mondo in certe cose è cretino e non c’è verso di distaccarlo dai luoghi comuni. Per la gente, dolomiti vuol dire Cortina d’Ampezzo, Val Gardena, Madonna di Campiglio e basta così. È già tanto se i competenti ammettono che anche in Val Pusteria, in Cadore, nell’Agordino esistono delle vere dolomiti. Figurarsi a Belluno. Se dite Belluno subito la gente dice Frìuli con l’accento sbagliato sull’i, di Belluno in genere non sanno niente di niente, è inutile farsi illusioni, le cose sono un po’ cambiate dopo il disastro del Vaiont però mica tanto.
Ora nessuno o quasi sa che su Belluno incombe una dolomite autentica con un accidenti di parete di buoni ottocento metri. Quelli che vanno su a Cortina di solito passano per Belluno con una furia tale, manco si fermano a prendere un caffè, manco levano per un istante gli occhi a guardare lo Schiara con la sua immortale Gusella, lo Schiara e la Gusella non sono catalogati fra le dolomiti di repertorio mondano, e anche se lo vedono immaginarsi se quelli si accorgono che lo Schiara è una dolomite con tutte le carte in regola né più né meno che le Cime di Lavaredo e il Sasso Lungo.
Mi ricordo che da bambino, avrò avuto cinque o sei anni, cercai di disegnare le montagne che si vedono dalla nostra casa a due passi da Belluno. E tutte le altre montagne riuscirono nel disegno delle gobbe più o meno tonde o accentuate, al posto dello Schiara invece risultò un mazzo di punte acuminatissime, una pazzesca selva di guglie inverosimili che allo Schiara non assomigliavano per nulla. Questo per dire che nella mia fantasia infantile lo Schiara incarnava già la personalità delle grandi dolomiti terribili, castelli inaccessibili e selvaggi. In seguito, pensando a questo disegno, mi resi conto perché gli antichi quadri e stampe davano, delle montagne, ritratti assurdi e senza alcuna somiglianza. Gli antichi, per i quali le montagne non avevano il minimo interesse, non sapevano «vederle», non le capivano, di fronte alle montagne si trovavano esattamente com’ero io all’età di cinque sei anni.
In seguito, naturalmente, l’idea di salire alla cima dello Schiara divenne una meravigliosa fissazione. E un bel giorno si partì, mio fratello Augusto, l’amico Emilio Zacchi, io, e un cacciatore bellunese di nome Nane Min, che ci doveva fare da guida. Senonché, per chi seguiva la via normale su per la Val Vescovà, lo Schiara non si presentava più come il superbo tipo che si vede da Belluno, bensì come un bestione accovacciato, grasso, floscio e stanco. D’accordo: dalla cima si vedeva laggiù in fondo Belluno con intorno tutto il resto e io pensavo che in quel momento giù a Belluno qualcuno forse alzava gli occhi da quella parte e si diceva perdio che bella montagna arrivarci in cima deve essere maledettamente difficile e sulla cima proprio in quel momento ci stavamo noi in carne ed ossa e questa era una bella soddisfazione. Ma lo Schiara che avevo salito non era lo Schiara che avevo amato e sognato fin da bambino piccolo, per me salire lo Schiara voleva dire una cosa immensa cioè arrampicarsi su per la grande parete che si vede da Belluno e tutto il resto erano balle.
Poi venne anche il giorno della parete. Prima un tentativo con l’amico Emilio Zacchi, cugino del primo salitore Luigi Zacchi, magnifico ufficiale degli alpini detto, chissà perché, «Cornacchia». Tentativo interrotto dalla pioggia quando già si era in groppa al costolone erboso che tutti sanno. Con una calata a corda doppia nella nebbia appesi a un chiodo che si muoveva da una parte e dall’altra solo a soffiarci sopra. Poi la scalata intera con perfino una nuova variante sulla cengia alta, in cordata con Silvio Sperti, fratello di Gianangelo, straordinario e geniale ragazzo che se n’andò per sempre qualche anno dopo. Quel giorno fui abbastanza felice. Ma, come succede spesso nelle dolomiti, la montagna, quando ci si è dentro, diventa irriconoscibile, completamente diversa da come appare dalla valle, tutta rotta, complicata, crollante, con erbe qua e là, macerie, frantumi, perfino brutta al paragone delle stupende muraglie liscie, compatte e pulite che si vedono dalla valle. Insomma non era proprio lo Schiara che mi immaginavo di trovare. Comunque, come potrei negare che lo Schiara in fondo è la montagna della vita mia? Forse avrei preferito che la montagna della vita mia fosse stata più ragguardevole e famosa, per esempio uno dei giganti della terra, che so io, la Civetta, le Grandes Jorasses, il Gaurisangar ...