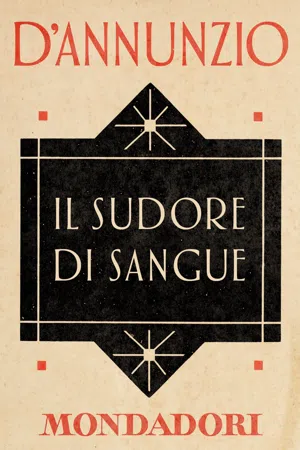![]()
1863-1873
Gabriele d’Annunzio nasce a Pescara venerdì 12 marzo 1863 da Francesco Paolo (il cui vero cognome, Rapagnetta, viene sostituito da quello dello zio adottivo, Antonio d’Annunzio) e da Luisa de Benedictis, discendente da un’agiata famiglia di Ortona. Gabriele è il terzogenito di cinque fratelli: Anna (1859), Elvira (1861), Ernestina (1865) e Antonio (1867). Il padre, esperto enologo, amministra le proprietà e sarà anche sindaco di Pescara.
Frutto di fantasia sono le notizie che d’Annunzio invia al traduttore francese Hérelle in data 14 novembre 1892: sarebbe nato a bordo del brigantino Irene, nelle acque dell’Adriatico, anche se poi la «passione profonda» per il mare, eletto subito a «patria», accompagnerà costantemente il suo percorso umano e artistico.
L’infanzia di Gabriele trascorre tra Pescara e la Villa del Fuoco, podere avito alla periferia della città, di cui si ricorderà il narratore dell’Innocente e del Trionfo della Morte. Primi precettori sono le sorelle Ermenegilda e Adele Del Gado, menzionate nella novella La contessa d’Amalfi (pubblicata sul «Fanfulla della Domenica» nel luglio 1885 e inserita nelle Novelle della Pescara) e nel Libro delle vergini (stampato nel 1884: alle sorelle si ispirano i personaggi di Camilla e Giuliana della novella Le vergini, divenute poi, nelle Novelle della Pescara, Orsola e Camilla de La vergine Orsola). Gabriele prosegue gli studi col maestro Eliseo Morico e con Giovanni Sisti, che lo segue sino agli esami di ammissione al Reale Collegio Cicognini di Prato.
1874-1878
All’inizio dell’anno scolastico 1874-75 viene iscritto alla prima classe ginnasiale del collegio pratese. Studente brillante e indisciplinato, il giovane Gabriele condivide con alcuni compagni un’intensa infatuazione per Napoleone (descritta nelle pagine delle Faville, come tutti i ricordi autobiografici della vita di collegiale, nelle sezioni intitolate Il secondo amante di Lucrezia Buti e Il compagno dagli occhi senza cigli). Legge i classici, comprese le edizioni non purgate, specie quelle dei testi «oraziani e nasoniani», e annota su numerosi quaderni elenchi di nomi (sotto la suggestione di un articolo di De Amicis sulla Lettura del vocabolario) e citazioni da Leopardi, Guerrazzi, Cicerone, Lambruschini, Augusto Conti, Seneca, Plauto, Orazio, Giordani, d’Azeglio, Balbo, Gioberti, Manzoni, Tommaseo. Comincia intanto a coltivare il culto di sé («più uomo di tutti i suoi compagni» lo descrive uno degli insegnanti «e dedito tutto a farsi un grande nome»). Rivelatrice in proposito una lettera al padre del 25 aprile 1878: «Vedi, padre mio, questa è l’unica vera dolcezza, l’unico vero conforto che io m’abbia dalle mie fatiche […] mi piace la lode, perché so che voi gioirete delle lodi a me date; mi piace la gloria, perché so che voi esulterete a sentire il mio nome glorioso: mi piace la vita, perché so ch’essa deve essere di sostegno e di consolazione alla vostra».
Trascorre le estati del 1875, ’76 e ’77 in collegio, nella villa della Sacca, a pochi chilometri da Prato, o a Firenze, ospite della famiglia Coccolini (la figlia del colonnello, Clemenza, è ricordata nelle Faville come Clematide e Malinconia). Ritornato a Pescara nell’estate del ’78 e conseguita la licenza ginnasiale a Chieti, nel novembre, durante il viaggio di ritorno al Cicognini per gli studi liceali fa una breve sosta col padre a Bologna, dove acquista, con altri volumi, le Odi Barbare del Carducci con prefazione del Chiarini, che producono su di lui profonda impressione (lo testimoniano la lettera al Carducci del 6 marzo 1879 e soprattutto quella al Chiarini del febbraio 1880, in cui si legge: «Il Carducci lo conoscevo poco […]. In quei giorni divorai ogni cosa con una eccitazione strana e febbrile, e mi sentii un altro. L’odio pe’ versi scomparve come per incanto, e vi subentrò la smania della poesia»).
1879-1880
L’esordio poetico, dopo le prime esercitazioni scolastiche, è sollecitato proprio dalle barbare carducciane. Nel 1879 pubblica, a spese del padre, i primi versi: l’ode All’Augusto Sovrano d’Italia Umberto I di Savoia, in occasione del genetliaco del re, non inserita nell’Opera Omnia, e il volume Primo vere, stampato dalla tipografia Ricci di Chieti e favorevolmente recensito dal Chiarini sul «Fanfulla della Domenica» del 2 maggio 1880, in un articolo intitolato A proposito di un nuovo poeta («Il mio nuovo poeta è un giovinetto di sedici anni […] egli deve aver sentito dentro di sé quel desiderio ardentissimo, quella smania violenta, che sono prova quasi certa d’esser chiamato alla poesia […]. Spesso e volentieri egli prende l’intonazione dal Carducci, va per un poco sulle sue orme, poi piglia l’andare da sé, e trova delle immagini felici, degli accenti veri, delle espressioni giuste, de’ suoni armoniosi»). Sull’onda di questo primo successo, Floro Bruzio (Floro era già pseudonimo dell’autore di Primo vere) pubblica le ventuno liriche di In memoriam, stampate nel maggio 1880 dal tipografo Niccolai di Pistoia, sempre a spese del padre. Il volumetto, ispirato dalla nonna Rita Lolli, morta da poco, non ha buona accoglienza, neppure da parte del Chiarini, che lo recensisce il 24 ottobre sul «Fanfulla» stroncandolo (il libro non sarà inserito nell’Opera Omnia). La seconda edizione di Primo vere, «corretta a penna e fuoco» e stampata il 14 novembre dall’editore Carabba di Lanciano, finanziatore ancora una volta Francesco Paolo, è preceduta da una sconcertante trovata pubblicitaria, quanto mai rivelatrice dell’ansia di notorietà del giovane poeta: egli divulga la notizia della propria morte, causata da una ferale caduta da cavallo. Dopo le commosse necrologie (famosa quella di Ugo Fleres – Uriel – sul «Capitan Fracassa» del 22 novembre) giungerà la smentita che però nulla toglie alla glorificazione funebre. Durante le vacanze estive, trascorse in Abruzzo, conosce il pittore Francesco Paolo Michetti. Già celebre, lo introduce nel cenacolo di artisti che si riuniscono nella sua casa di Francavilla. Rientrato in collegio, il 12 dicembre inizia la collaborazione al «Fanfulla della Domenica» (sollecitata, presso il direttore Ferdinando Martini, dall’amico Guido Biagi) con la pubblicazione del racconto Cincinnato, «figurina abruzzese» in prosa; al periodico il giovane collegiale continua a collaborare negli ultimi mesi di permanenza al Cicognini.
1881
Durante il terzo anno di liceo nasce il primo vero amore di d’Annunzio (dopo le varie esperienze adolescenziali con Teodolinda Pomàrici, Clemenza Coccolini, Emilia Corsani – la Gorella Gheri delle Faville –, Sblendore, la Ciccarina – ricordata nelle Novelle della Pescara, La guerra del Ponte e La contessa d’Amalfi): quello per la fiorentina Giselda Zucconi, figlia di Tito, professore di lingue straniere al Cicognini. La incontra a Firenze il 15 aprile 1881 e inizia con lei una fitta corrispondenza epistolare. Ne fa l’ispiratrice (Lalla) del futuro Canto novo, che si apre, nell’edizione 1882, con un sonetto di dedica «Ad E. Z.» (Elda, per Giselda) datato «15 aprile ’82», anniversario, appunto, del primo incontro.
Conseguita la licenza liceale il 30 giugno, il giorno seguente lascia il collegio e torna a Pescara, dopo un breve soggiorno a Firenze con Elda e una sosta a Bologna dove tenta contatti editoriali, falliti, con Zanichelli per la pubblicazione di Terra vergine e Canto novo. Trascorre l’estate a Francavilla, ospite del suo nuovo «amoroso amico», Michetti, con il musicista Francesco Paolo Tosti, lo scultore Costantino Barbella e il poeta Paolo De Cecco. Continua intanto a collaborare a vari periodici (fra i quali «Preludio», «Cultura letteraria», «Fanfulla della Domenica», «Arte», «Farfalla») con prose poi riprodotte in Terra vergine e liriche accolte solo parzialmente in Canto novo.
In novembre si trasferisce a Roma, in una modesta abitazione all’ultimo piano di via Borgogna 12, e si iscrive alla Facoltà di Lettere col progetto, mai realizzato, di laurearsi col romanista Ernesto Monaci. Alle aule universitarie preferisce le redazioni dei giornali: grazie all’amico abruzzese Edoardo Scarfoglio, di stanza, come lui, nella capitale, comincia a collaborare con il «Capitan Fracassa» e la «Cronaca Bizantina», fondata da Angelo Sommaruga il 15 giugno 1881, insieme a firme prestigiose: la Serao, Carducci, Martini, Pascarella, Giacosa, Fleres (d’Annunzio vi compare la prima volta il 30 novembre, con un’Elegia compresa poi in Canto novo). Tra i primi amici annovera, oltre a Scarfoglio, Enrico Nencioni, Cesare Pascarella, Ugo Fleres, Albino Zenatti, Salomone Morpurgo.
1882
Il 16 gennaio inizia l’attività di giornalista con un articolo, Fiera a Santa Susanna (recensione a una mostra di bozzetti per le statue dell’Altare della Patria), pubblicato sul «Fanfulla». Mentre insieme con Scarfoglio e Pascarella è in Sardegna (le cronache del viaggio si leggeranno nel «Capitan Fracassa»), il 5 maggio esce da Sommaruga Canto novo, in metri barbari, che già Carducci aveva apprezzato quando il volume era ancora in bozze di stampa. A breve distanza, sempre Sommaruga pubblica Terra vergine, il primo libro di prose, contenente nove bozzetti di ambiente abruzzese che parvero quasi una diretta emanazione della Vita dei campi di Verga. Ma l’Abruzzo di d’Annunzio indulge a una ferinità estetizzante ed è, a un tempo, più selvaggio e sanguigno, nell’eccesso di cromatismo, della Sicilia del Verga. Iniziano intanto le frequentazioni mondane, di cui si rinviene l’eco nelle lettere al padre (11 aprile: «Ho passato questi giorni in un’agitazione continua, in mille inquietudini, in mille irrequietezze, senza trovare un atomo di volontà, senza sapere quel che avessi. Sono malato di spirito, sono malato di anima») e ad alcuni amici (Paolo de Cecco, tra gli altri, a cui confessa, il 30 aprile, di non riuscire a liberarsi «dalle febbri torpide della sensualità»).
Si allenta così l’interesse per Elda, con cui mantiene ancora, tuttavia, un appassionato scambio di lettere. Sulla «Cronaca Bizantina» (1° luglio) e sul «Fanfulla della Domenica» (6 agosto) pubblica liriche erotiche ed estetizzanti che verranno poi accolte nell’Intermezzo di rime. Al ritorno dalle vacanze estive in Abruzzo, il giovane d’Annunzio è ormai pronto a riscuotere, nella capitale, affermazioni mondane e letterarie.
1883-1884
Il 23 gennaio 1883 tronca la corrispondenza con Elda inviandole l’ultima lettera: «Addio, mia buona, mia santa, mia bella bambina pallida e sofferente. Addio, addio, addio. Sono stanco e convulso». Quando è fresco di stampa l’Intermezzo di rime, edito da Sommaruga (il libro vede l’abbandono delle «barbariche strofe» e dà luogo a un’accesa polemica sull’inverecondia del contenuto, alla quale prendono parte Chiarini, Nencioni, Panzacchi e Lodi), sposa, il 28 luglio, la duchessina Maria Hardouin di Gallese, incinta. Dopo innumerevoli peripezie, compresa una fuga notturna, per l’opposizione del duca padre proprietario di palazzo Altemps, i cui salotti gli erano stati aperti nella primavera del 1883, il viaggio di nozze ha quale meta Porto San Giorgio e in Abruzzo, nella Villa del Fuoco, la coppia si stabilisce in attesa della nascita del figlio: Mario vede infatti la luce il 14 gennaio 1884.
Nel giugno esce da Sommaruga Il libro delle vergini, con una copertina raffigurante tre nudi di donna che suscita le proteste dell’autore e lo induce a rompere definitivamente i rapporti con l’editore. (Il volume non è compreso nell’Edizione Nazionale; di esso solo la novella Le vergini viene accolta nelle Novelle della Pescara mentre Nell’assenza di Lanciotto è ristampata nel ’92 presso il Bideri di Napoli in edizione economica.) Intensifica l’attività giornalistica sul «Fanfulla della Domenica» e sul «Capitan Fracassa» con cronache mondane, commenti a fatti di costume, resoconti di esposizioni d’arte che preludono all’intensa attività di articolista de «La Tribuna», iniziata, dopo il rientro a Roma della giovane coppia, il 1° dicembre 1884 con una pagina dal titolo Toung-Hoa-Lou. Ossia Cronica del Fiore dell’Oriente, firmata Shiun-Sui-Katsu-Kava, per la rubrica Giornate romane. Sino all’agosto 1888, cronista stipendiato presso il giornale romano, d’Annunzio redigerà con diversi pseudonimi – Il Duca Minimo, Lila Biscuit, Vere de Vere, Happemousche, Bull-Calf, Filippo La Selvi, Puck, Michings Mallecho e altri – varie rubriche: La vita a Roma, La vita ovunque, Favole mondane, Cronaca bizantina, Cronaca mondana, Grotteschi e rabeschi. Alle notizie sulla moda e sugli avvenimenti mondani si alternano acute informazioni sulle novità musicali, artistiche, letterarie. Parla, tra gli altri, e con competenza, di Baudelaire e Mallarmé, diffondendosi sulla lirica inglese da Keats a Swinburne, sui preraffaelliti e i parnassiani, su Zola e Maupassant, o Flaubert, cui già il corrispondente di Elda aveva dedicato, il 23 aprile 1882, apprezzamenti entusiastici: «un libro magico d’arte e di stile, Madame Bovary». Sullo scorcio del 1884 il poeta ha una breve ma intensa relazione con la giornalista Olga Ossani (la Febea del «Capitan Fracassa») che concorrerà a fornire il modello per il personaggio di Elena Muti nel Piacere.
1885-1886
La moglie è in attesa del secondogenito (Gabriellino nascerà il 10 maggio 1886) e d’Annunzio medita, dopo la vacanza estiva trascorsa in Abruzzo (ha sfidato in duello, il 30 settembre, presso la stazione di Chieti, un certo Carlo Magnico, da cui si ritiene diffamato), di allontanarsi dalla città per stabilirsi nei luoghi natali. Ma in autunno gli viene offerta l’opportunità di dirigere la prestigiosa «Cronaca Bizantina», impresa che tuttavia lo distoglie dal lavoro creativo. Scontento dell’attività giornalistica, che definisce «miserabile fatica quotidiana», sempre più «bisognoso del superfluo» e quindi oltremodo indebitato, si sente ormai «vinto» dalla capitale. «Ho molte cose a cui attendere» scrive il 6 aprile 1886 al principe Maffeo Sciarra, proprietario de «La Tribuna», «ho molte opere da condurre a termine, ho una gran voglia di mettermi a lavorare sul serio intorno a un lavoro lungo e d’importanza per me capitale. […] Roma mi ha vinto.» I lettori scarseggiano e la «Cronaca Bizantina» chiude i battenti. Otterrà aiuti finanziari, ma permane l’inquietudine letteraria, iniziata già all’indomani di Canto novo e protrattasi in questi anni tra incessanti prove sperimentali, sia in versi che in prosa, compiute su sollecitazione dei più importanti testi del decadentismo europeo subito letti e assimilati. Oltre agli articoli, che compone quotidianamente, scrive liriche (molte di quelle apparse, a partire dal 1883, in rivista confluiranno nell’Isaotta Guttadàuro del 1886 e poi nell’Isottèo-La Chimera del ’90), tenta la via del romanzo (il 6 settembre 1884 aveva scritto al Nencioni: «incomincerò subito un romanzo di cui ho già tutto l’organismo vivente nel cervello. Voglio fare un romanzo, dirò così, omerico epico»; e ancora il 17 maggio 1886 ribadisce, allo stesso destinatario: «E intanto lavoro al romanzo») e ripiega sulle novelle, che raccoglie nel volume San Pantaleone pubblicato nell’autunno 1886 dall’editore Barbera di Firenze. L’accoglienza è fredda, causa, forse, l’eccessiva e compiaciuta cura formale che distanzia le narrazioni dal registro verista allora imperante. Per il Natale 1886, esce, editrice «La Tribuna», l’Isaotta Guttadàuro ed altre poesie in raffinata veste editoriale con illustrazioni di Cabianca, Sartorio, Carlandi, Cellini, Coleman, De Maria, Formilli, Morani, Ricci (a...