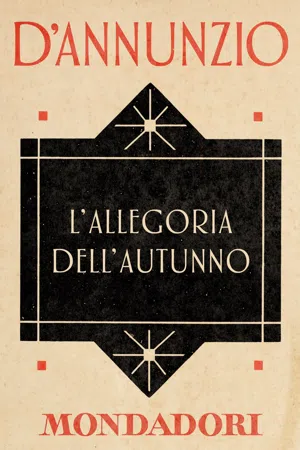![]()
1 NOTIZIA SUL TESTO
Edito nel 1934 nell’ambito dell’Edizione nazionale dell’Opera omnia, il volume antologico è intitolato dallo scritto d’apertura, che ripropone un’antica plaquette del 1895 pubblicata con pari titolo dal fiorentino Paggi: un manipolo di versi incompiuti (Frammento d’un poema obliato), pretesto per la Glosa, ovvero il discorso con il quale d’Annunzio chiudeva, l’8 novembre di quell’anno, la prima Esposizione internazionale d’arte di Venezia, in cui l’amico conterraneo Francesco Paolo Michetti aveva trionfato con La figlia di Iorio grazie ai suoi buoni uffici. Già riproposto nel Fuoco, romanzo veneziano del 1900 dove ricompare quasi immutato, il discorso sulla pittura veneziana intavola uno dei grandi temi del volume: la critica pittorica dell’artifex additus artifici, rappresentata anche attraverso i saggi coevi su Giorgione e su Michetti.
Quasi replica delle Prose scelte del 1906 e del Libro ascetico della giovane Italia del 1926, anch’essi antologici, L’allegoria dell’Autunno riprende la formula di entrambi e, negli anni del tramonto, muove dalle ragioni autocelebrative che hanno indotto d’Annunzio, una volta ritiratosi dalla lotta politica, a ripercorrere la propria vicenda rintracciandovi le tappe più significative della militanza estetica combattuta in particolare sulle colonne del «Convito» e del «Marzocco», riviste di punta della Terza Italia da lui animate. Il Vate recluso nel Vittoriale rivendica così il ruolo d’avanguardia che egli ha svolto predicando in anni remoti, in più di un caso ancora ottocenteschi, gli alti destini della Patria erede della tradizione greco-latina e rinascimentale.
L’Orazione agli Ateniesi del 1899, pronunciata nella capitale greca che affidava a d’Annunzio l’annuncio al mondo del ritrovamento dell’Auriga di Delfi, confronta infatti vittoriosamente la modernità con il «Passato augusto» che autorizza la nuova grandezza del presente. Parallelamente, il discorso dantesco dell’anno successivo, anch’esso solenne, inaugurale della Loggia che Firenze dedica in Orsanmichele alle Lecturae Dantis, insiste sulla coincidenza tra poesia e geografia, tema ricorrente del nazionalismo dannunziano. Nazionalismo che spicca negli epicedi: di Shelley, commemorato nel 1892, sommo poeta lirico, voce vicaria del poeta-maestro Enrico Nencioni, che non seppe «sciogliere il suo nodo ritmico». Affettuose e accorate le parole per Nencioni quanto togate e distanti quelle del 1907 per Carducci, anch’egli maestro, ma «avverso», al quale, scalzato l’ombroso Pascoli, d’Annunzio intende succedere. L’epicedio carducciano è perciò affiancato dalla coeva Canzone per la tomba di Giosuè Carducci, chiusa da non reticenti versi di autoinvestitura: «La fiaccola che viva Ei mi commette / l’agiterò su le più aspre vette».
Nella logica del recupero che presiede l’assemblaggio antologico, si colloca la ripresa della Rosa di Cipro, libretto per Puccini abbozzato nel 1906 e rimasto incompiuto perché la distanza che separa i due artisti non viene colmata dal sodalizio che molti auspicano. In calce, la data «10 luglio 1912» partecipa di quella falsificazione a cui d’Annunzio è incline nell’autolettura: la cronologia inventiva mira ora ad accomunare i lacerti della Tragedia lirica alla Pisanelle, ou le jeu de la rose et de la mort, come intitolerà fra poco (1935) l’edizione, per la prima volta in volume, della Pisanelle, ou la mort parfumée, pantomima del 1913, musicata da Pizzetti.
Collocato al centro dell’Allegoria dell’Autunno, l’abbozzo teatrale ne conclude la prima parte dedicata alla saggistica e agli epicedi; d’ora in avanti si tratterà invece di prefazioni e messaggi, scelti fra i molti che si devono al d’Annunzio promotore di imprese culturali. Di spicco Per la Raccolta nazionale delle musiche italiane, iniziativa di Umberto Notari, promossa nel 1917 dal poeta-soldato insieme con Malipiero, Pizzetti, Balilla-Pratella e Pirinello, ne attesta l’intensificarsi degli interessi musicali durante il conflitto, di cui il Notturno è massimo testimone e che prosegue negli anni del Vittoriale con il patrocinio dell’edizione di Tutte le Opere di Monteverdi «il Divinissimo», procurata da Malipiero (uscirà tra il 1927 e il 1946).
Già riproposta nel 1928, nel secondo tomo delle Faville del maglio (cfr. Il compagno dagli occhi senza cigli), al destino di Favilla era invece sfuggita la prefazione del 1909 alle Osterie d’Italia di Hans Barth in forma di «epistola», visto che I vini e il lurco compariva come Epistola vinosa negli elenchi preparatori del 1924, riguardanti il primo tomo. E in effetti, più che riferirsi alla guida del giornalista tedesco, ad uso del viaggiatore turista, d’Annunzio indulge ai propri ricordi di astemio, di «orgiaste» come dice «senza vino», che risalgono all’antica escursione in Sardegna del 1882 o agli anni romani dell’inizio secolo ripercorsi attraverso appunti di Taccuino attentamente elaborati.
Proprio perciò, avrebbero ben figurato nell’Allegoria dell’Autunno sia la prefazione del 1898 alla Disciplina degli Archivi, Diplomi e Carte antiche, studio di Pasquale Trivelli, anch’essa poi nei progetti delle Faville con il titolo La rosa per man di notaro, sia quella del 1913 alla Divine comtesse, biografia della contessa di Castiglione, opera di Robert de Montesquiou (entrambi gli scritti si leggono in Ric. in Appendice, insieme con altri esemplari prefativi). Ma l’omaggio del 1928 a Ojetti, amico di antica data ora tradotto in Inghilterra, e del 1926 a De Pinedo, pioniere delle trasvolate oceaniche, illustra qui solo per esemplari la versatilità di chi ha inteso estendere in ogni ambito il proprio protagonismo.
Quello sportivo domina nei messaggi raccolti, del pari scelti con parsimonia fra la messe che abbonda nell’ultimo scorcio dannunziano. Intercalati all’epicedio per Ruggero Maroni, fra gli allestitori del Vittoriale, al ringraziamento rivolto a Innocenzo Cappa, che a Pescara ha commemorato la madre del poeta, o al saluto per i veterani, i messaggi per le gare agonistiche confermano la predilezione per gli sport che connota in modo singolare la vicenda di d’Annunzio, letterato tutt’altro che sedentario, pioniere agli albori del Novecento dell’automobile e dell’aereo. Ciò che durante la guerra gli consentirà di realizzare le imprese eroiche nelle diverse Armi.
Da segnalare in proposito il messaggio del 1934 al podestà di Milano, Marcello Visconti di Modrone, premesso al Catalogo della grande mostra aeronautica realizzata allora da Italo Balbo, trasvolatore e ministro dell’Aviazione. Datato 9 agosto, il messaggio commemora lo storico volo su Vienna che nel 1918 ha annunciato la vittoria italiana attraverso il lancio di volantini sulla capitale austriaca. Il riferimento a quel volo vittorioso e incruento suona qui polemico. Nell’agosto 1934 le nostre divisioni presidiano il Brennero dopo il fallito putsch nazista a Vienna (Dollfuss è assassinato il 4 agosto) e d’Annunzio, che ha disapprovato l’incontro di Mussolini con Hitler il 14 giugno, a Venezia, al punto di non voler ricevere il «caro compagno» al Vittoriale sulla via del ritorno, ricorda qui il proprio disegno di un volo su Berlino. In modo poi surrettizio rende note le sue posizioni antihitleriane, manifestate ripetutamente invano a Mussolini. È il Duce e non il podestà di Milano il destinatario del messaggio in cui d’Annunzio esorta a «vegliare sul commissario della ipocrisia poiché fu commesso l’errore di gradirlo». Si fa udire così l’ultimo dissenso del Vate, che presto cadrà dinanzi alla conquista dell’Impero, quando, in occasione della campagna d’Africa, egli non farà mancare il suo autorevole appoggio al regime fascista. ←
* * *
2 L’ALLEGORIA DELL’AUTUNNO
«D’improvviso ieri mi si aprì nell’anima un antico germe di poesia. Mi tornò nella memoria il frammento d’un poema obliato che incominciai a comporre in nona rima qui a Venezia, quando venni per la prima volta navigando, alcuni anni fa, in un settembre della prima giovinezza. Era intitolato appunto L’allegoria dell’Autunno e vi si rappresentava il dio – non più inghirlandato di pampini ma coronato di gemme come un principe del Veronese e infiammato di passione le vene voluttuose – nell’atto di migrare verso la Città anadiomene dalle braccia di marmo e dalle mille cinture verdi. Allora l’idea non era giunta a quel grado di intensità che è necessario per entrare nella vita dell’arte; e io rinunziai istintivamente allo sforzo di manifestarla intiera. Ma, poiché nello spirito attivo come nel terreno fertile non si perde alcun seme, essa ora mi risorge nel momento opportuno a chiedere con una specie d’urgenza la sua espressione.» Così nel Fuoco (cfr. Rom. II, p. 236), il romanzo veneziano che sviluppa a oltranza il Frammento e include quasi intatta la Glosa, d’Annunzio espone le ragioni metaletterarie della riproposta.
Stesi davvero in occasione del primo soggiorno veneziano del settembre 1887, quando Venezia è raggiunta avventurosamente con il panfilo Don Juan di De Bosis (lo smarrimento della rotta e il salvataggio da parte della corazzata Agostino Barbarigo daranno origine all’Armata d’Italia), i versi in nona rima non sono i soli dedicati allora a Venezia e all’autunno, stagione della perfetta maturità, ora topica della città lagunare. Il 16 ottobre 1887 uscivano appunto nel «Fanfulla della Domenica», col sopratitolo di Prologo d’una Allegoria dell’Autunno, i due Sonetti del giovane Autunno poi inseriti nell’Isottèo (Versi I, pp. 443-4). Il primo – Il munifico Autunno è un giovinetto… – contiene i motivi che i novanta versi incompiuti sviluppano: in particolare, il corteo, tanto caro al poeta degli esordi, incline ai fasti parnassiani nel cui ambito rivisita la nostra tradizione quattro e cinquecentesca. E non sorprende che si fissi per sempre, nell’immaginario dannunziano, la giuntura Venezia-autunno e che l’autunno resti la stagione privilegiata di pagine imminenti, in attesa di quelle su Giorgione e di quelle della Glosa che nel 1895 costituiranno il preludio del Fuoco.
Una volta rientrato a Roma, forse prima ancora di stendere sonetti e nona rima, il Duca Minimo consegna alla «Tribuna» un articolo davvero enigmatico, dal titolo Un poeta d’autunno (8 ottobre 1887; SG I, pp. 935-8). Certo fantastico, Adolphous Hannaford è un inglese contemporaneo che si ispira a Keats: tutte le sue liriche «sono d’argomento autunnale», scrive il cronista che sotto mentite spoglie parla di sé, del suo aggiornamento estetico in ambito preraffaellita all’ombra di Nencioni e di De Bosis.
Imminente è infatti Il piacere, romanzo sì romano, ma dove Roma appare come una «città dell’Estremo Oriente» e dove l’autunno svolge il fondamentale ruolo figurativo indispensabile alla «trasposizione tragica», cioè all’ambiguità che del romanzo rappresenta il fulcro. D’Annunzio è confortato da Amiel, di cui traduce non a caso, accingendosi al cimento narrativo, i passaggi autunnali dei Fragments d’un journal intime (1886): «Il sole accendeva tutti i colori autunnali: l’ambra, lo zafferano, l’oro, lo zolfo, l’ocra, l’arancio, il fulvo, il rame, l’alga marina, l’amaranto. // Vi sono due forme dell’autunno: il tipo vaporoso e soave; il tipo colorito e vivo: quasi la diversità dei due sessi – Stagione bisessuale. La gamma minore e la gamma maggiore, luce e ombra, grazia e forza – L’autunno pallido, l’autunno vermiglio – il sogno, la vendemmia». Con tali ingredienti, Andrea Sperelli, il suo primo eroealter ego, vivrà una significativa rinascita autunnale.
Solo però all’indomani delle Vergini delle rocce e quando Il fuoco non si è profilato, gli antichi versi riemergono, senza dubbio in margine al Giorgione di Angelo Conti, l’amico perduto e ritrovato nel settembre 1894 proprio a Venezia dov’è di stanza nella nuova veste di soprintendente ai musei. Siamo al secondo soggiorno veneziano di d’Annunzio, durante il quale incontra Georges Hérelle, il suo traduttore, e, forse, la Duse, insieme con notabili locali che penseranno a lui per la chiusura della prima Esposizione internazionale d’arte di lì a un anno.
È da credere che senza le sollecitazioni di d’Annunzio Francesco Paolo Michetti non sarebbe riuscito a imporre vittoriosamente la sua Figlia di Iorio all’Esposizione del 1895. Forte della propria fama, coronata nel biennio 1894-95 dal susseguirsi delle traduzioni d’Oltralpe, chiede di persona lo spazio più confacente alla grande tempera profittando dell’amicizia intrecciata con Riccardo Selvatico e Antonio Fradeletto, i responsabili dell’iniziativa. Il 6 aprile si rivolge perciò a Selvatico mostrandosi attento regista del dipinto: «il quadro di F.P. Michetti […] ha bisogno dell’intera parete d’una sala. Scrissi già all’egregio Fradeletto pregandolo di serbare una parete di fondo larga circa sette metri. Aggiungo che la parete risponderebbe a tutte le convenienze se guardasse il nord, cioè se nella sua faccia interna fosse rivolta verso il nord per modo che il sole non la toccasse. La “tempera” ha bisogno di una luce calma e misurata. Il sole la distruggerebbe» (G. Damerini, D’Annunzio e Venezia, Milano 1943, p. 39).
Invece di un discorso inaugurale, com’era convenuto, d’Annunzio chiuderà l’Esposizione l’8 novembre insieme con Pompeo Molmenti, l’autore della
Storia di Venezia, chiamato in forze dagli organizzatori nel timore delle divagazioni dannunziane, tanto suggestive quanto forse non aderenti alla circostanza. E in effetti, l’oratore al debutto intende giocare dinanzi allo scelto pubblico veneziano tutte le sue carte; preferisce quindi lasciare da parte la pittura di Michetti, a cui del resto dedicherà un lungo saggio nel «Convito», VI, 1896 (
), per rivolgersi a Venezia, glorificandone la bellezza autunnale e perciò ambigua, «bisessuale» e vitalissima: non la Venezia mortuaria, meta vulgata del turismo internazionale come dell’estetismo di fine secolo.
Il dialogo, in proposito, con Angelo Conti deve essere sostenuto da letture mirate e l’oratore è a Venezia già il 25 settembre. Il prefetto della biblioteca Marciana, Carlo Castellani, lo soccorre nelle ricerche erudite da sfoggiare nella Glosa, come intitolerà il discorso che a stampa accompagna il Frammento, avendo d’Annunzio preso accordi con l’editore Paggi di Firenze per la realizzazione di una raffinata plaquette. A cominciare da Storia di Venezia nella vita privata e La dogaressa di Venezia (1887) di Molmenti e dai recenti studi di Malamanni, Il Settecento a Venezia (1892), e di Volpi, Storie intime della Repubblica di Venezia (1893), come testimoniano le consultazioni bibliotecarie (cfr. G. Zorzanello, D’Annunzio e la biblioteca Marciana, in QV, 37, 1983), l’accumulo erudito raggiungerà allo scoperto le pagine del Fuoco (che includono per intero la Glosa) attraverso il dialogo di Stelio e Foscarina: «Confessate […] che la mia erudizione vi sbalordisce. Ah se sapeste quanta ne ho accumulata!» (Rom. II, p. 214).
Mentre il discorso di d’Annunzio viene pronunciato al Ridotto della Fenice, il romanzo preferirà collocarlo nella Sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale indugiando su una cornice che la dice lunga circa le mire dell’oratore: nella favola narrativa diventa il «divo» a cui persino la regina Margherita rende omaggio, collocata com’è tra il pubblico, con un totale ribaltamento di prospettiva rispetto all’Eterno femminino regale di Carducci (1882) poiché il centro della scena è occupato dall’«Imaginifico» e non dalla sovrana (cfr. Rom. II, pp. 253 sgg.).
L’elogio della pittura veneziana, da Tintoretto a Veronese a Giorgione, segna un traguardo del d’Annunzio figurativo che enuncia una delle sue formule critiche di maggior destino: «artifex additus artifici». È la poetica del Fuoco e, in futuro, della prosa metaletteraria, quando l’«artificio», in una chiave sempre più narcisistica, sarà il suo proprio.←
3 ORAZIONE AGLI ATENIESI
Il testo ripropone pressoché immutato il Discorso agli Ateniesi apparso sul «Marzocco» del 28 maggio 1899 (cfr. SG II, pp. 460-3) e rimanda al secondo viaggio di d’Annunzio in Grecia, compiuto al fianco della Duse, fra la fine di gennaio e il marzo del 1899. Come informa B. Lavagnini, Alle fonti della Pisanella ovvero d’Annunzio e la Grecia moderna, Palermo 1942, il discorso in cui si celebra il rinvenimento, avvenuto tre anni prima, del capolavoro scultoreo di Delf...