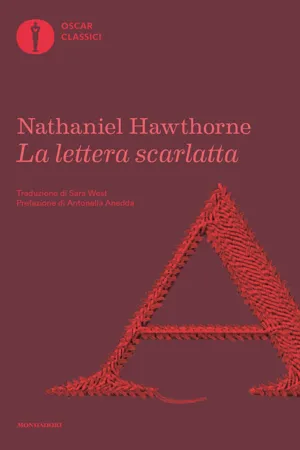![]()
È strano che io, contrario per natura a parlare di me e delle cose mie con i miei amici in un canto del focolare, per la seconda volta nella mia vita prenda a narrare cedendo ad un impulso autobiografico. La prima volta fu tre o quattro anni fa, quando – senza ragione di sorta che mi venisse dalla indulgenza del lettore o dalla mia audacia – elargii al pubblico una descrizione della mia vita nella quiete profonda di un vecchio presbiterio. E ora, soltanto perché la prima volta di là da ogni mio merito, mi toccò la fortuna di trovare chi mi ascoltasse, afferro per la giacca il lettore e mi metto a raccontargli la mia triennale esperienza in un ufficio di dogana.
Ma la verità è forse un’altra: che l’autore, quando lancia i suoi fogli al vento, non pensa mai ai molti che getteranno il suo libro in disparte e disdegneranno persino di aprirlo, sì ai pochi che potranno capirlo come lo capirebbero i suoi compagni di scuola e di vita. E difatto qualche scrittore va tanto oltre per questa via, che si abbandona a confidenze di carattere così intimo e geloso, quali potrebbero essere fatte soltanto al lettore di cui egli si fosse assicurata una compiuta simpatia di mente e di cuore: come se il libro lanciato per il mondo dovesse trovare senz’altro l’anima gemella di chi lo scrisse e compiere il suo ciclo di vita con la perfetta comunione di questa con l’anima dello scrittore.
Un simile abbandono non mi par decoroso, anche se il racconto sia fatto in terza persona; ma poiché senza una diretta rispondenza tra chi parla e chi ascolta, i pensieri si cristallizzano e la suggestione si spegne, si può anche consentire all’autore di illudersi che almeno un amico – un sensibile amico, se non il più intimo – sia ad ascoltarlo: dal pensiero di codesta ideal compagnia sarà vinto il suo naturale pudore, ed egli potrà parlare di se stesso e della realtà che lo tocca più da vicino, lasciando sotto un velo il suo “io” più segreto. In questo senso e dentro questi limiti io credo consentita l’autobiografia e che essa non violi né i diritti di chi scrive né quelli di chi legge.
Si vedrà poi come nel caso attuale l’autobiografia abbia anche un’altra giustificazione: di spiegare cioè come i fatti che seguono siano venuti a mia conoscenza e di fornire in certo modo al racconto una prova di autenticità. È questa principalmente la ragione che mi ha indotto a entrare io stesso in rapporto col lettore e a prendere parte a quel che accade in molte di queste pagine; e per riuscire a tanto ho creduto opportuno di dipingere in rapidi tocchi un genere di vita non ancora descritta da altri e taluni personaggi, tra i quali appunto figura l’autore del libro.
Ai tempi dell’antico Re Derby, la mia nativa città di Salem aveva un affollato e tumultuoso scalo, che è ora invaso da decrepiti magazzini di legno e non dà che rarissimi segni di vita commerciale: vi si incontrano tutt’al più qualche vecchia barcaccia, o qualche brigantino che va scaricando pollame dal malinconico bordo; o qualche goletta della Nuova Scozia, beccheggiante sotto il carico di legna da ardere. All’estremo di questo molo in rovina, che spesso la marea ricopre e lungo il quale l’erba cresciuta tra le commessure delle pietre denuncia lo squallore in cui è caduta la vita del porto, sorge un vasto caseggiato il quale guarda lo scenario ora descritto: e, di là da questo, la baia. Su l’edificio, per tre ore e mezza precise di ogni pomeriggio, ondeggia al vento, o s’affloscia nella bonaccia, la bandiera della Repubblica: bandiera dalle tredici strisce verticali, che indicano come sia ivi installato un ufficio civile del governo dello Zio Sam, mentre sugli stabilimenti militari sventola la bandiera a strisce orizzontali. La facciata è adorna di un vasto portico che regge, sopra una mezza dozzina di piloni di legno, una balconata, e da questa si scende alla strada per una larga scalea di granito: sull’ingresso del palazzo è scolpita una enorme aquila americana ad ali spiegate, la quale reca uno scudo sul petto, stringe un fascio di folgori e dardi in ogni artiglio, e, – bestione di pessimo carattere – con l’espressione feroce degli occhi e del becco ricurvo ha l’aria di minacciare terribili guai all’inoffensiva borgata e di ammonire i passanti che si tengano il più lontano possibile dai suoi rostri se amano la loro incolumità. E vien fatto di credere per questo che nessuno osi accostarsi alla bestia paurosa: molti invece stanno ora cercando riparo proprio sotto le ali dell’Aquila federale e immaginano (suppongo) che il suo seno sia soffice come un cuscino di morbida lana di cigno. Vana illusione, ché la bestia è tutt’altro che tenera anche nei momenti di ottimo umore, e presto o tardi, con un colpo d’artiglio o una beccata o una punta dei suoi dardi, finirà per mandare all’aria la nidiata.
Si è già detto che attorno a questo edificio, dove ha sede la dogana del porto, è cresciuta molta erba tra le commessure delle pietre, da quanto squallida si è fatta la vita del luogo; pure in qualche rara mattina dell’anno accade di assistere ad una ripresa dell’antico fervore e del traffico tumultuoso d’un tempo e allora i cittadini ripensano ai giorni lontani, antecedenti alla guerra con l’Inghilterra, in cui Salem era ancora un gran porto e i mercanti e gli armatori non lo avevano disertato per andare ad accrescere, sia pure impercettibilmente, con i loro affari, la grossa fiumana che sfocia a Boston o a New York. Quando in quelle rare mattine tre o quattro bastimenti, provenienti quasi sempre dall’Africa o dall’America del Sud, approdano al derelitto porto o si accingono a salpare da questo verso quelle remote regioni, la scalea di granito torna a risonare di passi affrettati. Vedi allora il nostromo, bruciato in faccia dalla salsedine, che porta sotto braccio la scatola di zinco contenente le carte di bordo, e lì, sul molo stesso, puoi dargli il benvenuto ancora prima che egli abbia riabbracciato la sposa che lo attende. E vedi l’armatore gaio o ammusonito, aspro o cordiale, a seconda che le sue speranze si siano o no avverate e il bastimento gli abbia portato mercanzia da barattare con buon oro sonante, o sia fallita l’impresa ed egli non ne ricavi che il danno e le noie. E vedi, interessante personaggio, quello che potrebbe esser detto il germe del vecchio lupo di mare, del mercante rugoso e grigio di barba e di umore: intendo parlare del giovane impiegato, svelto e traffichino, che già comincia ad assaporare il gusto del commercio come un lupacchiotto quello del sangue, e va cercando avventure sui legni del suo principale, mentre farebbe assai meglio se pensasse a varare battelli di carta in una pozzanghera. E incontri qualche marinaio, che, appena sbarcato, cerca protezione, e qualche altro che, debole e stanco, chiede d’entrare all’ospedale. E riconosci subito i capitani dei brigantini che hanno portato legname da ardere dalle province britanniche: marinai rudi che non hanno la snella andatura e l’aspetto svelto degli yankees ma hanno egualmente la loro importanza nella misera vita commerciale del porto.
Di tutte queste figure s’avviva in quelle rare giornate l’ufficio di dogana; ma più sovente, salendo le scale, ti accadrebbe di scorgere – sulla porta, l’estate; chiusi nelle loro stanze, l’inverno – una fila di venerabili uomini seduti su seggiole di vecchissimo tipo, appoggiate al muro in bilico sulle due zampe posteriori. Sonnecchiano per lo più, ma qualche volta conversano scambiandosi uno strano miscuglio di parole e di informi brontolii: con quella flaccida inerzia alla quale si riconoscono gli ospiti di un istituto di carità e tutti coloro che vivono di beneficenza o d’un lavoro monopolizzato o di risorse che non impegnano mai l’iniziativa personale. Sono questi buoni vecchioni, – destinati, come Matteo, a incassare i dazi ma non suscettibili, come l’evangelista, di essere tratti di lì per qualche missione apostolica – gli ufficiali della dogana.
Ma procediamo oltre: a sinistra appena s’entra dalla porta principale, è una stanza quadrata di circa cinque metri di lato e dal soffitto piuttosto alto, destinata a ufficio. La stanza guarda per due grandi finestre ad arco sul decrepito molo e da un’altra, attraverso uno stretto vicolo, sulla via Derby. Dalla finestra si scorgono botteghe di droghieri, rigattieri, mercanti di attrezzi navali, alle cui porte sono sempre crocchi di vecchi e di altri frequentatori del porto che cianciano e ridono tra loro.
La stanza è grigia, smorta, con qualche ragnatela alle pareti e al soffitto; l’impiantito è cosparso di sabbia grigia secondo la vecchia abitudine ormai abbandonata, e tutto l’aspetto rivela come in questo luogo entri di rado la donna con i suoi preziosi arnesi che sono la spazzola e la granata. In quanto al mobilio, tutto si riduce a una stufa, a una vecchia tavola di pino, presso la quale barcolla una poltrona a tre gambe, tre o quattro sedie di legno decrepite e zoppicanti e, per non dimenticare la biblioteca, una quarantina di volumi degli Atti del Congresso, sparsi su alcune tavole inchiodate al muro, e un grosso Digesto delle imposte sui redditi: un tubo sottile attraversa il soffitto e costituisce una specie di portavoce per comunicare con gli altri piani della casa. In questa stanza, circa sei mesi fa, il lettore avrebbe potuto sorprendere – seduto alla meglio sulla poltrona zoppicante e coi gomiti poggiati sulla tavola di pino o a passeggio su e giù per la stanza, gli occhi a un giornale – lo stesso uomo che una volta lo accolse nel suo gaio scrittoio del vecchio presbiterio, illuminato da un bel sole giocondo. Ora non più, ché il turbine della Riforma lo ha scacciato di lì e un più degno successore riveste la sua carica e intasca i suoi emolumenti.
Ho vissuto molto tempo lontano dalla mia città nativa, ma questa vecchia Salem mi è rimasta nel sangue, e l’ho oggi assai più cara di quanto non l’avessi durante la mia permanenza. Monotona com’è, squallida nelle sue case di legno e nelle vie che sboccano tutte nel più triste paesaggio, artisticamente disadorna, deserta d’ogni attrattiva, quella città tuttavia suscita in me un attaccamento sentimentale, che difficilmente ispirano le più convulse e tumultuose città moderne. E però mi sento legato a Salem da un affetto quale non nutro per alcun’altra città, anche se altrove io abbia condotto una molto più facile e piacevole vita.
Sentimento questo, cui forse non è estraneo il fatto che tutta la mia gente è di lì. A Salem infatti i primi inglesi che portavano il mio nome immigrarono duecentoventicinque anni fa, quando la colonia era ancora selvaggia, sparsa per la foresta dove è sorta la città attuale. E quivi tutti i loro discendenti nacquero e morirono, mescolando alla terra la loro sostanza umana; tanto che ormai deve esserci una certa parentela tra la zolla e questa mia mortale carcassa che la calpesta, e forse al fondo dell’attaccamento di cui vi ho parlato non è se non la misteriosa simpatia della polvere per la polvere. Non molti dei miei concittadini hanno gli stessi miei sentimenti nei riguardi della loro città: meglio per loro, ché la varietà di vita e il movimento, a quanto si dice, sono propizi allo sviluppo della razza...
C’è per altro, in questo sentimento, una sorta di suggestione morale legata alla figura del mio primo avo, il quale giganteggiò, nella paurosa grandezza di cui la tradizione famigliare lo rivestiva, sul mio spirito di fanciullo. Codesta figura mi è ancora viva nel pensiero e m’avvince tuttavia a quei tempi lontani; onde mi sembra che alla cittadinanza di Salem io abbia diritto, più che per me stesso, per lui: per questo mio lontano avo cioè, grave, barbuto, vestito di nero sotto l’alto cappello a cono, che venne a installarsi qui tanto presto con la sua spada e il suo Vangelo, e passeggiò così maestosamente per quelle vergini strade ed ebbe tanto vasta rinomanza di capitano e di scrittore, mentre il mio nome è quasi sconosciuto.
Era soldato, legislatore, giudice, uno degli alti membri del clero, e aveva tutte le qualità, buone e cattive, dei puritani del suo tempo. Ma soprattutto era un tremendo, palese persecutore dei quaccheri, i quali ne ricordano il nome nelle loro cronache a proposito di un caso di crudele severità, esercitata contro una donna della loro setta; e il gravissimo caso purtroppo servì, meglio di ogni altro gesto anche più degno, a immortalare il nome dell’avo mio.
Non degenere, il figlio di costui, nel quale anzi lo spirito di persecuzione si era fatto più aspro e violento: egli divenne infatti così famoso per la sua crudeltà nell’inventare martirî per streghe e fattucchiere, che il nome di lui parve macchiato per sempre da tanta ferocia, e le sue ossa, se ancora non siano ridotte in polvere nel cimitero di Charles Street, debbono serbare tuttavia di quella macchia una traccia profonda.
Non so se questi miei antenati abbiano pensato in tempo a pentirsi delle loro colpe, e a chiedere perdono a Dio, o se in un’altra vita essi ora paghino il fio delle loro crudeltà: comunque io che scrivo oggi queste pagine prendo sopra di me l’onta delle loro gesta, e invoco che sia distolta ogni maledizione dalla loro memoria; ché, a quanto mi consta e come prova il decadere della nostra famiglia per tanti e tanti anni, di maledizioni, ce ne furono certamente e non lievi!
Devo dire per altro che tutti e due quei terribili uomini riterrebbero senza dubbio castigo adeguato alle loro colpe il vedere che il vecchio ceppo, così a lungo prestigioso, non abbia saputo produrre altro che un indolente e un fannullone come me. Essi non attribuirebbero alcun valore agli ideali che ho posti alla mia vita, e i miei pochi successi (seppure ne ho avuti all’infuori della vita domestica) non parrebbero loro degni di alcuna considerazione. “Chi è? Che cosa fa nella vita?” sussurrano certamente le due ombre grigie degli avi. “Perde il suo tempo a scrivere racconti! Bel modo di occuparsi! Bel modo di glorificare Iddio e rendersi utili al prossimo! E perché allora non si è messo a fare il sonatore girovago?”
Ebbene: mi sprezzino pure a loro piacimento! Questo non toglie che nella mia natura si riscontrino ancora tracce non dubbie e profonde di quello che essi furono un giorno...
La mia razza, piantata saldamente su quei due gravi ed energici uomini quando la città era ancora agli albori, vi si è sempre mantenuta degna di rispetto. Per quanto io sappia nessuno dei suoi membri l’ha mai disonorata o se ne è mostrato indegno; ma, d’altra parte, assai raramente dopo le due prime generazioni, è uscito dal ceppo comune un uomo che abbia compiuto qualche memorabile gesta o comunque sia emerso dalla folla. Tutti, più o meno, sono stati soffocati nell’oceano della mediocrità: come avviene a talune vecchissime case, che con l’andare del tempo scompaiono per il progressivo innalzarsi del suolo su cui i secoli accumulano strati di terriccio e di fango. Per più di cent’anni gli uomini della mia razza furono tutti marinai, di padre in figlio. In ogni generazione un canuto quartiermastro passava dal ponte di una nave al focolare, e un ragazzo di quindici anni assumeva il posto ereditario dinanzi a un albero maestro, fronteggiando per la prima volta la salsedine e le raffiche, che già avevano sferzato il volto dei suoi avi. Poi il ragazzo, col volger del tempo, passava dal castello di prora alla cabina, viveva la sua virilità tempestosa, e ritornava dal vagabondaggio intorno al mondo per invecchiare e morire e mescolare la sua polvere mortale alla terra nativa. Una così lunga ed ininterrotta relazione tra una stirpe e una terra crea tra queste una speciale affinità, una simpatia da non attribuirsi alla bellezza del luogo e del paesaggio né ad alcuna ragione di ordine morale. Non è amore, è istinto. L’abitante nuovo, venuto da altre contrade o figlio di parenti immigrati, ha poco diritto di chiamarsi salemita. Egli non può avere la più lontana idea di come s’attacca al suolo nativo un vecchio colono, la cui razza già da tre secoli vi sia saldamente abbarbicata: attaccamento di ostrica allo scoglio. Non importa che il luogo sia per lui avaro di gioie: che egli sia stanco delle vecchie case di legno, della polvere e del fango, della monotonia dei giorni e dei sentimenti, del freddo vento dell’ovest e dell’ancor più fredda atmosfera sociale: difetti questi senza importanza. Il fascino permane ed è tanto che la terra nativa pare una terra d’incanto, un paradiso terrestre.
E questo fu il caso mio.
Mi sembrò quasi fatale fare di Salem il mio rifugio, in modo che i caratteri tipici della mia gente potessero continuarsi in me: non riprende forse ogni discendente della razza il sentiero della vita al punto stesso in cui il suo predecessore scese nella tomba? Pure a un certo punto parve che codesta affinità fosse divenuta dannosa e che la catena dovesse spezzarsi. La razza umana, come ogni altro seme, non prospera rigogliosa, se ripiantata nello stesso terreno troppo a lungo sfruttato. I miei figli sono nati altrove; e finché il loro avvenire potrà essere sotto il mio controllo resteranno lontani dalla mia città.
Quando io uscii dal vecchio presbiterio, fui indotto ad assumere un posto nell’ufficio doganale dello zio Sam proprio da questo strano, indolente, monotono attaccamento per la mia terra: avrei potuto, se no, trovare altrove migliore occupazione. Ma il mio destino era questo. M’ero allontanato già altre volte da Salem, e sempre vi ero ritornato, come se questa città fosse per me il centro dell’universo.
Così un bel giorno salii la scalea di granito con la nomina presidenziale in tasca, e fui presentato a coloro che dovevano collaborare con me e dovevano aiutarmi ad affrontare le gravi responsabilità inerenti al mio ufficio di capo della dogana.
Dubito molto che alcun altro funzionario americano abbia mai avuto sotto di sé un corpo patriarcale di veterani, quale quello chiamato a servire sotto i miei ordini. Intuii al primo colpo d’occhio ch’essi erano tutti invecchiati là dentro: la dogana di Salem infatti per oltre venti anni si è mantenuta estranea agli uragani politici i quali soltanto compromettono la stabilità degli uffici. Il ricevitore – vecchio soldato ed ottimo ufficiale della Nuova Inghilterra – aveva potuto conservare a lungo il suo posto grazie appunto alla indipendenza creatagli dal suo glorioso passato di soldato; e la sua abilità, formatasi sull’esempio del più saggio spirito liberale, aveva procurato stabili posizioni anche ai suoi dipendenti. Il generale Miller era eminentemente conservatore, e la forza dell’abitudine aveva molta influenza sulla sua benevola natura: per questo egli si affezionava facilmente ai visi più noti e familiari, e si decideva a malincuore a qualsiasi cambiamento che pure gli sembrasse opportuno.
Quando dunque assunsi il mio posto, trovai pochi impiegati e tutti vecchi. Erano la maggior parte antichi capitani marittimi, i quali, dopo aver vagabondato sui mari più lontani battuti dalle mille tempeste della vita, avevano finalmente trovato riposo in quel tranquillo asilo, dove conducevano un’esistenza serena, turbata soltanto dal timore che si accompagnava a ogni nuova elezione presidenziale.
Come tutti gli uomini, erano certo soggetti anche questi alle malattie della vecchiaia; ma c’è da credere che possedessero il segreto di tener lontana quanto più possibile la morte. Tra questi valentuomini due o tre, gottosi o artritici da quanto mi dissero, non si facevano vedere in ufficio per la maggior parte dell’anno; e soltanto quando il sole di maggio e giugno succedeva ai rigori dell’inverno, essi uscivano dalle loro tane per avviarsi pigramente a quello che si compiacevano di chiamare il “dovere”, e tornarsene poi con tutto loro comodo a letto: devo confessare la colpa di avere abbreviato la vita a più d’uno di questi venerati servitori della Repubblica. Su mia richiesta molti furono esonerati dall’arduo lavoro, ma morirono tutti dopo essere stati messi a riposo: come se l’unica loro ragione di vita fosse l’ufficio dove avevano lavorato per tanti anni. Ma è di conforto all’anima mia pensare che fu in tal modo concesso loro tempo bastante a fare la dovuta penitenza dei peccati e delle male pratiche, che ritengo inevitabili per ogni impiegato alla dogana le cui porte non danno accesso diretto al Paradiso.
La maggior parte dei miei sottoposti apparteneva al partito dei Whigs; fu quindi gran ventura per la loro venerabile confraternita che il nuovo capo ufficio non fosse un politicante, e, per quanto sincero, democratico, deciso a non dare alcuna importanza alle opinioni politiche dei suoi sottoposti. Ché se invece quella carica autorevole fosse stata assunta da un politicante deciso a lottare contro un ricevitore del partito dei Whigs, cui gli acciacchi impedivano di tenere personalmente la gestione della dogana, neanche uno di quei vecchi veterani sarebbe rimasto per un mese al suo posto. Secondo le abitudini normali della vita politica, sarebbe stato un dovere infatti per il nuovo capo mandare quelle teste canute alla ghigliottina; e non era difficile accorgersi che quei vecchioni vivevano nel terrore di questa probabilità.
Mi divertì e mi commosse a un tempo questo terrore, quando io presi possesso del mio ufficio; mi commosse vedere un viso ornato di una venerabile barba bianca, arso da cinquant’anni di uragani, impallidire per lo spavento al minimo cenno di un uomo affatto inoffensivo qual io sono; cogliere, quando qualcuno di costoro si rivolgeva a me, il tremore di una voce usa a sovrastare l’urlo della tempesta e quasi a comandare gli elementi. Ma quelli sapevano che, sia per le loro opinioni, sia per la poca efficienza nel lavoro, avrebbero dovuto tutti essere sostituiti da gente più giovane, più ortodossa e più attiva; e lo sapevo anch’io, ma non mi decidevo mai ad agire di conseguenza. E però con grave disagio della mia coscienza di funzionario costoro continuarono per qualche tempo a trascinare le loro vecchie carcasse intorno ai moli e a zoppicare su e giù per la scalinata. E proseguirono pure a passare gran parte del tempo sonnecchiando nei cantucci consueti, sulle sedie appoggiate alle pareti, e destandosi appena una o due volte durante il pomeriggio per importunarsi a vicenda col racconto, ripetuto per la millesima volta, di vecchie storielle di mare o di barzellette secolari, divenute come giaculatorie sulle loro bocche. Credo comunque che costoro si accorsero presto come il loro sorvegliante fosse tutt’altro che un uomo da far paura.
E si illudevano costoro d’essere impiegati utilmente: vederli, con quanta acuta sagacia scrutavano attraverso gli occhiali le stive dei battelli, con quanto ardore battagliavano per le minime cose e con quale meravigliosa ottusità si lasciavano passare sotto il naso le veramente importanti... E vedere con che esemplare alacrità corre...