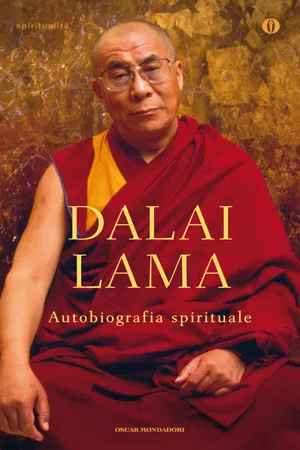![]()
![]()
Ero il solo a poter determinare l’unanimità
A sedici anni divento capo temporale del Tibet
Nell’ottobre del 1950, nelle regioni orientali del Tibet, l’Esercito popolare di liberazione infliggeva alle nostre truppe, male equipaggiate e numericamente molto inferiori, pesanti perdite. Quando si seppe che la città di Chamdo era caduta nelle mani dei cinesi, i timori si fecero più acuti. Di fronte al pericolo che si profilava, la popolazione di Lhasa si mobilitò per chiedere che fossi dichiarato maggiorenne e investito del potere temporale.
Sui muri della città furono affissi manifesti che criticavano violentemente il governo e chiedevano con forza che io prendessi immediatamente in mano le sorti del paese. Ricordo che, quando mi giunsero queste notizie, sentii montare in me l’angoscia. Avevo solo sedici anni e non avevo ancora completato la mia formazione religiosa. Inoltre ero all’oscuro di tutti i rivolgimenti che si erano prodotti in Cina e che avevano condotto all’invasione del nostro paese ed ero sprovvisto della minima preparazione politica. Perciò mi opposi, adducendo la mia inesperienza e la mia età, perché di norma un Dalai Lama solleva il reggente dal proprio incarico a diciotto anni.
In tutta evidenza il lungo protrarsi delle reggenze era uno dei punti deboli del nostro assetto istituzionale. In quegli ultimi anni io stesso avevo potuto constatare gli attriti fra le varie fazioni del governo e il loro effetto deleterio sull’amministrazione del paese, situazione che con la minaccia dell’invasione cinese finì per rivelarsi catastrofica. Avevamo più che mai bisogno di unità e nella mia veste di Dalai Lama ero il solo a poter determinare nel paese l’unanimità.
Il mio gabinetto decise di consultare l’oracolo di stato. Al termine della cerimonia il Kuten, ondeggiando sotto il peso del suo imponente copricapo rituale, mi venne vicino e mi mise sulle ginocchia una katha, la sciarpa bianca da cerimonia, sulla quale erano scritte le parole Thu-la bap, «È giunto il tuo momento».
L’oracolo si era espresso. Dovevo assumere le mie responsabilità e prepararmi senza indugio a guidare il mio paese, chiamato a scendere in guerra.
Il 17 novembre 1950 il Dalai Lama divenne ufficialmente capo temporale del Tibet. Il 1° ottobre 1949 Mao Tse-tung, sconfitti i nazionalisti, aveva proclamato a Pechino la nascita della Repubblica popolare cinese. Il 1° gennaio 1950 rese nota la sua intenzione di «liberare» il Tibet, che i cinesi chiamavano tradizionalmente «la Casa dei tesori dell’Ovest». Nel linguaggio della propaganda si trattava di mettere fine all’«imperialismo occidentale» e al «regime reazionario» dell’ultima teocrazia del mondo. All’epoca in Tibet c’erano solo sette stranieri.
Il 7 ottobre 1950 quarantamila uomini dell’Esercito popolare di liberazione varcano lo Yangtze, confine orientale tra Tibet e Cina. Malgrado la disperata resistenza degli ottomila e cinquecento soldati tibetani e quella dei cospicui ostacoli naturali, l’avanzata delle truppe cinesi si rivela incontenibile. Si ferma solo a cento chilometri dalla capitale, Lhasa.
Al governo tibetano viene intimato di inviare una delegazione a Pechino per negoziare con le autorità cinesi le condizioni della «liberazione pacifica» del paese.
Abbiamo erroneamente creduto
che l’isolamento potesse garantirci la pace
La minaccia che incombeva sulla libertà del Tibet non era sfuggita al mondo. Dopo il novembre del 1950 il governo indiano, sostenuto dagli inglesi, protestò presso le autorità della Repubblica popolare cinese, dichiarando che l’invasione del nostro territorio recava pregiudizio alla pace. Ma fu inutile. Ci avviavamo a pagare il prezzo del nostro ancestrale isolamento.
La geografia ha isolato il nostro territorio dal resto del mondo. Nel Tibet di un tempo, per raggiungere le frontiere dell’India e del Nepal partendo da Lhasa, bisognava sobbarcarsi un lungo e faticoso mese di viaggio attraverso le alture himalayane, per la maggior parte dell’anno impraticabili.
L’isolamento è un fattore caratteristico della nostra terra e noi l’abbiamo rincalzato deliberatamente autorizzando l’ingresso solo a un esiguo numero di stranieri. In passato Lhasa era chiamata «la Città proibita». Storicamente le nostre relazioni con i popoli vicini – mongoli, manciù e cinesi – sono state conflittuali, è vero. Ma adesso ciò che desideriamo più di ogni altra cosa è vivere in pace, nello spirito della nostra religione. Abbiamo creduto di poter perpetuare questo stile di vita pacifico restando ai margini del mondo: è stato un errore. Oggi perciò mi impongo di lasciare la porta spalancata a tutti.
Giustamente il Dalai Lama si rammarica che, per mancanza di interesse verso la politica estera e per mancanza di esperienza nelle relazioni internazionali, il Tibet abbia trascurato di fare riconoscere ufficialmente dalla comunità degli stati la propria indipendenza. Il tredicesimo Dalai Lama ne aveva avuto l’occasione, quando, all’epoca della prima rivoluzione cinese, nel 1911, aveva dichiarato l’indipendenza del paese, espellendo da Lhasa gli amban e una piccola guarnigione di soldati cinesi.
All’inizio del XX secolo il Tibet soddisfaceva tutti i criteri per la sovranità de facto di uno stato. Aveva un territorio con frontiere definite e un governo che godeva di piena autorità, in grado di intrattenere relazioni internazionali. Alla conferenza panasiatica di Nuova Delhi del 1947 i delegati tibetani, con la loro bandiera, furono tra i rappresentanti delle trentadue nazioni presenti. Ma la diplomazia tibetana si limitò ai contatti con i paesi confinanti: l’India britannica e poi, nel 1947, indipendente, il Nepal, il Bhutan e la Cina. Così quello statuto d’indipendenza de facto non fu formalizzato sul piano internazionale.
Se l’indipendenza del Tibet rispetto alla Cina è fonte di interpretazioni contraddittorie, ciò si deve alle complesse, e spesso malintese, relazioni tra i due paesi, nei quali politica e religione sono stati a lungo indistricabili. Dopo essere sceso in guerra contro la Mongolia, la Cina e le cittàstato della Via della seta, nell’VIII secolo, all’epoca del suo apogeo militare, il regno del Tibet comprendeva comunità indoeuropee, turche e cinesi, ed era arrivato a occupare la capitale della Cina, Chang’an. Poi, nel X secolo, fu conquistato dai mongoli, che tuttavia non lo integrarono mai nel loro impero.
Tra i Dalai Lama tibetani e i Khan mongoli si stabilì il rapporto che sussiste tra un maestro spirituale e un protettore laico1 e quando, nel XIII secolo, i mongoli insediarono in Cina la dinastia Yuan, tra i Figli del Cielo e il Dalai Lama si stabilì un legame analogo. L’imperatore cinese era considerato dai tibetani un’emanazione terrena di Manjushri, il bodhisattva della Sapienza risvegliata, e gli era riconosciuto il ruolo di protettore materiale. Il Dalai Lama, il cui lignaggio di reincarnazione si ricollega ad Avalokiteshvara, il bodhisattva della Compassione risvegliata, esercitava un’autorità spirituale, rispettata anche in Cina e in Mongolia.
Nel quadro di questa speciale relazione, durante il XVIII secolo, quando il Tibet fu straziato da una guerra civile, l’esercito cinese intervenne per restituire il trono al settimo Dalai Lama. A Lhasa si insediarono due rappresentanti dell’imperatore, gli amban, i quali tuttavia dovevano rispondere al governo del Dalai Lama e non potevano esercitare alcun potere in nome della Cina.
Più tardi, nel XX secolo, il Tibet fu oggetto delle contese sorte in Asia centrale per l’avidità di Russia e Regno Unito. In un primo momento gli inglesi cercarono di siglare accordi commerciali sul Tibet con la Cina e di ridisegnare unilateralmente i confini dei regni himalayani. I tibetani, però, contestarono la validità di quei trattati.
Nel 1904 una spedizione militare britannica cercò di imporre con la forza la supremazia dell’Inghilterra, e il tredicesimo Dalai Lama fu costretto ad abbandonare la capitale occupata. Gli inglesi firmarono con il reggente la Convenzione di Lhasa, che riconosceva loro un’indennità di guerra e diversi vantaggi commerciali. Il trattato costituiva de facto un riconoscimento della sovranità tibetana rispetto allo stato cinese e nel 1906 fu confermato da un documento che gli inglesi fecero firmare ai cinesi, nel quale questi ultimi accettavano espressamente il trattato anglo-tibetano.
Per dare conferma dei vantaggi acquisiti, tuttavia, nel 1907 i britannici aprirono con i cinesi nuove trattative e conclusero il Trattato di Pechino, con cui si impegnavano a non trattare con il Tibet se non passando per l’intermediazione cinese. In patente contraddizione con gli accordi precedenti, il nuovo documento riconosceva esplicitamente il «potere di dominio» (suzerainty) cinese sul Tibet. Trovò così legittimazione una contro-verità storica, fondamento alle successive rivendicazioni cinesi secondo cui «il Tibet fa parte della Cina».
Il Dalai Lama ha deplorato il comportamento contraddittorio degli inglesi, le cui conseguenze si sarebbero rivelate fatali per il suo paese: Suzerainty è un termine vetusto e vago, del tutto inadeguato. Il suo impiego ha indotto in errore generazioni intere di capi di stato occidentali. Esso non teneva conto delle relazioni spirituali tra i Dalai Lama e gli imperatori manciù. Sono molti gli antichi concetti orientali che non è possibile tradurre alla lettera con un semplice termine politico occidentale.2 Di fatto le proteste tibetane successivamente presentate in sede Onu non sono valse a far riconoscere la sovranità tibetana rispetto alla Cina.
Approvo l’appello del Kashag alle Nazioni Unite
Il 7 novembre 1950 il Kashag3 e il governo inoltrarono alle Nazioni Unite un appello che invocava il loro intervento in nostro favore e che ebbe la mia approvazione:
«L’attenzione del mondo è concentrata sulla Corea, dove una forza internazionale sta resistendo all’invasione. Ma le vicende analoghe che stanno accadendo nel remoto Tibet passano inosservate. È nostra convinzione che in nessuna area del mondo possa esservi aggressione che non trovi reazione, o libertà che non trovi protezione. Ci siamo perciò risolti a informare l’Organizzazione delle Nazioni Unite circa i fatti recentemente occorsi nella regione di frontiera del Tibet.
«Come sapete, negli ultimi tempi la questione del Tibet ha conosciuto sviluppi allarmanti. L’iniziativa del conflitto in corso non è stata presa dal Tibet ed è dovuta principalmente alla sfrenata ambizione della Cina.»
La strategia della Repubblica popolare cinese consisté nel far credere al mondo occidentale di essere sinceramente impegnata sulla via per la composizione pacifica della questione tibetana. All’epoca i grandi paesi erano preoccupati per la minaccia di una guerra atomica con epicentro in Corea e l’Unione Sovietica aveva dichiarato il proprio appoggio alla Cina maoista. L’unico stato membro dell’Onu a lanciare un appello contro l’invasione straniera del Tibet fu El Salvador, nel novembre del 1950. Il Tibet cozzò contro il rifiuto del primo ministro dell’Unione indiana, Nehru, ansioso di preservare l’amicizia con il grande vicino del Nord. La Gran Bretagna si mostrò indifferente e gli Stati Uniti scelsero il partito della prudenza, per timore di esacerbare le relazioni con i sovietici.
Intanto, sul terreno degli scontri, nel Tibet orientale l’esercito cinese stava commettendo atrocità. Il governo tibetano inviò a Pechino una delegazione, con l’incarico di trattare. Ma il confronto durò ben poco e il 23 maggio 1951 gli emissari tibetani, di fronte alla minaccia di una marcia forzata su Lhasa, firmarono l’Accordo per la liberazione pacifica del Tibet, noto anche come Accordo in diciassette punti, che disponeva l’annessione del loro paese alla Cina.
Secondo la Commissione internazionale dei giuristi,4 dal punto di vista del diritto internazionale questo documento, firmato sotto la minaccia delle armi, è privo di valore.
La madrepatria: una sfacciata invenzione
Avevo l’abitudine di ascoltare le trasmissioni in lingua tibetana di Radio Pechino. Una sera in cui mi trovavo solo, sentii d’improvviso una voce nasale annunciare che tra i rappresentanti del governo della Repubblica popolare cinese e il cosiddetto «governo regionale» tibetano era stato firmato un Accordo in diciassette punti per la liberazione pacifica del Tibet.
Non credevo alle mie orecchie. Avrei voluto correre a fare appelli al mondo intero, ma ero inchiodato al mio posto. Lo speaker spiegò che «nel secolo scorso minacciose forze imperialiste avevano invaso il Tibet, perpetuandovi ogni sorta di crimine e di provocazione». «Il risultato» aggiunse «è che il popolo tibetano si è trovato immerso nelle tragiche sofferenze della schiavitù.» Ascoltando questa inverosimile congerie di menzogne e luoghi comuni di una strampalata propaganda mi sentii male, fisicamente.
Il peggio, però, doveva ancora venire. La radio annunciò che, in base alla prima clausola dell’accordo, il popolo tibetano sarebbe tornato in seno alla «madrepatria». Che il Tibet si stesse ricongiungendo alla madrepatria era una spudorata invenzione! Il Tibet non è mai appartenuto alla Cina: semmai avrebbe potuto rivendicare vaste porzioni di territorio cinese. I nostri popoli sono differenti per razza e per etnia. Parliamo lingue diverse e il nostro sistema di scrittura non ha nulla in comune con i caratteri cinesi.
La cosa più inquietante era che i delegati tibetani non erano autorizzati a firmare in mio nome. Il loro mandato era soltanto quello di negoziare: avevo tenuto con me i sigilli di stato.
Il Dalai Lama si trova di fronte a un dilemma. Tra gli uomini del suo entourage, suo fratello maggiore, Takster Rinpoche, ha lasciato il monastero di Kumbum e ha preso contatto con le missioni diplomatiche estere a Calcutta; è convinto che gli americani non possano permettere l’espansionismo comunista dei cinesi e che scenderanno in campo a favore del Tibet. Sapendo che gli Stati Uniti sono già impegnati militarmente in Corea, il Dalai Lama dubita che apriranno un secondo fronte in Tibet. Del resto, considerato che la Cina è un paese molto più popoloso, teme che un conflitto armato, anche con il sostegno straniero, finisca per rivelarsi estremamente lungo e sanguinoso. Per cercare di scongiurare uno spargimento di sangue dall’esito incerto, il giovane Dalai Lama decide di incontrare i dirigenti cinesi. Il pensiero che si tratti pur sempre di esseri umani gli fa sperare di riuscire a dialogare e a trovare con loro una via d’intesa.
La personalità di Mao m’impressionò
Nonostante il difficile quadro delle relazioni con la Cina, nel 1954 e nel 1955 mi sono recato in quel paese. Fu una grande occasione per scoprire un mondo diverso. Durante il viaggio, tra l’altro, incrociai molti tibetani delle province del Kham e dell’Amdo. Accumulai così un notevole bagaglio di esperienze e di conoscenze nuov...