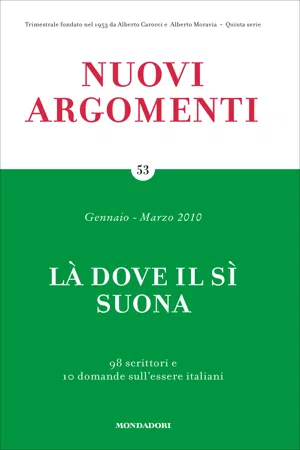![]()
LÀ DOVE IL SÌ SUONA
1. Lei si sente italiano? E, se sì, in che modo?
2. Territorio, tradizione e identità sono concetti utilizzati con frequenza, a destra come a sinistra. È d’accordo con l’uso che se ne fa? E crede di poter parlare, secondo la sua esperienza, di territorio italiano, tradizione italiana e identità italiana?
3. Che significato ha per lei la parola patria?
4. Sente più forte il suo legame con un’identità locale (cittadina, provinciale, regionale) o con l’identità nazionale?
5. Simmetricamente, sente più forte il suo legame con l’identità italiana o con l’identità europea?
6. Ci sono personaggi, periodi o eventi storici che accendono in lei qualcosa di simile a un orgoglio patrio?
7. Uno dei rari momenti in cui il popolo italiano pare ritrovare un’unità di intenti e sentimenti è la visione di eventi sportivi. Si è mai trovato a guardare la gara di un atleta o di una squadra nazionale augurandosi che vincesse solo perché rappresentante l’Italia? E, se sì, per quale motivo?
8. Pensa che il senso di appartenenza linguistica sia un elemento costitutivo del sentimento di identità nazionale?
9. Quale è, se ritiene che esista, il carattere nazionale italiano? Crede che tale carattere sia costitutivo dell’identità o possa mutare nel tempo?
10. Italiani si nasce o si diventa?
[NB Il numero non è indicato quando uno degli autori intervistati ha scelto di non rispondere a una domanda.]
![]()
Eraldo Affinati (Roma 1956)
1-8. Penso, parlo e scrivo in lingua italiana. Come ci hanno insegnato i grandi maestri del Novecento, un pensiero è verbale, oppure non è.
2. Credo che di questi concetti si faccia quotidiano scempio, a destra come a sinistra. L’Italia dovrebbe essere una casa comune sotto il cui tetto uomini e donne del Belpaese e d’altri mondi possano imparare a convivere, non illudendosi che ciò avvenga senza tensioni, nel rispetto delle reciproche identità, tanto più forti quanto più capaci di mettersi in gioco, evitando di chiudersi a riccio in sterili o isterici arroccamenti.
3. Equivale a radice: appena tocchi una nervatura, vibra tutta la pianta. Quindi la patria non è soltanto nostra, ma appartiene a tutti quelli che decidono di riconoscersi in lei.
4. La ritengo una distinzione sostanzialmente trascurabile.
5. Senz’altro con quella italiana.
6. Mio nonno, insieme ad altri nove cittadini italiani, venne fucilato dai nazisti il 26 luglio 1944 a Pievequinta, vicino a Forlì. Mia madre, pochi giorni dopo, fuggì da un treno che la stava conducendo in Germania. Quando penso a questi eventi, non sento tanto un orgoglio patrio, ma un sentimento più complesso: ho l’impressione di essere, al tempo stesso, figlio e orfano di quell’Italia. Come se non fossimo riusciti a mantenere le grandi promesse formulate, con tutti i crismi costituzionali, nell’immediato secondo dopoguerra. Però, da insegnante, non perdo la speranza, essendo convinto che nessuna generazione sia migliore o peggiore di un’altra, ma ognuna ricominci da capo.
7. Certo che mi è capitato. Da bambino ho tifato per Nino Benvenuti al Madison Square Garden. Da ragazzo ho urlato quando Paolo Rossi segnò contro il Brasile ai Mondiali di calcio. Da adulto ho festeggiato la vittoria di Stefano Baldini nella maratona di Atene… Ma non ho mai pensato che queste emozioni mi rendessero più italiano.
9. Niccolò Machiavelli, con indimenticabile disincanto e suprema sprezzatura, illustrò tutta la forza e la fragilità del nostro individualismo. Non credo che questo carattere sia immutabile. Al contrario, ritengo che possa cambiare. Ma con tempi lunghi.
10. Mohamed, Ivan e Hafiz, miei scolari, mi dimostrano ogni giorno che italiani si diventa. E ciò accade, nonostante le lungaggini burocratiche, in tempi brevissimi.
Antonella Anedda (Roma 1958)
1. Mi chiamo Anedda-Angioy sono sarda da generazioni continuamente imparentate tra loro. Unica eccezione una nonna di origine corsa Serra e una marrana: Campus. No, non mi sento esattamente italiana, ma vedo le ferite dell’Italia dove sono nata e ne soffro.
2. È una domanda a cui trovo difficile rispondere. Parlare di identità può essere pericoloso e ho qualche dubbio sulla parola. Vorrei più dire alterità, condivisione di uno spazio, terre.
3. Qui con una certa sorpresa mi scatta qualcosa, una commozione infantile, emotiva e so anche perché. Collego questa parola ai russi che in Guerra e pace resistono a Napoleone con Kutuzov, o al discorso di Churchill, o alla serie televisiva degli anni ’60 di Mrs. Miniver. Ma è appunto una risposta emotiva. In realtà penso come Joyce che la patria sia una di quelle parole che ci fanno tanto infelici. Dietro ci sono in agguato guerre, sangue, sopraffazione. No meglio dire paese, country ma poi ricomincio a pensare ai Minivers.
4. Regionale, isolana, però la Sardegna stava per diventare inglese. Nelson la voleva comprare dai Savoia e si era trovato molto bene tra i maddalenini.
5. Mi è capitato di sentirmi più a casa in Spagna che in Italia, forse perché possiamo tenere il cappello davanti al re. Scherzo però davvero dipende e mi è capitato di tornare da alcuni paesi europei e, con tutti i difetti dell’Italia, dire: che paese meraviglioso, che luce, davvero basterebbe poco.
6. Il Settecento di Giovanni Maria Angioy e la sua utopia il novecento di Antonio Gramsci e di Emilio Lussu. Il lavoro di Maria Lai che unisce con i fili due paesi nemici.
7. Solo nelle partite di rugby. Per il resto tifo Liverpool.
8. Sì ma in modo duttile, permeabile, accogliendo altri accenti, ospitando anche ciò che è estraneo.
9. Penso che sia augurabile che possa cambiare nel tempo. Sapendo cosa succede quando i cognomi si ripetono, credo che mescolarsi, cambiare sia un bene.
10. Molti stranieri che vengono in Italia e spesso restano, diventeranno italiani e noi un po’ stranieri.
Giuseppe Antonelli (Arezzo 1970)
1. Io sono innegabilmente italiano. Lo sono – direi quasi mio malgrado – nell’aspetto, nell’abbigliamento, nelle movenze, perfino nei tratti somatici. Me ne accorsi la prima volta che a sedici anni andai da solo all’estero: ovviamente in Inghilterra, come tutti gli italiani. La gente (coetanei e adulti, senza distinzioni) capiva che ero italiano molto prima che aprissi bocca. Chi diceva perché eravamo vestiti meglio, chi per il taglio di capelli alla moda, chi per il gesticolare (e, dopo aver aperto bocca, per il tono di voce). Non riuscivo a capire cosa ci fosse di così strano in quel modo di essere: quella era la mia acqua. («Ci sono due giovani pesci che nuotano e a un certo punto incontrano un pesce anziano che va nella direzione opposta, fa un cenno di aiuto e dice: “Salve, ragazzi. Com’è l’acqua?”. I due pesci giovani nuotano un altro po’, poi uno guarda l’altro e fa: “Che cavolo è l’acqua?”»: Foster Wallace docet). Ebbene, questa è la nostra acqua – i vestiti griffati, il taglio alla moda, il tono urlato, le risate sguaiate, il conformismo assoluto – il conflitto d’interessi, i furbetti del quartierino, la monnezza, i finanziamenti alle scuole private – onorevole eccellenza cavaliere senatore nobildonna eminenza monsignore – questa è la nostra acqua (e quando i media internazionali lo dicono, da noi si fa appello al patriottismo). Poi, tornando in Inghilterra due anni dopo, me ne sono accorto anch’io che era facile riconoscere gli italiani: avevano tutti lo zaino Invicta.
2. Territorio, tradizione e identità sono tutti concetti che rimandano a un passato più o meno remoto: ieri ci si richiamava all’impero romano, oggi alla lega contro il Barbarossa. A seconda dell’estensione del territorio, possono essere usati pro o contro l’unità nazionale; ma sono sempre ispirati a un’idea di conservazione, se non di restaurazione. E infatti fino a non molti anni fa questi concetti erano considerati di destra: erano idee che facevano parte di una certa ideologia, intesa come visione complessiva del mondo. Oggi che le ideologie si danno per morte, questi stessi concetti sono presentati come valori condivisi (o da condividere). Un’ulteriore prova del fatto che – non solo in Italia, per carità – il pensiero dominante oggi è di destra. Della nuova destra è anche la tendenza a imporre le proprie idee come super partes (o bipartisan che dir si voglia), stagliandole su quel minaccioso orizzonte a cui Noam Chomsky dà il nome di «TINA» (There Is No Alternative).
3. A dispetto delle recenti fortune, patria per me era e resta una parola di destra. (Come l’inno suonato a ogni occasione e soprattutto come l’alzarsi in piedi durante l’inno, magari mettendo una mano sul cuore). Nel 2005, lo slogan scelto da Alleanza nazionale per celebrare il decennale del partito (nato dalle ceneri del neofascista Movimento Sociale Italiano) lo diceva chiaramente: «Eravamo in pochi a chiamare Patria l’Italia. Oggi siamo la maggioranza».
4. Forse perché sono cresciuto in una grande città come Roma, forse perché a casa mia non s’è mai parlato romanesco, non s’è mai cucinato romanesco, non s’è mai tifato per la Roma o per la Lazio (non si è mai tifato per il calcio, in effetti), non s’è mai andati a sentire il papa, né (colpevolmente) a visitare musei e monumenti, e non s’è mai detto né Roma capoccia né Roma caput mundi, forse per tutto questo non provo alcun sentimento di appartenenza locale. Influenzato da altri immaginari e da altri conformismi, se sento parlare di territorio non penso al luogo dove vivo o sono nato: penso ai prodotti Dop, ai vitigni autoctoni, all’abbinamento per terroir.
5. Non credo che esista un’identità europea. C’è una moneta comune, è vero (non a tutti, peraltro: basti il caso clamoroso della Gran Bretagna), ma non c’è in comune un elemento essenziale come la lingua (a meno che non si voglia pensare, appunto, all’inglese). Per rendersene conto basta guardare la bandiera: ha solo le stelle, ma nelle bandiere quelle che contano sono le strisce.
6. Nel Rinascimento l’Italia esportava cultura. A testimoniarlo ci sono ancora, nelle lingue di tutto l’occidente, tante parole d’origine italiana. Tra Quattro e Cinquecento si diffondono – solo per limitarsi a qualche esempio – parole relative alla guerra (soldato), al vestire (cappuccio), alla moda (profumo), alla cucina (maccheroni), ma anche alla letteratura (sonetto) e alle arti figurative (facciata, piedistallo, balcone). Pur divisa politicamente, l’Italia godeva di un prestigio culturale che nei secoli successivi avremmo potuto solo rimpiangere. (L’italiano era, tra l’altro, una delle lingue centrali della diplomazia; oggi stenta a mantenere un suo spazio anche negli organismi comunitari).
7. Una volta all’anno, da quando quindici anni fa me ne sono andato di casa, io e mio padre passiamo un giorno noi due soli, e il giorno è quello dei Mondiali di ciclismo. Quand’ero piccolo lui mi ha insegnato a leggere la gara, a capire le strategie di squadra, le tattiche vincenti, a guardare i primi piani per vedere chi era in forma e chi no. Guardavo le maglie azzurre, e quella era l’Italia. C’erano i gregari, le punte, i capitani (le classi sociali); i passisti, gli scalatori, i velocisti (le diverse specializzazioni); i generosi e gli opportunisti (i caratteri individuali). Sembrava la Repubblica di Platone o l’apologo di Menenio Agrippa: se ognuno faceva al meglio il suo dovere, rispettando limiti e mansioni del proprio ruolo, allora l’Italia vinceva. Quando ero piccolo io facevo il tifo per Moser, ma quando Saronni vinse il Mondiale staccando tutti negli ultimi cinquecento metri di salita, io urlavo come un pazzo e avevo il cuore a duemila, perché aveva la maglia azzurra.
8. La lingua è stato ed è il principale elemento di coesione nazionale. Anteporre i dialetti alla lingua comune significa vanificare il faticoso processo di integrazione avvenuto dopo l’Unità, con l’intento antistorico di rimettere indietro il calendario. Chi propugna il ritorno al dialetto per legge (nei programmi scolastici, nei cartelli stradali, nelle trasmissioni radiotelevisive) è un passatista velleitario. È un po’ come chi esalta la bicicletta perché è più ecologica, ma si dimentica che senza macchina, treno, aereo per andare da una città all’altra ci vorrebbero giorni – non ore – di viaggio. Ecco, potremmo dire che il dialetto è come la bici: va bene per chi si muove in spazi ristretti. Senza contare che la famosa morte dei dialetti è un mito falso almeno quanto la morte delle ideologie. Stando ai dati Istat 2006, l’uso esclusivo del dialetto riguarda ormai meno del 6 per cento degli italiani, ma il 33 per cento della popolazione (un terzo degli italiani sopra i sei anni) quando parla in famiglia o con amici usa sia l’italiano sia il dialetto, mescolandoli liberamente secondo quei meccanismi che i linguisti chiamano code mixing e code switching.
9. A un certo punto del film Tra le nuvole, George Clooney e la sua collega sono all’aeroporto e devono scegliere in quale fila mettersi. Lui: «Mai stare dietro gli anziani, hanno le ossa piene di metallo e sembrano non apprezzare quanto poco tempo gli sia rimasto: eccoli, gli asiatici, sono essenziali, bagaglio leggero e hanno la fissazione per i mocassini, li adoro!». Lei: «Questo è razzismo». Lui: «Sono come mia madre mi affido agli stereotipi, si fa prima!». Un italiano – dando ragione a Clooney – avrebbe probabilmente cercato di passare avanti agli altri o di evitare la fila con una scusa. Sicuramente si sarebbe lamentato che la sua era la fila più lenta.
10. Italiani si nasce (e io appunto lo nacqui), ma anche si diventa: soprattutto negli anni decisivi dell’infanzia e dell’adolescenza. Per questo, a quarant’anni suonati, sto pensando per la prima volta all’idea di lasciare l’Italia. Forse vorrei che mia figlia, nata lo scorso 8 settembre (!), diventasse qualcosa di diverso.
Enrico Arosio (Milano 1957)
1. Sì, mi sento italiano e chiedo comprensione e pazienza.
2. Se la domanda è posta sullo sfondo della dialettica irrisolta tra centralismo e federalismo, nazione e territori, darei una doppia risposta, politica e culturale. La considerazione politica è che no, non mi piace il frequente uso ideologico del concetto di identità. Mi dispiace l’abuso dell’identità italiana rispetto all’immigrato perché spesso gli si chiede lealtà senza offrirla, onestà senza praticarla, obbedienza abusandone. E mi dispiace la procedura manipolativa con cui una forza politica, che pure ha avuto il merito di lanciare il tema cruciale del federalismo, ha provato a imporre un artificio identitario come la “Padania”. La “Padania” non esiste, andrebbe scritta tra virgolette alte, è una modesta invenzione lessicale «buona per i gonzi», direbbe il giovane Holden. Padano è, al massimo, un termine geografico, il bacino del Po (potrei dire: un formaggio). L’invenzione politica della “Padania”, accompagnata dalle fasulle pretese di autonomismo o statuto speciale per Regioni come la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ha irretito alcuni milioni di elettori in un nonsenso storico-culturale. E ha imbastardito un tema nobile come il federalismo, che in realtà è molto adatto all’Italia, articolatasi sulla rete dei Comuni sin dal Rinascimento, e che la sinistra, con miopia, ha lasciato in mano alla Lega. In termini culturali, risponderei che il territorio italiano è insieme federale e unitario nella sua impareggiabile ricchezza e diversità. Se dico Dolomiti di Brenta o piana del Salento, Ogliastra o Carso triestino, Cinque Terre o Circeo, colline del Chianti o isola di Stromboli, dico Italie e Italia. Alla fine, se costretto a parlare di identità italiana, prevale in me un elenco infinito di paesaggi modellati dal lavoro dell’uomo nelle più ammirevoli varianti. I tedeschi parlano, non a caso, di “Kulturlandschaft”.
3. Dirsi patrioti nel 2010 non dovrebbe essere un imbarazzo, anche se un’intera generazione, la mia, formatasi negli anni Settanta, ha lungamente confuso il patriottismo con un valore “di destra”, retorico, inattuale. Sul concetto di patria lascerei la parola a Salvatore Satta, nel De profundis, pubblicato nel 1948 ma scritto nel 1944-45. Quando ragiona sulla dissoluzione politica e morale dell’Italia dopo vent’anni di fascismo, e la chiama «la morte della patria»: «Qui giace un’Italia senza virtù, invisa ai propri figli, spregiata allo straniero che ancor la lusinga, e quel che è più triste, indifferente alla miseria nella quale è caduta». Parole di allora, ma in grado di turbarci ancora oggi; tantopiù oggi.
4. A volte sento più forte il legame con Milano e la milanesità che con l’Italia e l’italianità. Per una ragione emotiva, ma non solo, di richiamo delle radici: la mia famiglia, Arosio, è documentata a Milano, a quanto risulta, dal Settecento, e dunque da una decina di generazioni. Nel 1838 la mia ava Giuseppina Arosio sposò Tito Ricordi, l’editore di Verdi. Per me, dunque, Milano è grande città e cultura urbana, mentre la Lombardia, lo dico con affetto, è campagna: nelle giornate limpide d’inverno guardiamo a nord e ci appare il Resegone, la montagna di Lecco che incantava Stendhal, e siamo contenti che stia dove sta. Io stesso, che ho vissuto, per studio e per lavoro, sette anni altrove (a Monaco e Roma), ho fatto ritorno a Milano per farvi nascere i miei due figli. Mi definirei un italiano con una sub-appartenenza molto forte, quella di una borghesia laica milanese e cosmopolita, con i suoi codici etici, civici, il senso di responsabilità e di solidarietà. E qualche buona abitudine: una per tutte, la fedeltà al culto dei migliori marrons glacés d’Europa, prodotti dalla pasticceria Galli in via Victor Hugo.
5. Sono europeista sin da ragazzo, quando studiavo alla Deutsche Schule di Milano. Provengo da una famiglia di poliglotti e sono in grado di lavorare in tedesco, inglese e francese, ho modeste nozioni di spagnolo, olandese e yiddish, il tutto messo a sobbollire in venticinque anni di giornalismo. Mi sono formato, via via, su Heine, Goethe e Kafka, su Parri, Altiero Spinelli, la Parigi dei cubisti e la Repubblica di Weimar, la Vienna di Adolf Loos e la Amsterdam dei mercanti, le architetture di Barcellona e i fiordi di Norvegia, i reportage di Joseph Roth e il Savinio di Sorte dell’Europa, il “Nouvel Observateur” e la “Neue Zürcher Zeitung”. Non saprei dove cominciare, perciò non comincio. Eludo la risposta con una notazione molto personale. Quando studiavo Lettere in Germania, intorno al 1980, ci tenevo moltissimo a farmi notare dai professori quale italiano plurilingue, mi battevo con un certo ardore contro i pregiudizi e giudizi antitaliani, allora molto accesi (dalla mafia alle Brigate Rosse), e dentro di me pensavo che con l’impegno avrei contribuito a correggere, nel mio piccolo, l’immagine del nostro Paese. Questo sentimento, o questa illusione, non mi ha mai abbandonato nei quattro anni all’Università di Monaco, anche se non ne ho mai parlato con nessuno.
6. Orgoglio patrio? Potrei dire: la ...