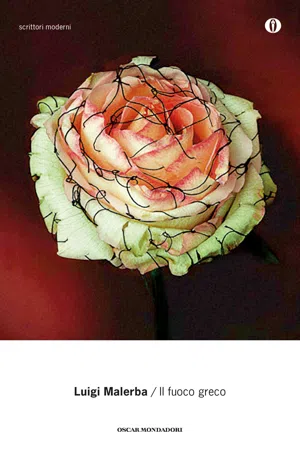
- 252 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il fuoco greco
Informazioni su questo libro
Il segreto dell'arma più potente della flotta bizantina, il fuoco greco, il micidiale strumento di morte che ha permesso ai signori di Costantinopoli di mantenere il controllo del Mediterraneo, è stato rubato. Ma in una corte dominata dagli intrighi e dal delitto chi vuole la verità e chi invece si serve del tradimento per liberarsi dei rivali nella corsa al potere? Un memorabile romanzo storico con il quale Luigi Malerba conferma il suo talento di raffinato narratore di trame e situazioni.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Print ISBN
9788804468462eBook ISBN
97888520545321
Un cruccio che turbò a lungo i sonni dell’Imperatore Costantino VII Porfirogenito e ne tenne occupati molti pensieri durante gli anni che sedette sul Trono di Bisanzio, fu quello di correggere l’acustica della Sala del Triclinio, luogo eletto dei sontuosi banchetti che si tenevano in occasione delle visite di ospiti eminenti. Durante questi banchetti, che in qualche caso avrebbero dovuto rinsaldare con la cordialità della tavola i rapporti promossi dalla diplomazia bizantina, il dialogo risultava ogni volta gravemente compromesso: le voci rimbalzavano contro le pareti e le colonne di marmo per ritornare agli emittenti con echi e risonanze, e si sovrapponevano e confondevano in un turbine di orribili muggiti. Sentendo echeggiare nella sala le proprie voci deformate in suoni grotteschi, come se qualche buffone maligno si fosse nascosto dietro le colonne per fare il verso ai loro discorsi, alcuni ospiti stranieri si erano ammutoliti per tutta la durata del banchetto e avevano interpretato questi disturbi come una beffa architettata con malizia e arroganza. In qualche caso erano ripartiti offesi dalla Capitale bizantina con grave pregiudizio dei rapporti diplomatici.
La Sala del Triclinio, detta anche Crisotriclinio per l’abbondanza degli ori che la decoravano, era la più sontuosa fra tutte le sale dei Palazzi Imperiali e Costantino VII non voleva rinunciare, a causa della cattiva acustica, a stupire i suoi ospiti con il lusso e la ricchezza bizantina la cui fama aveva superato i confini dell’Oriente e dell’Occidente.
La sala era di forma circolare, delimitata all’intorno da alte colonne di marmo di Tessaglia, e le pareti esterne, di forma ottagonale, erano riquadrate di alabastro e rivestite di mosaici che raffiguravano fiori e frutta a festoni, e uccelli fantastici in una fascia alta vicina al soffitto. Il pavimento a disegni geometrici era composto a rombi di cipollino rosso intrecciati a lastre compatte di porfido e di marmo di Aquitania. Il soffitto intarsiato di legni preziosi riproduceva gli stessi motivi geometrici del pavimento. Tutta questa gioia per gli occhi veniva guastata ogni volta da una tormentosa confusione delle voci e dei suoni che impediva anche le esibizioni dei musicanti alla fine dei banchetti.
Gli architetti di Corte avevano ricevuto l’incarico di correggere l’acustica senza toccare i marmi e i mosaici. Chiamato in udienza dall’Imperatore, il Primo Architetto aveva esposto una sua personale teoria dei vuoti: in un vaso ciò che conta e che viene utilizzato non è la materia di cui è composto, che può essere preziosa o vile, ma il vuoto interno. Nello stesso modo l’essenza di un ambiente destinato all’uomo non è costituita dalle pareti, dai pavimenti e dai soffitti, ma dal vuoto che essi delimitano e nel quale l’uomo si muove.
«Si muove e parla» aveva sottolineato l’Imperatore.
Era proprio questo spazio vuoto, aveva spiegato il Primo Architetto, che intendeva modificare, beninteso senza alterare né i marmi né i mosaici, affinché le voci non rimbalzassero dagli angoli di risonanza creando turbamento durante i banchetti imperiali.
La squadra degli operai comandati dall’Architetto trafficò a lungo dentro la grande sala circolare. Vennero collocati fra una colonna e l’altra dei vasi con alberetti di mirto e di cipresso, vennero stesi tappeti tessuti appositamente in modo che la loro forma non turbasse il disegno marmoreo dei pavimenti, vennero applicate doppie tende di seta e di lino alle finestre, senza che tutto questo migliorasse la situazione acustica. Vennero ricoperti i mosaici delle pareti con perfette riproduzioni degli stessi disegni su sottili tavole di legno, ma le voci e i suoni continuarono a confondersi come prima.
L’Imperatore manifestò tutta la sua irritazione facendo rinchiudere il Primo Architetto e i suoi operai in un monastero della Bitinia e chiamò dalla Persia un architetto e un matematico raccomandati dal Patriarca di Costantinopoli che qualche anno prima li aveva incaricati di certi restauri nella cupola di Santa Sofia dalla quale cadevano frammenti di pitture e di mosaici durante le messe cantate. Si era scoperto che il canto e le alte voci delle preghiere facevano vibrare i materiali che, a lungo andare, si scollavano dalla loro sede e precipitavano in testa ai fedeli e agli stessi officianti. Il restauro e i segreti congegni messi in opera dai due persiani per infrangere l’urto delle voci avevano eliminato del tutto l’inconveniente nella Cattedrale.
Dopo un primo esame della grande sala, i due persiani fecero portare via i vasi, smontarono i pannelli di legno applicati sopra i mosaici, tolsero tutte le tende e i tappeti e poi si chiusero dentro la Sala del Triclinio con una piccola cassa di attrezzature e una scala alta quanto le pareti.
Una settimana dopo l’Imperatore venne informato che il lavoro era compiuto. Deluso dal Primo Architetto che gli aveva fatto spendere una fortuna senza ottenere nessun risultato, Costantino volle provare lui stesso l’acustica dell’ambiente. In presenza dei due persiani entrò nella Sala del Triclinio e provò a parlare a voce bassa, poi a voce più alta e infine fece emettere dei gridi da un suo accompagnatore perché non riteneva degno della maestà imperiale mettersi a gridare entro le mura dei Palazzi. Le prove di voce vennero ripetute in vari luoghi del grande ambiente e i risultati furono sempre soddisfacenti: niente echi, niente risonanze.
Costantino e gli uomini del suo seguito osservarono attentamente la sala e in nessun luogo notarono dei cambiamenti. Si domandarono se il risultato fosse opera di magia ma i due persiani, che avevano intuito il sospetto, fecero notare all’Imperatore dei sottilissimi fili di seta tesi come una invisibile ragnatela fra una colonna e l’altra e fra le colonne e il soffitto secondo criteri, dissero, calcolati in base alla teoria pitagorica dei suoni e dei numeri applicata con profitto già in varie occasioni.
I due persiani vennero compensati con quattrocento nomismi d’oro come era stato pattuito e in più ebbero in dono due medaglie d’oro cesellate dall’Orafo di Corte e raffiguranti da una parte l’immagine del Basilicos e dall’altra una Croce greca con le due date della Invenzione e della Esaltazione.
Prima di ripartire per il loro paese l’architetto e il matematico, soddisfatti del dono ricevuto, dissero all’Imperatore che l’acustica della sala si poteva perfezionare ancora con il volo di qualche farfalla, anche una sola ma non più di dodici. Costantino diede disposizioni perché si provvedesse anche a questo durante i banchetti che si svolgevano in primavera e in estate.
Questo avveniva nell’anno del Signore 957, due anni prima della morte di Costantino VII. Da allora la Sala del Triclinio venne gloriosamente esibita agli ospiti d’onore senza che i vecchi inconvenienti disturbassero la loro conversazione e confondessero le musiche e i canti che alla fine dei banchetti coronavano l’ospitalità imperiale.
2
Era una sera gelida di febbraio dell’anno 962 e quando gli ospiti presero posto ai tavoli della Sala del Triclinio trovarono che la superficie dell’acqua versata dai coppieri nei calici d’argento era coperta da un leggero strato di ghiaccio. Nonostante il freddo, il banchetto aveva avuto inizio con l’invocazione solenne dell’Araldo Vocale il quale aveva intonato a gran voce: «In gaudio prandite, domine!» e tutti si erano chinati sui cibi caldi e sul vino per ottenere ristoro ai loro corpi infreddoliti.
La tavola del Basileus, alla quale sedeva in questa occasione la Reggente Teofane, era collocata all’estremità della sala di fronte all’ingresso. Di forma rettangolare, la tavola di marmo intarsiato era posta su un rialzo di legno tutto rivestito di porpora e riscaldato da un tubo di aria calda che arrivava direttamente dalle cucine. Nell’emiciclo di fronte le tavole degli invitati erano disposte in modo che questi non volgessero le spalle alla Reggente.
Su grandi carrelli spinti da giovinetti che rabbrividivano dentro le loro strette e bianche tuniche di seta, arrivavano i cibi che si fermavano vicino alla tavola occupata dalla Reggente e dagli ospiti d’onore, e poi facevano il giro delle altre tavole seguendo un percorso rigidamente stabilito dal Prefetto della Tavola del Basileus che aveva fissato secondo l’etichetta anche i posti degli invitati.
Il posto d’onore alla destra della Reggente Teofane era stato assegnato all’Ambasciatore dell’Emiro di Mosul e Aleppo, il temibile Saif ad-Dawla, con il quale si tentava una pacificazione dopo anni di guerre che avevano procurato vasti danni ai due contendenti e dissanguate le finanze dell’Impero Bizantino. Alla sinistra di Teofane sedeva l’eunuco Giovanni Bringas che ufficialmente ricopriva le cariche di Magister Officiorum e di Parakimomeno, vale a dire “colui che dorme accanto all’Imperatore”, in questo caso alla Reggente, ma che in realtà era l’artefice segreto della politica imperiale sia per le decisioni interne che per i rapporti con gli Stati esteri. Gli altri invitati seduti al tavolo della Reggente appartenevano tutti all’Alta Burocrazia: Leone Foca, nominato da poco Kuropalata dopo che il fratello Niceforo Foca aveva strappato all’Emiro Saif ad-Dawla le città di Germanicea e di Aleppo nella valle dell’Eufrate, e l’Eparco Giorgio Mesarite, massimo Magistrato dell’Impero. Agli altri tavoli sedevano, insieme alle Dame di Corte e ai rappresentanti degli Ordini Burocratici, un Maestro di Retorica, un Grammatico, un Teologo, un Matematico, un Poeta di Corte e alcuni Monaci sapienti. Il fior fiore della cultura bizantina era stato reclutato per questo pranzo che, seguendo una tradizione instaurata da Costantino VII, veniva dedicato una volta ogni mese a un filosofo, a un poeta o a uno storico della Antichità Classica. Quella sera era stato scelto come argomento della conversazione il filosofo greco Aristotele.
Mentre si mangiavano arrosti di capretto, salsicce di oca farcite di aglio e cipolla, prosciutti di cinghiale e petti di pavone, si discuteva se quella di Aristotele fosse vera filosofia, se la vera filosofia coincida sempre con la vera religione come fonte di verità e, di conseguenza, se un vero cristiano potesse accettare le proposizioni filosofiche dell’Ateniese. A quel tempo Aristotele non era stato ancora assimilato alla cultura cristiana e la conversazione era arrivata a un punto delicato e controverso.
«Se anche vogliamo riconoscere nel Motore Immobile del filosofo ateniese una immagine di Dio, come pretendono in molti,» disse il Teologo di Corte «non si capisce perché Dio debba essere immobile. Il principio della divinità, al contrario, è mobile per eccellenza e i suoi attributi dovrebbero essere semmai la fluidità aerea, l’infinità espansiva, la velocità.»
Sulla velocità di Dio intervenne il Matematico.
«La velocità può essere un attributo divino solo se è assoluta, e su questo credo che non si possa dubitare. Ma la velocità assoluta significa che il Soggetto è già arrivato nel momento stesso in cui è partito.»
Il Kuropalata Leone Foca si irrigidì per un istante, depose nel piatto la salsiccia d’oca che stava per addentare, e intervenne nella discussione sulla velocità di Dio.
«La questione è dura da risolvere perché l’affermazione dell’illustre Matematico smentirebbe il principio di non-contraddizione già formulato da Anassagora e assunto in seguito proprio da Aristotele come uno dei cardini della logica.»
«Aristotele è un filosofo pagano» rispose subito il Teologo «e perciò, quando parliamo degli attributi del Dio dei Cristiani, possiamo tranquillamente contraddire la sua logica. Converrà piuttosto tener conto di Proclo che nella sua Institutio theologica afferma che l’esistenza del Primo Motore Immobile rende necessaria anche l’esistenza di ciò che si muove, vale a dire di ciò che è mosso dal Primo Motore. Infatti ogni Ente o è immobile, o mobile di per sé, o mobile per altrui impulso. Da ciò è manifesto che ad imprimere impulsi al moto può essere soltanto Colui che Aristotele chiama il Motore Immobile. Il vostro discorso non tiene conto che l’Immobile muove qualcosa che gli è estraneo, ma non può avere il limite della immobilità in quanto comprende in se stesso anche gli altri Enti e perciò va catalogato come semovente. In questo caso il movimento è pura espansione che non comporta luogo di partenza e luogo di arrivo e perciò la velocità, che ho citato come attributo divino, si esercita nel corpo stesso dell’Ente Supremo impropriamente identificato nel Motore Immobile di Aristotele. Se invece vogliamo condizionare questo attributo della velocità ad altri attributi in una sequenza necessariamente infinita, allora stiamo discutendo della scienza del nulla, come dice Proclo, e meglio sarebbe tacere come ci impone la fede.»
Leone Foca volle ancora introdursi nella conversazione temendo che la serata si riducesse a un dialogo fra il Matematico e il Teologo, i quali si fronteggiavano con l’apparente compostezza di chi sa di poter contare su una grande riserva di argomentazioni e sull’attenzione dei commensali.
«Non mi sembra elegante» disse Leone Foca «introdurre la fede in argomenti che stavamo trattando secondo i principi della logica.»
«Ho detto soltanto che la fede in qualche caso impone di tacere, soprattutto quando si pronunciano commenti come il vostro che non sono improntati né alla logica né all’eleganza.»
Leone Foca rimase offeso e frastornato dalla risposta del Teologo di Corte, e non ebbe il tempo di riordinare le idee e di rispondere perché il Matematico riprese il dialogo con il Teologo deponendo il coltello con il quale stava tagliando un abbondante pezzo di capretto arrostito.
«La nozione di spazio, secondo voi, è ammessa nei Cieli popolati dagli Enti immobili, mobili o semoventi?»
Alla domanda, carica di pungente ironia, rispose il Teologo con la sua flemma abituale.
«Mi pare che il centro del nostro discorso fosse l’Onnipotente o, se preferite, il Motore Immobile e non lo spazio riservato agli Enti che da esso derivano e da esso dipendono.»
«Intendevo parlare proprio del Supremo fra tutti gli Enti» disse il Matematico «o, sempre per usare il linguaggio del filosofo ateniese, del Motore Immobile. Se volete posso formulare di nuovo la domanda in questo modo: la nozione di spazio è ammessa dall’Onnipotente? E, insieme alla nozione di spazio, è ammessa la geometria con le sue forme, per esempio la sfera che fra tutte le forme è la più perfetta?»
«La nozione di spazio è ammessa necessariamente dall’Onnipotente per quanto riguarda gli Enti che da esso derivano e da cui sono mossi, ma per quanto riguarda lo stesso Ente Supremo diciamo che comprende tutti gli altri spazi e le relative geometrie in uno spazio infinito.»
«Uno spazio infinito, secondo la geometria di Euclide, è composto di un numero infinito di punti, ma pur sempre di punti, distinti l’uno dall’altro. Mi seguite?»
«Ho capito che cosa volete intendere: che da un punto all’altro si possono stabilire dei percorsi e che questi si possono coprire più o meno velocemente. Ma io vi rispondo che l’Ente Supremo già occupa tutti questi punti e quindi non è dato stabilire dei percorsi e tanto meno delle velocità relative.»
Nella Sala del Triclinio l’aria gelida si era fatta di ghiaccio e i commensali avevano smesso perfino di masticare per non perdere nemmeno una parola della contesa tra il Teologo e il Matematico.
«I filosofi cristiani parlano spesso della sfera celeste. Nemmeno nel caso della sfera è dato stabilire dei punti differenziati? Se si ammette la forma di sfera bisogna ammettere anche uno spazio delimitato da una superficie. Siete d’accordo almeno su questo?»
«Certamente,» rispose il Teologo «secondo la geometria di Euclide.»
«Esiste anche una geometria celeste diversa da quella euclidea? Forse siete sul punto di dirmi che secondo questa nuova scienza delle forme esiste una sfera infinita che si identifica con l’Ente Supremo. Non credete che le forme geometriche, compresa la sfera, siano proprio un modo di combattere l’idea di infinito, questo assoluto male metafisico che opera nel cosmo seminandovi il caos?»
«Se dite che questa idea semina il caos nella mente umana sono d’accordo con voi, ma se parlate del cosmo devo pensare che considerate Dio un assoluto male metafisico, un seminatore di caos.»
«Ho parlato di idea e una idea può seminare il caos solo nel cosmo immaginato dalla mente umana. Mi sembrava che non ci fosse possibilità di equivoco, ma ho l’impressione che con i vostri sofismi maliziosi vogliate sfuggire alla domanda se può esistere o no una sfera infinita.»
«Vi ho già risposto.»
«Io non intendo la sfera di cui parla Euclide, ma quella di cui parlano i nostri filosofi cristiani.»
«La sfera celeste è una elegante metafora e voi sapete che le metafore non occupano spazio né hanno una superficie e perciò male si adattano ad essere misurate e rinchiuse in una forma geometrica.»
Il Matematic...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Il fuoco greco
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- Copyright