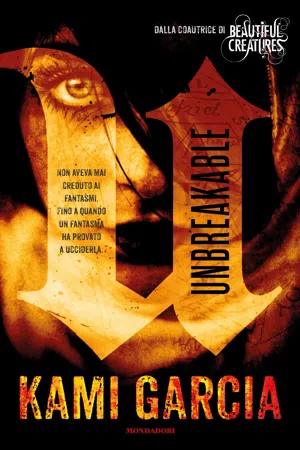![]()
Mentre affondavo i piedi scalzi nella terra bagnata, mi sforzai di non pensare ai cadaveri che erano sepolti sotto di me. Ero già passata per quel minuscolo cimitero un paio di volte, ma mai di notte, e sempre restando alla larga dai cancelli di ferro arrugginiti.
In quel momento avrei dato qualsiasi cosa pur di non trovarmi lì.
Al chiaro di luna la striscia di prato curato, nascosto dietro le file di lapidi segnate dalle intemperie, si mostrava per quello che era realmente: il coperchio erboso di un’enorme bara.
Un ramo si spezzò all’improvviso e io mi voltai di scatto.
«Elvis?» Mi guardai intorno, cercando con lo sguardo la coda a righe bianche e grigie del mio gatto.
Elvis non fuggiva mai di casa, anzi di solito era ben contento di infilarsi tra le mie gambe ogni volta che aprivo la porta. Almeno fino a quella notte, quando era schizzato via talmente in fretta che non avevo fatto neanche in tempo a prendere le scarpe e lo avevo rincorso per otto isolati, per poi ritrovarmi lì.
Sentii delle voci soffocate tra gli alberi e mi irrigidii.
Dall’altra parte del cancello, una ragazza con indosso una tuta blu e grigia della Georgetown University passò sotto la luce fioca di un lampione. I suoi amici la raggiunsero, ridacchiando e incespicando sul marciapiede. Una volta arrivati davanti a uno degli edifici universitari, scomparvero all’interno.
Ogni tanto mi scordavo che il cimitero si trovava nel bel mezzo di un campus. A mano a mano che mi addentravo tra le file irregolari di lapidi, il bagliore dei lampioni svaniva dietro gli alberi e le nuvole passeggere facevano sprofondare di tanto in tanto il cimitero nel buio. Ignorai le vocine nella mia testa che mi urlavano di tornare dritta a casa.
Con la coda dell’occhio, scorsi qualcosa che si muoveva: un lampo bianco.
Lanciai un’occhiata tra le lapidi, ora immerse nell’oscurità più totale.
“Andiamo, Elvis. Dove sei?”
Niente mi spaventava più del buio. Mi piaceva vedere cosa avevo davanti, perché nelle tenebre poteva nascondersi di tutto.
“Pensa a qualcos’altro.”
Il ricordo mi colse alla sprovvista, prima che potessi bloccarlo…
Il volto di mia madre sopra di me mentre mi sveglio a fatica. L’ondata di panico che le attraversa lo sguardo mentre si preme il dito sulle labbra, facendomi cenno di restare in silenzio. Il pavimento freddo sotto i piedi mentre ci dirigiamo verso l’armadio e lei che sposta i vestiti da una parte.
«C’è qualcuno in casa» mi sussurra, scostando un’asse di legno dalla parete sul fondo del mobile, dietro la quale c’è una piccola apertura. «Resta qui finché non torno a prenderti. E non fare rumore.»
Mi rannicchio lì dentro, mentre lei risistema l’asse al suo posto. Non avevo mai sperimentato il buio assoluto prima di allora. Fisso un punto a pochi centimetri da me, dove ho la mano posata sul legno. Ma non la vedo.
Chiudo gli occhi nonostante l’oscurità. Si sentono dei rumori – le scale che scricchiolano, i mobili che grattano contro il pavimento, un vociare sommesso – e un pensiero continua a rimbombarmi nella testa e non mi dà tregua.
E se non tornasse più?
Troppo spaventata per vedere se posso uscire da lì, continuo a tenere la mano appoggiata sul legno. Ascolto il mio respiro irregolare, certa che chiunque altro sia in casa possa sentirlo.
Alla fine, l’asse si sposta sotto il mio palmo e uno spiraglio di luce inonda il nascondiglio in cui mi ero accovacciata. Mia madre mi stringe tra le braccia e mi assicura che gli intrusi se ne sono andati. Mentre mi tira fuori dall’armadio, sento soltanto che il battito accelerato del mio cuore e non riesco a pensare a nient’altro che al peso opprimente dell’oscurità.
Avevo appena cinque anni quando successe, ma ricordavo ancora alla perfezione ogni singolo istante passato raggomitolata in quel bugigattolo. Mi bastò il solo pensiero per sentirmi soffocare. Una parte di me voleva tornare a casa, con o senza il mio gatto.
«Elvis, vieni fuori!»
Qualcosa si mosse tra le lapidi scheggiate che avevo davanti.
«Elvis?»
Da dietro una croce di pietra spuntò una sagoma.
Io sussultai e mi lasciai sfuggire un gemito di paura. «Mi scusi» mormorai con voce tremante. «Sto cercando il mio gatto.»
La figura estranea non disse una parola.
I rumori si intensificarono fino a stordirmi: il crepitare dei rami che si spezzavano, il frusciare assordante delle foglie, il mio battito accelerato. Mi venne in mente la miriade di casi irrisolti dei telefilm polizieschi che guardavo con mia madre, e che iniziavano esattamente così: una ragazza si ritrova da sola in un posto in cui non dovrebbe essere e fissa il tizio che sta per aggredirla.
Indietreggiai e il fango denso mi avvolse le caviglie come una mano che cercava di ancorarmi al suolo.
“Ti prego, non farmi del male.”
Il vento si insinuò tra le lapidi del cimitero, sollevò le lunghe ciocche di capelli aggrovigliati sulle spalle di quella figura e scostò la stoffa leggera del vestito bianco dalle gambe.
“Le gambe.”
Provai un sollievo indescrivibile. «Per caso hai visto passare un gatto siamese bianco e grigio? Se lo trovo, lo faccio secco.»
Silenzio.
Il chiaro di luna le illuminò l’abito e mi accorsi che in realtà non si trattava di un vestito. Era una camicia da notte. Chi mai se ne sarebbe andato a zonzo in un cimitero in camicia da notte?
“Una squilibrata.
Oppure una sonnambula.”
In teoria i sonnambuli non andrebbero svegliati, ma non potevo nemmeno lasciarla da sola in quel posto di notte.
«Ehi! Mi senti?»
La ragazza non si mosse, continuava a fissarmi come se avesse potuto vedere i miei lineamenti nonostante il buio. Un senso di vuoto mi attanagliò lo stomaco. Avrei voluto guardare qualcos’altro… qualsiasi altra cosa che non fossero i suoi occhi inquietanti.
Rivolsi lo sguardo verso la base della croce.
La ragazza era scalza come me, ma sembrava che i suoi piedi non toccassero il suolo.
Battei gli occhi, incapace di prendere in considerazione quella possibilità. Doveva essere un effetto ottico dovuto al chiaroscuro della luna. Osservai i miei piedi, incrostati di fango, poi di nuovo i suoi.
Erano pallidi e immacolati.
Una scia di pelliccia bianca le guizzò davanti e si fiondò verso di me.
Elvis.
Lo afferrai prima che potesse sfuggirmi di nuovo. Lui mi soffiò contro, graffiandomi e dimenandosi come un matto, finché non lo lasciai andare. Il cuore mi batteva all’impazzata, ed Elvis sfrecciò via in mezzo all’erba e si infilò sotto il cancello.
Guardai di nuovo la croce di pietra.
La ragazza era scomparsa e nel punto in cui l’avevo vista un attimo prima la superficie di fango era liscia e intatta.
Il sangue dei graffi mi colava lungo il braccio, mentre attraversavo il cimitero e cercavo di scacciare dalla testa l’immagine della ragazzina con la camicia da notte bianca.
Ricordai a me stessa che non credevo nei fantasmi.
![]()
Quando tornai con passo incerto sul marciapiede illuminato, di Elvis non c’era più traccia. Un tizio con uno zainetto sulla spalla mi passò vicino e mi lanciò un’occhiata stranita quando si accorse che avevo i piedi scalzi ed ero coperta di fango fino alle caviglie. Probabilmente immaginava che facessi parte di una qualche confraternita.
Le mie mani smisero di tremare solo quando raggiunsi O Street, dove le ombre del campus svanirono per lasciare spazio alle luci del traffico di Washington D.C. Dopo una serata come quella, persino i turisti che si mettevano in posa per fare le foto in cima alla famosa scalinata del film L’esorcista erano, in un certo senso, rassicuranti.
All’improvviso il cimitero mi sembrò lontano anni luce, e cominciai ad analizzare l’accaduto.
La ragazza che avevo visto tra le lapidi non era diafana o evanescente come i fantasmi di certi film. Mi era sembrata una ragazza normale.
“A parte il fatto che fluttuava in aria.”
O no?
Forse era stato il chiaro di luna a creare quell’illusione ottica. E magari i suoi piedi non erano infangati perché il terreno era asciutto, nel punto in cui si trovava lei. Quando raggiunsi il mio isolato, dove una miriade di casette a schiera erano appiccicate l’una all’altra, mi ero ormai convinta del fatto che ci fossero decine di spiegazioni plausibili.
Elvis se ne stava spaparanzato sui gradini d’ingresso con aria docile e annoiata. Presi in considerazione l’idea di lasciarlo lì fuori per dargli una bella lezione, ma volevo troppo bene a quello stupido gatto.
Mi ricordavo ancora il giorno in cui mia madre me l’aveva comprato. Ero tornata a casa in lacrime, perché a scuola avevamo preparato i pensierini per la Festa del papà e io ero l’unica bambina senza un padre. Il mio se n’era andato quando avevo cinque anni e non era più tornato. Mia madre mi aveva asciugato le lacrime e aveva detto: «Scommetto che sei anche l’unica bimba della tua classe che oggi riceverà un gattino.»
Elvis aveva trasformato uno dei giorni peggiori della mia vita in uno dei più belli.
Aprii la porta d’ingresso e lui si fiondò dentro come una scheggia. «Sei fortunato che ti lasci entrare.»
La casa sapeva di pomodori e aglio, e la voce di mia madre riecheggiò lungo il corridoio. «Questo weekend sono impegnata. Anche il prossimo. Mi dispiace, ma devo scappare. Credo che mia figlia sia appena rientrata. Kennedy?»
«Sì, mamma.»
«Eri da Elle? Stavo per chiamarti.»
Varcai la soglia della cucina e lei riagganciò il telefono. «Non esattamente.»
Mi lanciò una rapida occhiata e il mestolo di legno le cadde a terra, macchiando di sugo di pomodoro le piastrelle bianche del pavimento. «Cosa ti è successo?»
«Sto bene. Elvis è scappato via e ci è voluta una vita per riprenderlo.»
Lei si precipitò a esaminare i segni lasciati dagli artigli. «È stato Elvis a farti questo? Non ha mai graffiato nessuno in vita sua.»
«Credo che si sia imbestialito quando l’ho afferrato.»
Il suo sguardo attonito si spostò sui miei piedi incrostati di fango. «Dove sei stata?»
Mi preparai a ricevere la solita ramanzina che mia madre m’impartiva tutte le volte che uscivo la sera: porta sempre con te il cellulare, non andare in giro da sola, resta in zone ben illuminate, e il suo preferito in assoluto, prima urla e poi fai domande. Quella sera av...