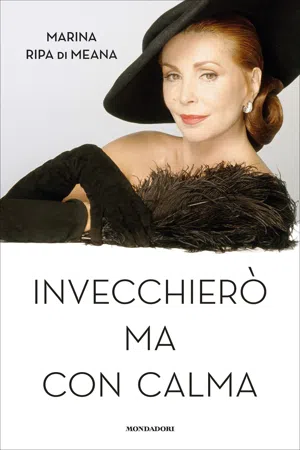![]()
Sono entrata in casa e ho capito subito che era cambiato tutto.
Andrea ripeteva: «C’è più luce, così si potrà finalmente leggere anche senza accendere la lampadina». E io, con un filo di voce: «Ma che dici, figlio mio!».
In cima alla piccola rampa di gradini che porta in giardino, ho dovuto farmi schermo con una mano, e socchiudere gli occhi.
Il padrone di casa aveva deciso di cedere alle richieste dei condomini e di procedere al “taglio del bosco”. Non solo potare qua e là, diradare e distanziare i rizoma a terra dei bambù, medicare le palme malate a causa del punteruolo rosso, tagliare le spire da grande rettile del glicine con il suo corpo ligneo e sinuoso che sale e sparisce oltre i muretti dell’albergo adiacente, liberare dall’ombra le foglie lucide, grasse, delle magnolie e i fiori gialli di mimosa di certe acacie, ridurre il troppo, lo sfuggito al controllo, dare luce alle ortensie che preparano la fioritura per aprile. No. Tutto quello che era stato fino a quel giorno, lunedì 28 febbraio 2011, il più segreto giardino di ombre e silenzi del quartiere di Prati di Castello a Roma, via Ovidio 26 e 28, era sparito.
Dall’alto del cestello giallo di una gru con motosega, una botanica ed esperta di essenze ornamentali, piante, arbusti e fiori, che ha il suo vivaio a Vallerano di Roma, con gesti energici e precisi dava istruzioni a due operai albanesi, che eseguivano a ritmo serrato.
Ho cacciato un urlo lungo oltre un minuto: «Criminali, fermatevi! C’era un sogno e ora non c’è più nulla. Fermatevi, delinquenti!».
Dovevo avere un’aria davvero minacciosa, perché i tre si sono fermati e si sono girati a guardarmi con aria sbalordita.
Ero appena rientrata da Milano, dove avevo partecipato a una trasmissione televisiva, “Mattino 5”. Per tutto il viaggio avevo accarezzato l’idea di tornare a casa, sdraiarmi nella penombra della mia stanza e riordinare i pensieri. Ma ora avevo l’impressione di essere entrata per sbaglio in casa d’altri, forse nello studio di un notaio, con un tetro giardinetto angusto e banale, noioso come il suo proprietario.
Gli orrendi palazzi vicini, la cui vista per anni mi era stata risparmiata dalla volta verde dei miei alberi, ora si stagliavano contro il cielo in tutta la loro bruttezza e incombevano su di me in una luce abbacinante.
È stato un momento terribile: ho capito che si era rotto per sempre un equilibrio, che era sparito per sempre il luogo dove, per dieci anni, c’eravamo nascosti e riservati nei momenti peggiori.
Il mio bosco segreto, che di notte si animava di fruscii e rumori lontani, di aliti di vento, giaceva ora davanti a me distrutto e umiliato dalle bianche ferite inferte dai denti della sega sul nero della scorza.
Se è vero quel che si legge nei libri, Cosimo, il Barone Rampante, aveva sentito dire che nei tempi antichi una scimmia che fosse partita da Roma saltando da un albero all’altro sarebbe potuta arrivare fino in Spagna senza mai toccare terra. Io ne ero sicura, e quando mi avvicinavo in silenzio ai miei alberi, per osservare le foglie nuove, grandi e lustre, o piccole e vellutate, e i rami neri della magnolia, dove di colpo a tempo debito sporgeva un carnoso fiore bianco, quando mi muovevo in quella luce verdastra da acquario, pensavo che bastava chiudere gli occhi per arrivare, che so, in Moldavia, in Carinzia, nella Selva Nera.
Tutto finito.
Ho posato il bastone che avevo brandito minacciosa davanti ai due operai albanesi e alla bionda amazzone che avevano fatto scempio del mio regno.
Sono entrata come una furia nello studio di Carlo, che pareva infastidito da tutto il trambusto che s’era creato e cercava imperturbabile di continuare la telefonata in cui era immerso.
«E tu non hai mosso un dito!» urlo. «Stanno distruggendo la mia, la nostra vita, e tu te ne stai qui, sussurrando parole incomprensibili, in mezzo alle tue scartoffie!»
«Niente di incomprensibile, Marina. Come al solito esageri! Sono normali lavori di potatura che andavano fatti comunque! E io stavo rispondendo al sarto Primo Chiodo, che sta ritoccando i pantaloni del mio smoking per Venezia, e voleva sapere se il pacco lo porto a destra o a sinistra.»
«Ah, parlavate di coglioni! E dici che io esagero!? Ma hai provato a uscire dal tuo guscio, a dare un’occhiata a quell’ammasso di relitti, tronchi, rami, bambù sradicati, abbandonati per terra?»
«I bambù sono piante altamente infestanti» dice compunto Carlo, come se ripetesse una lezioncina di botanica appena imparata.
«Infestanti!? Infestanti!? Ma ti hanno fatto il lavaggio del cervello?»
A quel punto è scoppiata una inevitabile, terribile, furibonda lite, che si è conclusa con l’altrettanto inevitabile: «Me ne vado, non rimetterò mai più piede in questa casa!».
Con gli occhi iniettati di sangue, ho spalancato la porta d’ingresso e l’ho sbattuta con forza dietro di me.
Ho incrociato lo sguardo con la signora del piano di sopra, che stava scendendo gli ultimi gradini che danno sull’androne del palazzo.
«Ma bene» dice sarcastica la signora. «Begli ambientalisti, voi Ripa di Meana! Avete fatto legna per l’inverno? Dovreste vergognarvi di quello scempio là fuori!»
L’ho guardata ammutolita. Ho riaperto la porta di casa mia e ho urlato: «Carlo, vieni un po’ qui, la signora del piano di sopra ha qualcosa da dire all’integerrimo ambientalista!».
Credo sia in casi come questi che la mia voce possa legittimamente essere definita “stridula”. Dopo qualche minuto di dialogo con la gentile dama del piano di sopra, Carlo si è deciso, finalmente, a dare un’occhiata in giardino. Ora anche lui era impietrito, e continuava a ripetere: «Era il giardino più incantato di Roma, e adesso è un deposito di nani di Biancaneve sbeccati».
Con un’ultima occhiata di inutile trionfo, ho deciso di abbandonare il campo della rovina, di uscire, alla ricerca di consolazione nei paesaggi noti e intatti per le strade di Roma, approfittando del fatto che Andrea era impegnato a comprare salmone all’aneto gravad lax all’Ikea e a portare in un piccolo deposito di via Fauro (sì, la stessa via dove abitavo da ragazzina!) i vestiti che decido di mettere in vendita perché, dopo averli indossati in televisione, praticamente non li posso portare più d’un paio di volte. Intanto Carlo, forse un po’ stordito dai capelli folti e dalle zinne sode della botanica, decisa come Anita Garibaldi, stava nel suo studio, con aria affranta. In cuor mio, speravo che le mie ultime minacce di morte, seppure generiche, avrebbero sortito la conclusione dei lavori del cantiere prima del tempo fissato. Penso che la bella botanica di Vallerano di Roma abbia chiamato quello stesso pomeriggio il proprietario dell’immobile, spiegando l’accaduto e aggiornando il lavoro per l’indomani.
Sono uscita di casa e, tirando il passo, ho attraversato piazza Cavour umida, gelida, con tutte le palme malate, la chioma secca piegata e sorretta da un anello metallico, come la capuzzella di un impiccato, quando alla forca c’era ancora il boia pontificio, mastro Titta. In un vapore grigio, una sola libreria, Arion, sull’angolo, rossa, tanto illuminata e tanto ottimistica, vuota, certo, con le panchine sul marciapiede, circondata da notizie pessime della TV che riportava manifestanti libici che roteavano roncole-scimitarre, e il presidente Giorgio Napolitano che dalla Germania invitava a non preoccuparsi più di tanto, in particolare per il numero dei barconi e di quanti, profughi senza futuro, sarebbero sbarcati nell’atollo italiano di Lampedusa, prendendo il largo da un porto della Libia.
Arrivata al Ponte Cavour, tenendo la destra di via Vittoria Colonna, all’altezza dell’incrocio con il Lungotevere dei Mellini, uno strano edificio di fine Ottocento con un grande lucernaio, sopra il tetto, una specie di atelier per pittori, e ai piedi, lungo tutto il basamento, tavoli e alzate e vetrine dei grandi Ruschena, che secondo me dovevano essere pasticceri piemontesi, ineguagliabili nei mont blanc e nei marrons déguisés. E, quando ci penso, salivo dalla nostalgia. Un languore per la pasta di castagne glassate con un tappo di panna montata, o per i piccoli mont blanc di taglio “paste della domenica”, con la meringa di un tempo e la panna montata come la si faceva una volta, dal latte battuto con il cucchiaio di legno poroso e biancastro, e che ora sono invece composti da spaghetti di marronita pigiati nei sac à poche, da dove spuntano ormai castagne insapori, e da una panna sbattuta da fruste di metallo, che è invece solo schiuma, praticamente nulla, come la spuma con cui si fanno i cappuccini. E io vengo presa dalla disperazione, perché i sapori spariscono. E tutto non sa più di niente.
All’improvviso mi sono sentita come quando avevo vent’anni e tornavo, la domenica pomeriggio, dalla colazione a piazza della Libertà a casa delle mie amiche e cugine Azzariti e Bedoni, con quelle lunghe buone cucinate dei miei amati parenti. Nel frattempo sono arrivata alla schiena d’asino del Ponte Cavour, dove ho davanti l’angolo e il bow-window dello sperone di Palazzo Borghese, i platani forti, con il rostro dell’antica punta, che per secoli era stato il segnale del porto fluviale di Ripetta nelle acque del Tevere, a terra, e i platani spogli, che alla fine della luce del pomeriggio si riempiono a migliaia di storni che stridono e a poco a poco cedono di colpo, e i rami diventano pesanti e rigidi, nel silenzio improvviso. Quando da ragazzina guardavo Palazzo Borghese, pensavo che in fondo, per via di matrimonio, un giorno forse avrei potuto anch’io invitare a cena Linda Christian e Tyrone Power al Circolo della Caccia, all’ultimo piano del palazzo, punto certo, perché mi proponevo di sposare un grande nobile, uno con i quattro quarti, e dunque con il potere di invitare a cena chiunque in quel prestigioso, magico luogo riservato al gotha della nobiltà.
Sono salita tenendo la mano destra sulla spalletta del ponte, più o meno lì dove, sotto una delle grandi arcate, era all’ancora una delle chiatte dei circoli canottieri.
Circa trent’anni prima, nel 1979, nella mia delirante interpretazione cinematografica di Assassinio sul Tevere di Bruno Corbucci, con Tomas Milian, lanciandomi al tramonto dalla spalletta del Ponte Matteotti, da dove ogni Capodanno si lanciava l’“olandese volante” Mister Ok, mi ero gettata anch’io nel gorgo scuro del fiume per raggiungere e uccidere la mia vittima, nuotando con una muta nera da sub. E una voce all’altoparlante, argentina e dissacrante, tipica di un giovane fiumarolo, mi aveva rincorso con un: «A Mari’, sta’ attenta ar cefalo!».
Per quei misteriosi allineamenti della memoria, mi sono ricordata che quella con Bruno Corbucci e Tomas Milian era stata in realtà la mia unica esperienza cinematografica. Il mondo della celluloide non era per me, mi annoiavano le lunghe attese tra un ciak e l’altro e quel sentirsi sballottata a destra e a manca, con un truccatore che ti seguiva come un’ombra. Avevo avuto anche un’altra (e per la verità meno sguaiata) occasione di entrare nel mondo del cinema, in quel caso hollywoodiano, quando circa nove anni prima, nel ’70, il produttore americano Bob Evans, con il quale a quel tempo avevo una storia, mi aveva chiesto di interpretare il ruolo di protagonista di Love Story. Sì, voleva affidarmi proprio la parte che venne poi data ad Ali MacGraw, e che la rese famosissima. Alla mia obiezione che non parlavo l’inglese, Bob Evans mi aveva anche procurato una coach per insegnarmelo a tamburo battente. Poi, però, non se ne era fatto niente, perché il mio rapporto con la coach era finito a male parole (colpa della mia insofferenza e della sua pignoleria), ma soprattutto perché non avevo voluto lasciare Roma. Il faldone del cinema, quel pomeriggio del 28 febbraio 2011, lo richiusi ripensando all’ultima esperienza, quella del ’92, quando in Venezuela ero stata regista e sceneggiatrice del film Cattive ragazze. Con un sottile dolore e un pizzico di autoironia, ricordai anche che il critico Paolo Mereghetti così informò i suoi lettori delle mie fatiche: “Il primo e ultimo film di una serie così breve da esaurirsi nel giorno stesso del suo inizio”.
Spostandomi sull’altra spalletta, in direzione di via Tomacelli, potevo scorgere le due chiese basse rispetto al Lungotevere rialzato, due chiese, quella di San Gerolamo dei Croati e quella del Valadier, dove avevo ancora il fotogramma dell’immediato dopoguerra, dei miei vent’anni, appunto, quando tornavo dai cugini Azzariti dopo aver divorato il bollito con salsa verde: molto prezzemolo, olio, chiara d’uovo tritata, un po’ d’aglio e un pizzico di acciuga, che mi dava appena appena un po’ di bruciore, e che però mi piaceva tanto. A quel tempo, su quell’argine, c’era, ricordo benissimo, solo una piccola urna con dentro l’Ara Pacis, che io vedevo e riuscivo a leggere da fuori. Era la sistemazione di un architetto dell’epoca, Vittorio Ballio Morpurgo. Cinquant’anni dopo, lunedì 28 febbraio 2011, invece, mi gravava l’ombra bianca di un gigantesco parallelepipedo di foggia balneare, l’Ara Pacis di Richard Meier, l’americano, una specie di stabilimento di Fregene, la grande “nave” di quel segmento del Tirreno. Poi ho proseguito attraversando largo Goldoni, scorrendo lungo tutta via Condotti e, arrivata a piazza di Spagna, a fianco della scalinata, ho preso posto al Babington’s tea room. Non si entra più in quel tempio dall’uscio laterale affacciato sull’androne, ma diritti, attraverso una piccola rampa, un fornice ricavato da un varco nel muro incorniciato dal travertino. E nella luce del fondo, tra scatole nere di tè e lemon pie giallo zafferano in una vetrina vittoriana piena di luce, vedevo Luca Montezemolo con una sua amica, in silenzio; un profilo, quello femminile, che sembrava tracciato dal Pollaiolo e che tirava su da una tazza di tè lapsang, mentre Luca teneva con le due mani un oggetto piatto, rettangolare, di vetro o d’alluminio, forse un iPod (o iPhone?). Lo teneva con due mani guardando in basso, con le dita strette sull’oggetto, amleticamente perplesso se chiamato, veramente o meno, a salvare l’Italia.
Qualche mese prima mi trovavo a Milano, in una di quelle classiche giornate autunnali fredde e piovose. Arrivai in taxi al Grand Hotel et de Milan, sotto un acquazzone dirompente. Il voiturier dell’albergo (così almeno credevo) diritto e impettito mi aprì la portiera dell’auto e, tenendo aperto l’ombrello, mi invitò a scendere. «Prego, signora» mi disse con accento valdese, ravviandosi con noncuranza un ciuffo biondo cenere. Mi girai per ringraziarlo, ed ecco che mi si appalesa Luca Cordero di Montezemolo!
Tornando verso il Ponte Cavour, mi sono diretta al locale bruxellese Du pain quotidien per mangiare un croissant, come facevo in avenue Louise nella capitale belga, quando Carlo era commissario europeo. Prima di scavalcare del tutto il ponte, mi sono girata indietro e ho visto l’innaturale, con alcune luci alogene sparate dall’alto con fasce strette e violente di luce bianca lungo la facciata qualsiasi di un edificio ottocentesco, oggi la Banca del Fucino. Hanno creato solo con effetti di luce una specie di architettura da notti bianche di San Pietroburgo, che tuttavia potrebbe essere anche una facciata vicentina tardo-palladiana sui Monti Berici; e girando lentamente il capo verso gli attici del palazzo dei gioiellieri Bulgari, in Lungotevere Marzio, chi guarda in alto, sopra gli attici, entra in un mondo di luce e led, un giardino d’Oriente fatto di palme, di acque scorrenti, tutto virtuale, tutto inventato, sull’ultimo livello di quel palazzo che ha ai piedi il Tevere e di fronte Castel Sant’Angelo e San Pietro. È l’innaturale, il trionfo del mondo virtuale del nostro profeta, Dagospia.
Ripercorro il ponte in senso contrario e, arrivata quasi al piede, sono sempre sulla spalletta a nord del fiume, quindi verso San Pietro e non verso piazzale Flaminio. Qualche giorno prima, Carlo, che stava passeggiando con me, e seguiva con l’occhio Rosi Greco e un suo amico fermi, con il motorino in verticale perché si era bloccato il freno anteriore e la ruota non girava più, guardava quella casa bianca di fronte, che è quasi dirimpettaia a quella di Dagospia dall’altra parte del fiume, già in Prati, in via Vittoria Colonna. E dopo un silenzio molto lungo mi aveva detto, indicandomi il palazzo dell’Ottocento ridipinto in bianco e il suo portone: «Qui siamo a Lungotevere Prati. Lì, al piano nobile, ora abita Marta Marzotto». Io ho stretto le labbra e ho pensato: “Ah no, questo no. Anche qui. Ma non doveva rimanere fino all’ultimo giù in Libia con Gheddafi?”.
Sarà stato il richiamo indiretto di Gheddafi, e il ricordo dell’ultima telefonata di Carmen Llera dall’Africa del Nord che, dicono, destabilizzò Alberto Moravia il giorno prima della sua morte improvvisa; sarà stato il Lungotevere dei Mellini a sbalzarmi a oltre vent’anni fa al Lungotevere delle Vittorie, la parte iniziale dopo la Farnesina, e il mio ricordo va a un piano alto di una palazzina in stile littorio dove abitava da tanti anni il mio amico scrittore.
Alberto mi portava sulla prua della sua terrazza che dominava Roma per poterla rimirare da lì, escludendo dallo sguardo le odiate auto. Ma di colpo mi tornano in mente i nostri ultimi incontri.
Alberto si era un po’ offeso per una mia intervista a un settimanale femminile in cui parlavo sì della nostra grande amicizia, ma lo criticavo anche, etichettandolo con l’espressione “braccin curt”. A cercare di metter pace fu quella volta Alain Elkann, che stava lavorando al suo librone-intervista Vita di Moravia, che poi uscì il giorno esatto della morte dello scrittore.
Per fare pace, eravamo andati a cena, su sua iniziativa, due settimane prima. E sono grata ad Alain, perché così ho potuto riparlare con Alberto e rivederlo prima della sua scomparsa. Pochi giorni dopo quella cena, il mattino del 26 settembre 1990, ero nel negozio Camomilla a comprare un piccolo cappellino simile a quelli a trapezio degli ufficiali polacchi. La radio annunciò che era morto Moravia. Corsi al Lungotevere delle Vittorie. Mi fecero entrare per salutarlo, e fu l’ultima volta che lo vidi.
Mi ricordai di quella sera, quando Alberto sbuffava e batteva i piedi per la “faticaccia” che gli avevano imposto le ultime bozze, ...