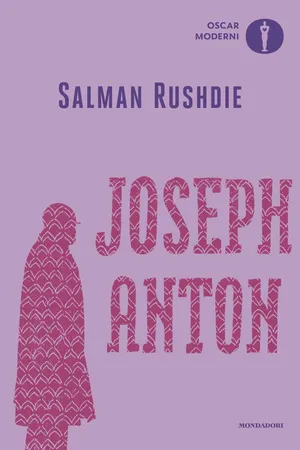![]()
Quando era piccolo, all’ora di andare a dormire suo padre gli narrava le magnifiche favole d’Oriente; le raccontava e riraccontava, variandole e reinventandole alla sua maniera. C’erano quelle di Sheherazade dalle Mille e una notte, narrate per combattere la morte e per provare che le storie hanno il potere di ingentilire e sopraffare anche il più spietato dei tiranni; e le favole con gli animali del Panchatantra; e i prodigi che si riversavano come una cascata dal Kathasaritsagara, l’“Oceano formato dai fiumi delle storie”, immenso bacino di racconti creato in quel Kashmir da cui venivano i suoi antenati; e poi le gesta dei potenti eroi raccolte nello Hamzanama e nelle Avventure di Hatim Tai (dalle quali era anche stato tratto un film, pieno di infiorettature rispetto ai racconti originali, su cui il padre ricamava a sua volta, quando lo metteva a letto). Crescere immerso in quelle narrazioni significava imparare due indimenticabili lezioni: la prima era che, pur non essendo vere (nella realtà infatti non c’era traccia di geni nella lampada né di tappeti volanti né di lanterne magiche), quelle storie gli facevano percepire e capire, proprio nel loro essere non vere, verità che la realtà stessa non era in grado di raccontargli; la seconda era che gli appartenevano tutte, così come appartenevano a suo padre, Anis, e a chiunque altro: erano tutte sue, com’erano di suo padre, le storie luminose e le storie cupe, le sacre e le profane, tutte a sua disposizione per essere alterate e rinnovate e scartate e scelte di nuovo come e quando voleva, sue per riderne e gioirne e viverci dentro e insieme e appresso, per dar loro vita nell’amarle e per riceverne in cambio vita nuova. L’animale narratore era l’uomo, l’unica creatura sulla terra che si raccontava storie per capire qualcosa su se stesso. Le storie erano sue per diritto di nascita, e nessuno poteva togliergliele.
Anche sua madre Negin aveva delle storie per lui. Alla nascita, Negin Rushdie si chiamava Zohra Butt, e quando si era sposata con Anis aveva cambiato, oltre al cognome, anche il nome proprio, reinventandolo appositamente per il marito e lasciandosi così definitivamente alle spalle quella Zohra a cui non voleva più pensare, una donna che in passato era stata molto innamorata di un altro uomo. Suo figlio non avrebbe saputo dire se nel profondo dell’animo si sentisse più Zohra o più Negin, perché con lui non parlò mai dell’altro uomo. Preferiva spifferare i segreti di chiunque tacendo invece sui propri. Era infatti una pettegola di livello mondiale, e mentre raccontava seduta sul suo letto, lui, che le massaggiava i piedi come le piaceva, lui, il maggiore e unico maschio tra i suoi figli, ebbro delle notizie deliziose e talvolta piccanti che uscivano dalla sua bocca, dalla gigantesca, ramificata e aggrovigliata foresta di sussurranti alberi della genealogia familiare di cui si faceva latrice, lui si nutriva del frutto proibito dello scandalo. E giunse a capire che anche questi segreti diventavano suoi, poiché un segreto, una volta raccontato, non apparteneva più a chi lo rivelava, ma a chi ne veniva messo al corrente. Se non si voleva che un segreto fosse svelato, bisognava seguire un’unica regola: “Non raccontarlo a nessuno”. Anche questo precetto gli sarebbe tornato utile in seguito. E fu appunto in seguito, quando era ormai diventato uno scrittore, che sua madre una volta gli disse: «Basta, di queste storie non te ne racconterò più, che poi tu le infili tutte nei tuoi libri e io mi ritrovo in mezzo ai guai». Era vero, e forse qualcuno le aveva consigliato di darci un taglio, ma sta di fatto che lei era dipendente dai pettegolezzi come il marito, suo padre, lo era dal bere, e proprio come lui era incapace di smettere davvero.
Villa Windsor, Warden Road, Bombay-26. Era una casa sulla collina, dalle finestre si vedeva il brulicare cittadino e, al di là, il mare; sì, suo padre era ricco, anche se passò la vita a spendere ciò che aveva e quando morì, sul lastrico e pieno di debiti, tutto il denaro che lasciò fu una scorta di rupie nel cassetto in alto a sinistra della sua scrivania. Anis Ahmed Rushdie (“B.A. Cantab., Bar-at-Law”, avvocato patrocinante, come recitava orgogliosamente la targa di ottone affissa al muro accanto alla porta principale della villa) aveva ereditato una fortuna dal padre, un magnate del tessile di cui era l’unico figlio, dopodiché se l’era spesa tutta ed era morto: potrebbe anche sembrare la storia di una vita felice, ma non lo era stata. Sul suo conto, i figli sapevano alcune cosette: che la mattina era allegro finché non si radeva, ma poi, una volta che il Philishave aveva fatto il suo lavoro, diventava irritabile, e allora era meglio non stargli tra i piedi; o che quando li portava in spiaggia il fine settimana, all’andata era allegro e divertente mentre sulla via del ritorno era immancabilmente di cattivo umore; o che, quando giocava a golf con la moglie al Willingdon Club, lei, che era una giocatrice migliore, doveva fare in modo di perdere perché non valeva la pena vincere contro di lui; e che quando era ubriaco si metteva a fare smorfie raccapriccianti, alterando i lineamenti del volto in espressioni strambe e terribili che li spaventavano a morte e che nessun estraneo era mai arrivato a vedere, cosicché tutti gli altri erano ignari di cosa intendessero quando dicevano che papà “faceva le facce”. Ma quando ancora erano piccini c’erano quelle storie, e poi il sonno, e se sentivano che in un’altra stanza si stava alzando la voce, se sentivano la mamma che piangeva, non c’era nulla che potessero fare. Si tiravano le lenzuola sulla testa e cominciavano a sognare.
Anis portò il figlio tredicenne in Inghilterra nel gennaio del 1961. Per circa una settimana, prima che iniziassero i corsi della Rugby School, condivisero una stanza in un albergo di Londra, il Cumberland Hotel vicino al Marble Arch. Di giorno andavano a comprare gli indumenti prescritti dalla scuola, giacche di tweed, pantaloni grigi di flanella, camicie Van Heusen con il colletto semirigido staccabile, che si chiudeva con bottoncini a pressione sul collo del ragazzino rendendogli difficile respirare. Bevevano milkshake al cioccolato alla Lyons Corner House di Coventry Street, andavano al cinema, l’Odeon Marble Arch, per vedere The Pure Hell of St Trinians, e lui intanto sperava che nel collegio della scuola ci fossero anche delle ragazze. La sera il padre comprava pollo grigliato da asporto nel Kardomah Café di Edgware Road e glielo faceva introdurre clandestinamente nella camera d’albergo, nascosto nel suo nuovo impermeabile a doppiopetto di serge blu. Poi si ubriacava, e a notte fonda lo svegliava scuotendolo e urlandogli parole talmente sconce che al ragazzo, terrorizzato, sembrava persino impossibile che le conoscesse. Infine andarono a Rugby, comprarono una poltrona rossa e si dissero addio. Anis scattò una foto in cui si vede suo figlio davanti al college con in testa un berretto a strisce bianche e blu e addosso l’impermeabile che sapeva di pollo. La malinconia negli occhi del ragazzo potrebbe far pensare che fosse infelice di andare in una scuola così lontana da casa. Ma in verità non aspettava altro che suo padre partisse per cominciare a dimenticare le notti intrise di quel linguaggio osceno e di quella cieca rabbia immotivata. Voleva lasciarsi alle spalle la tristezza e iniziare a vivere il proprio futuro, ed era forse inevitabile che dopo tutto ciò si sarebbe costruito un’esistenza il più lontano possibile dal padre, frapponendo oceani di distanza tra loro. Tempo dopo, laureatosi a Cambridge, quando comunicò al padre che voleva fare lo scrittore, dalla bocca di Anis uscì una sorta di doloroso guaito. «E adesso» aveva urlato «che cosa racconto ai miei amici?»
Ma diciannove anni più tardi, il giorno del quarantesimo compleanno di suo figlio, Anis Rushdie gli spedì una lettera scritta di suo pugno che divenne la comunicazione più preziosa che quello scrittore aveva o avrebbe mai ricevuto. Accadde cinque mesi prima che Anis morisse, ormai settantasettenne, di un mieloma multiplo fulminante, un tumore del midollo osseo. In quella lettera emergeva con che attenzione avesse letto i libri del figlio, quanto li avesse capiti, come fosse impaziente e desideroso di leggerne altri, e con quanta profondità sentisse dentro di sé un amore paterno che in tutta la vita non era riuscito a esprimere. Visse abbastanza per felicitarsi del successo dei Figli della mezzanotte e della Vergogna, ma non per leggere il libro con il più grosso debito nei suoi confronti. E forse fu meglio così, perché in questo modo si perse anche il clamore che ne seguì; ma una delle poche cose di cui suo figlio era assolutamente sicuro era che nel mezzo della battaglia scatenata dai Versi satanici avrebbe potuto contare sull’incondizionato, incrollabile sostegno del padre. Di fatto, senza l’ispirazione delle sue idee e del suo esempio quel libro non sarebbe mai stato scritto. “Mamma e papà ti incasinano la testa?” No, per niente. O meglio, magari sì, ma ti hanno anche permesso di diventare la persona, e lo scrittore, che avevi dentro di te.
Il primo dono che ricevette dal padre, un dono simile a un messaggio in una capsula del tempo che non capì fino all’età adulta, fu il suo cognome. “Rushdie” era un’invenzione di Anis, il cui padre si chiamava in realtà in tutt’altra maniera, quasi con uno scioglilingua: Khwaja Muhammad Din Khaliqi Dehlavi, un raffinato cognome della Città Vecchia di Delhi, perfettamente adatto a quel gentiluomo d’altri tempi che con un’occhiata truce folgorava chi lo guardava nella sua unica fotografia sopravvissuta, quell’industriale di successo e saggista occasionale che viveva in una haveli diroccata nella famosa vecchia mahalla, o quartiere, di Ballimaran, un dedalo di viottoli ventosi dalle parti di Chandni Chowk, che era stata la casa di Mirza Ghalib, il grande poeta farsi e urdu. Muhammad Din Khaliqi era morto giovane, lasciando al figlio una fortuna (che avrebbe sperperato) e un nome troppo pesante da portarsi addosso al giorno d’oggi. Anis si era dunque ribattezzato “Rushdie” in onore di Ibn Rushd, colui che in Occidente è noto come Averroè, il filosofo arabospagnolo di Cordoba del XII secolo che era diventato il qadi, o giudice, di Siviglia, traduttore e commentatore celebrato delle opere di Aristotele. Suo figlio portò quel nome per due decenni prima di rendersi conto che il padre, un vero studioso dell’islam a cui però mancava completamente la fede religiosa, lo aveva scelto perché di Ibn Rushd ammirava le argomentazioni razionalistiche all’avanguardia nei confronti degli islamici che, ai suoi tempi, tendevano a interpretare le scritture in modo strettamente letterale; e altri vent’anni dovettero passare prima che la battaglia scatenata dai Versi satanici fornisse un’eco tutta novecentesca a quella disputa vecchia di otto secoli.
“Perlomeno” si disse mentre sopra il suo capo si stavano addensando le nubi nere della tempesta “andrò in battaglia con il giusto nome.” Dalla tomba, suo padre gli aveva consegnato un vessillo sotto il quale era pronto a lottare, il vessillo di Ibn Rushd, ossia dell’intelletto, dell’argomentazione, dell’analisi e del progresso, per la libertà della filosofia e dell’insegnamento dai ceppi della teologia, per la ragione umana contro la cieca fede, la sottomissione, l’accettazione prona e l’immobilismo. Nessuno vuole andare in guerra, ma se ti ci trovi in mezzo, che almeno sia una guerra giusta, per le cose più importanti che ci sono al mondo, e allora potresti anche chiamarti “Rushdie”, se dovessi andare a combatterla, e collocarti laddove ti ha messo tuo padre, nel solco della tradizione del grande aristotelico, Averroè, Abū’l-Walīd Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd.
Lui e suo padre avevano la stessa voce. A casa, quando rispondeva al telefono, gli amici di Anis lo scambiavano per lui, e ogni volta doveva interromperli prima che si mettessero a dire qualcosa di imbarazzante. Si assomigliavano, e nei momenti tranquilli del loro accidentato viaggio di padre e figlio si sedevano in veranda, nel tepore della sera, con il profumo della buganvillea nelle narici, a discutere appassionatamente sulle cose del mondo, e sebbene fossero quasi sempre in disaccordo entrambi sapevano di avere lo stesso modo di pensare. Ciò che condividevano sopra ogni cosa era la mancanza di fede.
Anis era un senza Dio, il che è ancora considerato una condizione scioccante negli Stati Uniti, sebbene sia tutt’altro che eccezionale in Europa, e completamente incomprensibile nella maggior parte del resto del mondo, dove la sola idea di “non credere” è difficile persino da formulare. Ma era esattamente ciò che era: un ateo che però sapeva molto di Dio e ci pensava spesso. Le origini dell’islam lo affascinavano poiché erano le uniche a essere storicamente documentate tra le grandi religioni del mondo, e perché il Profeta non era una leggenda glorificata da “evangelisti” che avevano scritto cento o più anni dopo la vita e la morte dell’uomo reale, né un piatto riscaldato da quell’eccezionale proselitista che era stato san Paolo per un facile consumo globale, ma piuttosto un uomo dalla vita ampiamente certificata, di cui si conoscevano bene le condizioni economiche e di censo, vissuto in un’epoca di profondi cambiamenti sociali, un orfano diventato mercante di successo dalle tendenze mistiche, che un giorno, sul monte Hira vicino alla Mecca, aveva visto l’arcangelo Gabriele stagliarsi all’orizzonte riempiendo la volta celeste e istruendolo su come “recitare” e pertanto creare a poco a poco il testo della “Recitazione salmodiata”, al-Qur’an, il Corano.
Anis aveva tramandato al figlio la convinzione che la nascita dell’islam fosse affascinante proprio perché si era verificata “dentro la storia”, e che, in quanto tale, non poteva che essere stata influenzata dagli eventi, dalle pressioni e dalle idee circolanti al tempo della sua creazione; e che storicizzare l’accaduto, cercare di capire come una grande idea potesse essere modellata da quelle diverse forze, era di fatto l’unico approccio possibile all’argomento; e che si poteva considerare Maometto un autentico mistico – così come si può accettare che Giovanna d’Arco abbia realmente sentito delle voci o che la Rivelazione di san Giovanni riporti effettivamente l’esperienza “reale” di un’anima tormentata – senza necessariamente stimare come vero che, se qualcuno fosse stato accanto a lui quel giorno sul monte Hira, avrebbe assistito a sua volta all’apparizione dell’arcangelo. La rivelazione doveva essere intesa come un evento interiore, individuale, non come una realtà oggettiva, e la parola rivelata andava indagata come ogni altro testo, usando tutti gli strumenti critici a disposizione, letterari, storici, psicologici, linguistici e sociologici. In breve, il testo doveva essere considerato come un artefatto umano e, in quanto tale, preda della fallibilità e dell’imperfezione degli uomini. Il critico americano Randall Jarrell, con una frase diventata famosa, ha definito il romanzo come “un lungo scritto con qualcosa di sbagliato dentro”. Ecco, Anis Rushdie pensava di sapere cosa ci fosse di sbagliato nel Corano: alcuni passaggi sembravano sconnessi.
Secondo la tradizione, Maometto, che era forse analfabeta, quando scese dalla montagna cominciò a recitare e chiunque appartenesse alla sua più stretta cerchia e gli fosse vicino in quel momento trascrisse le sue parole su quanto aveva sottomano: pergamena, pietra, pelle, foglie, e talvolta, si dice, persino ossa. Questi brani furono conservati in un forziere custodito nella sua abitazione fino alla sua morte, quando i compagni si riunirono per stabilire la corretta sequenza della rivelazione, ed è alla loro risolutezza che dobbiamo il testo del Corano diventato canonico. Per poterlo considerare “perfetto”, il lettore è chiamato a credere che: a) l’arcangelo abbia riferito la Parola di Dio senza alcuna imprecisione, il che è del tutto ammissibile dal momento che si presume che gli arcangeli siano immuni da refusi; b) il Profeta, o, come preferiva chiamarsi, il Messaggero, si sia ricordato le parole dell’arcangelo con assoluta precisione; c) le frettolose trascrizioni dei compagni, buttate giù nel corso di una rivelazione durata ventitré anni, siano parimenti esenti da errori; d) quando essi si riunirono per disporre il testo nella sua forma definitiva, la loro memoria collettiva della corretta sequenza fosse a sua volta perfetta.
Anis Rushdie era riluttante a contestare le proposizioni a), b) e c). La d), invece, gli risultava più difficile da digerire, perché, come facilmente si accorge chiunque legga il Corano, parecchie sure, o capitoli, contengono profonde discontinuità, cosicché un argomento è lasciato cadere d’un tratto, senza preavviso apparente, per poi magari essere ripreso inaspettatamente più avanti, all’interno di una sura che fino a quel momento riguardava tutt’altro. Anis coltivò a lungo il desiderio di ricomporre quelle discontinuità per poter così giungere a un testo che fosse più chiaro e più facile da leggere. Non si trattava di un piano segreto o nascosto, tutt’altro, ne discuteva apertamente con gli amici anche a cena. Non c’era nessun brivido in quell’impresa, nessuna sensazione che essa potesse costituire un pericolo. Forse i tempi erano diversi, e un’idea del genere poteva essere sostenuta senza temere ritorsioni; o forse le persone al corrente erano davvero meritevoli di fiducia; o semplicemente Anis era soltanto un eccentrico inoffensivo. Fatto sta che quello studioso revisionista crebbe i suoi figli in un’atmosfera di indagine libera e aperta, senza divieti, senza tabù. Tutto, persino le sacre scritture, poteva essere vagliato e, almeno potenzialmente, migliorato.
Ma Anis non portò mai a compimento il suo progetto e, quando morì, tra le sue carte non fu trovato alcun testo. Negli ultimi anni era stato preda dell’alcol e dei fallimenti economici, non aveva avuto né il tempo né la concentrazione necessaria a sobbarcarsi la fatica richiesta da una profonda erudizione coranica. Forse il suo non era stato altro che un sogno velleitario, vacue chiacchiere alimentate dal whisky. Ma suo figlio ne era rimasto segnato. Eccolo, il secondo grande dono di Anis alla sua famiglia: uno scetticismo apparentemente impavido, accompagnato da una quasi totale libertà dalla religione. Certo, qualche piccola concessione alla tradizione la faceva anche lui. La famiglia Rushdie non mangiava “la carne del porco”, e al loro desco non si trovavano nemmeno alimenti egualmente proscritti dalle scritture come saprofagi “delle terre o delle acque” né “tutto ciò che non ha né pinne né scaglie, tanto ne’ mari quanto ne’ fiumi”; dunque, niente gamberi al curry. Assai di rado, poi, partecipavano al rituale su e giù delle preghiere celebrative dell’Idgah. Una o due volte l’anno si osservava il digiuno, durante quello che i musulmani indiani – perlopiù di lingua urdu invece che araba – chiamano Ramzán invece che Ramadan. E una volta, per un breve periodo, avevano ospitato un maulvi, un maestro di teologia, assunto da Negin per insegnare a quei pagani dei suoi figli almeno i rudimenti della fede. Ma i pagani si erano ribellati contro il docente, una sorta di versione in miniatura di Ho Chi Minh, ed erano stati così spietati nel prenderlo in giro che il maulvi era corso dai genitori per lamentarsi a gran voce di quell’irriverenza nei confronti del sacro; Anis e Negin si erano fatti una risata e avevano preso le difese dei ragazzi, cosicché il maulvi se n’era andato stizzito per non tornare mai più, mugugnando contro i miscredenti. Dopo quell’esperienza non vi furono altri tentativi di educazione coatta alla religione. I pagani restarono pagani e, perlomeno a Villa Windsor, andava bene così.
Quando si congedò dal padre per immergersi nella nuova vita che lo aspettava in Inghilterra, nel suo bell’impermeabile in serge e con in testa il berretto a strisce bianche e blu della Bradley House, la prima cosa che gli divenne chiara fu che portava addosso lo stigma di essere diventato uno “straniero”. Fino a quel momento non si era mai considerato come l’Altro di chicchessia. Ma alla Rugby School imparò una lezione che non dimenticò mai: ci sarebbe sempre stato qualcuno a cui semplicemente non piaceva, qualcuno che lo considerava alieno, un piccolo omino verde o un blobbone mucoso dell’Oltrespazio, e provare a fargli cambiare idea era una battaglia priva di senso. In seguito, in circostanze più drammatiche, sarebbe stato costretto a imparare di nuovo quella lezione.
Si accorse presto che in un collegio inglese dei primi anni Sessanta era possibile incappare in tre diverse tipologie di grave errore, ma bastava evitare di compierne almeno uno per essere perdonati. Le pecche erano: essere straniero; essere intelligente; non essere bravo negli sport o nei giochi sociali. Alla Rugby i ragazzi stranieri e intelligenti che se la spassavano erano anche eleganti giocatori di cricket o di carte, com’era il caso di uno dei suoi coetanei, il pakistano Zia Mahmood, talmente abile nel bridge da diventare uno dei più forti giocatori al mondo. Ma chi non aveva abilità sportive doveva evitare di essere troppo intelligente e, se possibile, troppo straniero, il che restava comunque il peccato più grave.
Lui, gli errori, li fece tutti e tre contemporaneamente. Era straniero, intelligente e pas sportif. Come risultato di questa nefasta miscela, alla Rugby passò anni perlopiù infelici, anche a dispetto dei suoi exploit scolastici e della gratif...