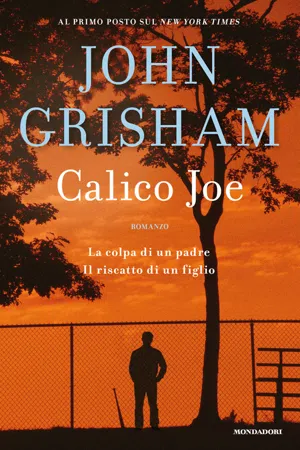Il tumore al pancreas di mio padre è stato asportato la settimana scorsa nel corso di un intervento che è durato cinque ore ed è stato più difficile di quanto i chirurghi si fossero aspettati. I medici gli hanno poi comunicato la triste notizia che la maggior parte dei soggetti in condizioni simili alle sue ha un’aspettativa di vita non superiore ai novanta giorni. Dato che io non sapevo niente né dell’intervento né del tumore, non ero presente quando a mio padre è stata annunciata la sua sentenza di morte. Per lui la comunicazione non è mai stata una priorità. Dieci anni fa ha divorziato da una moglie e, prima che la novità filtrasse fino a me, se n’era già trovata un’altra.
Mi ha telefonato la moglie in carica – la numero cinque o sei –, la quale, dopo essersi ripresentata, mi ha messo al corrente dei più crudi dettagli del tumore e delle questioni collegate. Agnes mi ha poi spiegato che in quel momento mio padre non stava bene e non se la sentiva di parlare. Io ho ribattuto che lui non se l’è mai sentita di parlare, indipendentemente dalle condizioni di salute. Agnes mi ha invitato a trasmettere la notizia al resto della famiglia. Stavo per chiederle “Perché?”, ma non mi andava di litigare con quella povera donna.
Il resto della famiglia è costituito da mia sorella minore, Jill, e da mia madre. Jill vive a Seattle e, per quello che ne so, sono almeno dieci anni che non parla con nostro padre. Ha due bambini piccoli che non lo hanno mai visto, e non lo vedranno mai. Mia madre, dopo essere sopravvissuta a dodici anni di matrimonio, per sua fortuna se n’era andata, portando Jill e me con sé. Ho la sensazione che la notizia dell’imminente morte del suo ex marito avrà un impatto pressoché nullo su di lei.
Inutile dire che a Natale non ci riuniamo tutti insieme e neppure ci scambiamo i regali davanti al caminetto.
Dopo la telefonata di Agnes mi siedo alla scrivania e comincio a riflettere sulla mia vita senza Warren, mio padre. Ho cominciato a chiamarlo Warren quando ero al college perché l’ho sempre considerato un individuo qualunque, più un estraneo che un padre. Lui non ha mai fatto obiezioni. Non gli è mai importato come lo chiamo, e ho sempre pensato che preferisca che non lo chiami affatto. Io almeno ogni tanto un tentativo lo faccio, lui mai.
Dopo qualche minuto ammetto la verità: la vita senza Warren sarà esattamente uguale alla vita con Warren.
Telefono a Jill e le do la notizia. La sua prima domanda è se ho intenzione di andare al funerale, il che è un po’ prematuro. Vuole sapere anche se dovrebbe andare a trovarlo per salutarlo e dirgli addio, prendendosi il disturbo di comportarsi come se gliene importasse, mentre in realtà non gliene importa affatto. Non importa neppure a me, e lo ammettiamo tutti e due. Non proviamo affetto per Warren perché lui non si è mai preso cura di noi. Si è disinteressato della famiglia fin da quando eravamo bambini e ha vissuto gli ultimi trent’anni comportandosi come se non esistessimo. Jill e io adesso siamo entrambi genitori, e ci sembra inconcepibile che un padre non si curi minimamente dei propri figli.
«Non ci vado» dichiara Jill alla fine. «Né ora né mai. E tu?»
«Non lo so» rispondo. «Devo pensarci.»
La verità è che so che andrò a trovarlo. Nella sua vita Warren ha tagliato quasi tutti i ponti, ma c’è una parte piuttosto importante di una questione irrisolta che lui deve sistemare prima di morire.
Mia madre vive a Tulsa con il secondo marito. Ai tempi del liceo Warren era il fanatico superatleta e lei la reginetta del ballo della scuola, la ragazza più popolare. Il loro matrimonio aveva emozionato l’intera cittadina, ma dopo un paio d’anni tutte le emozioni erano svanite. So che i miei genitori non si parlano da decenni, e perché dovrebbero?
«Mamma, ho una brutta notizia» dico al telefono, cercando di sembrare adeguatamente mesto.
«Cos’è successo?» chiede subito lei, temendo probabilmente che si tratti di una delle nipoti.
«Warren è malato. Cancro al pancreas, gli restano meno di tre mesi.»
Pausa, sollievo e poi: «Credevo che fosse già morto».
Ecco qua. Alla cerimonia funebre di mio padre non ci sarà una folla di familiari in lacrime.
«Mi dispiace» aggiunge mia madre, ma non è vero. «Immagino che dovrai occupartene tu.»
«Credo di sì.»
«Paul, io non voglio saperne niente. Chiamami quando sarà tutto finito. Anzi, no. Non mi interessa cosa succede a Warren.»
«Lo capisco, mamma.»
So che Warren l’ha picchiata, qualche volta, probabilmente molto più spesso di quanto mi rendessi conto all’epoca. E so che beveva, andava a donne e viveva la vita tosta del giocatore professionista di baseball. Era arrogante e vanesio e, a partire dall’età di quindici anni, abituato ad avere tutto quello che voleva perché lui, Warren Tracey, poteva lanciare una palla così forte da trapassare un muro di mattoni.
Spostiamo la conversazione sulle bambine e su quando mia madre potrà rivederle. Grazie alla sua bellezza e intelligenza, dopo Warren è caduta in piedi. Ha sposato un uomo un po’ più anziano di lei, un dirigente di una società di trivellazioni che ha assicurato a Jill e a me una casa accogliente. Ama mia madre, ed è questa l’unica cosa che conta.
Dubito che Warren l’abbia mai amata.
Nell’estate del 1973 il paese stava lentamente emergendo dal trauma del Vietnam. Spiro Agnew era nei guai e alla fine sarebbe colato a picco. Il caso Watergate stava diventando sempre più scottante e aveva molto altro in serbo. Io avevo undici anni ed ero vagamente consapevole di quello che succedeva là fuori, nel mondo reale, ma ne ero meravigliosamente immune. Il mio mondo era il baseball, e poco altro aveva importanza. Mio padre lanciava per i New York Mets, e io vivevo e morivo a ogni partita. Anch’io lanciavo, per gli Scrappers nella Little League di White Plains, e, dato che mio padre era quello che era, tutti si aspettavano grandi cose da me. Di rado ero all’altezza di quelle aspettative, ma ho avuto momenti promettenti.
All’inizio di luglio la corsa al pennant nella National League East si era ormai assestata su una blanda competizione. Tutte le sei squadre – Mets, Pirates, Cardinals, Phillies, Cubs ed Expos – veleggiavano intorno a .500 e davano scarsi segnali di belligeranza. Nella West, i Reds e i Dodgers stavano prendendo il largo. Nell’American League gli Oakland A’s, con le loro divise sgargianti e i capelli lunghi, speravano di ripetere il campionato del 1972.
I miei amici e io seguivamo tutto religiosamente. Conoscevamo ogni giocatore e ogni statistica. Studiavamo i tabellini di tutti gli incontri e poi rigiocavamo le partite sui campetti sabbiosi di White Plains. La vita a casa non era sempre piacevole e la mia via di fuga era il campo. Il baseball era il mio migliore amico e, a metà luglio del 1973, stava per subire una scossa come mai prima di allora.
Tutto cominciò piuttosto banalmente con un tendine stirato. A Wichita il prima base della squadra affiliata ai Cubs nell’AAA, la lega inferiore, crollò a terra mentre superava la terza e puntava a casa base. Il giorno dopo Jim Hickman, prima base dei Cubs, si fece male alla schiena. Tutto a un tratto la squadra aveva bisogno di qualcuno che giocasse in prima, così scesero di categoria e si rivolsero al loro club AA di Midland, Texas, e convocarono un ventunenne di nome Joe Castle. All’epoca Castle aveva una percentuale di valide di .395 con venti fuoricampo, cinquanta PBC, cioè punti battuti a casa, quaranta basi rubate e un solo errore in prima base. Era il prospetto più promettente dell’AA e stava attirando grande interesse.
La leggenda narra che Castle stesse dormendo nel modesto appartamento che divideva con altri quattro giocatori delle leghe minori quando arrivò la telefonata da Chicago. Venne accompagnato in auto da un viceallenatore all’aeroporto di Midland e riuscì per un soffio a prendere un aereo diretto a Houston, dove aspettò per due ore il volo per Philadelphia. Durante l’attesa telefonò alla sua famiglia in Arkansas per comunicare l’eccitante novità. Arrivato a Philadelphia un taxi lo scaricò al Veterans Stadium, dove venne rapidamente dotato di una divisa da gioco, gli venne assegnato il numero 42 e fu spedito dritto in campo. I Cubs si stavano già esercitando alla battuta.
Comprensibilmente Castle era nervoso, emozionato, quasi stordito, e quando Whitey Lockman, il manager, gli disse: “Stai tranquillo, cominci in prima e batti settimo” ebbe addirittura problemi a impugnare la sua mazza nuova di zecca. Nel suo giro di battute di riscaldamento mancò le prime due palle.
Sarebbe passato parecchio tempo prima che ne mancasse altre.
Nei pochi minuti che precedettero l’inizio della partita Castle fece due chiacchiere nel dugout con Don Kessinger, l’interbase veterano dei Cubs, anche lui originario dell’Arkansas. Kessinger, che era stato un All-American nel baseball e nel basket alla Ole Miss, era un tipo cordiale e rilassato. Riuscì a tranquillizzare il ragazzo. Il suo unico consiglio fu: “Vai là sopra e fai lavorare quella mazza”. L’esterno centro dei Cubs era Rick Monday, un altro veterano, anche lui nato in Arkansas, a Batesville, poco lontano dalla cittadina natale di Joe lungo il White River. Grazie a Kessinger e Monday, Joe riuscì a sopravvivere al peggior momento di panico pre-partita che un giocatore possa immaginare.
Era giovedì 12 luglio, un giorno che il mondo del baseball avrebbe ricordato a lungo.
Il lanciatore dei Phillies era un mancino di nome Benny Humphries, un amante delle palle veloci fuori controllo che concedeva la base con la stessa facilità con cui eliminava per strikeout. Mentre si avvicinava al box di battuta nel secondo inning, Joe strinse i denti e si ripeté di sventolare il primo lancio, quale che fosse il tipo di palla. Humphries riteneva che il novellino dovesse essere “battezzato” nella fornace della Major League e lanciò con tutta la forza che aveva. Joe, dal lato destro, intuì la palla veloce, la colpì con un contatto perfetto e sparò una valida che atterrò venti file dietro la recinzione dell’esterno sinistro. Scattò per fare il giro delle basi, troppo eccitato per limitarsi a un piccolo trotto vittorioso, e prima ancora di riprendere fiato si ritrovò nel dugout tra i compagni che si congratulavano.
Joe Castle non era il primo debuttante nella Major League che realizzava un home run al primo lancio. Anzi, era l’undicesimo. Quarantasei lo avevano fatto al primo turno di battuta, undici al primo lancio. In ogni caso il suo nome adesso era nel libro dei record. Il libro era aperto, e Joe aveva appena cominciato.
Al quinto inning Humphries partì con una dritta alta e interna, un brushback che voleva essere un avvertimento, ma Joe non recepì il messaggio. Senza perdere la calma, arrivò al conteggio di 3-1 e poi spedì una palla veloce lungo la linea di foul di sinistra, dove sfiorò a malapena l’interno del palo del foul. L’arbitro di terza base ruotò subito l’indice della mano destra per segnalare un fuoricampo. Joe, che stava girando la prima seguendo la palla con lo sguardo, scattò di corsa e rallentò leggermente mentre si avvicinava a casa base. Adesso c’era un record che apparteneva soltanto a lui e a un altro giocatore. Nel 1951 Bob Nieman dei St Louis Browns aveva realizzato due fuoricampo nei suoi primi due turni di battuta in Major League.
Quella sera i Mets giocavano contro i Braves ad Atlanta e la partita non veniva trasmessa in televisione. Io ero nel seminterrato di Tom Sabbatini e tutti e due ascoltavamo Lindsey Nelson, il meraviglioso radiocronista, il quale ci informò di ciò che era appena successo a Philadelphia. Non ci voleva molto per eccitare Lindsey: «Ha uguagliato un primato, amici miei» disse. “Pensate alle migliaia di giovani che hanno praticato questo sport: solo due di loro hanno realizzato due fuoricampo nei primi due turni di battuta.”
“Mi domando se possa riuscirci tre volte” aggiunse Ralph Kiner, battitore di grande potenza, già nella Hall of Fame e spalla di Lindsey.
Nel sesto inning i Cubs massacrarono Humphries, e i Phillies mandarono in campo un rilievo, un lanciatore destro di nome Tip Gallagher. Quando nella parte alta del settimo inning Joe lasciò l’area di riscaldamento, lo score era bloccato sul 4-4 e i tifosi dei Phillies, sempre molto chiassosi, erano in silenzio. Nessun applauso, solo curiosità. Con loro sorpresa, Joe prese posizione nel box di sinistra. Dato che non esistevano rapporti redatti dagli scout, i Phillies non potevano sapere che era ambidestro e nessuno si era preso il disturbo di osservarlo durante il riscaldamento. Castle si limitò a guardare una curva bassa, poi mandò in foul le successive due palle veloci. Con due strike, assunse un atteggiamento più difensivo e accorciò di otto centimetri la presa sulla mazza. Nella precedente stagione era risultato il battitore della Texas League con la percentuale più bassa di strikeout subiti. Con due strike, Joe Castle era al massimo della sua pericolosità.
Uno slider finì basso, poi Gallagher scagliò una palla veloce. Joe la colpì, sparando una linea che continuò a salire finché non sorvolò di un metro e mezzo la recinzione di sinistra. Mentre faceva il giro delle basi per la terza volta consecutiva, Castle stabiliva un record che sembrava imbattibile. Nessun debuttante aveva mai fatto fuoricampo nei suoi primi tre turni di battuta.
Joe Castle era nato a Calico Rock, in Arkansas, un piccolo e pittoresco villaggio appollaiato su un promontorio sovrastante il White River sul bordo orientale delle Ozark Mountains. Quello era territorio dei Cardinals, e lo era fin dai tempi di Dizzy Dean, ragazzo di campagna dell’Arkansas e leader della famigerata Gashouse Gang degli anni Trenta. Suo fratello Paul, detto Daffy, era lanciatore nella stessa squadra. Negli allenamenti primaverili del 1934, quando la Gang era all’apice della fama, Dizzy profetizzò che tra lui e Daffy avrebbero messo insieme cinquanta vittorie. Furono quarantanove: trenta per Dizzy e diciannove per Daffy. Vent’anni dopo Stan Musial, il più grande Cardinal di tutti i tempi, era riverito al punto da essere quasi idolatrato. Con una radio in ogni veranda, la cittadina di Calico Rock, come innumerevoli altre nel Midwest e nel profondo Sud, seguiva con passione gli amati Cardinals durante le lunghe e afose sere d’estate. Le cronache delle partite venivano trasmesse dalla KMOX di St Louis, e le voci familiari di Harry Caray e Jack Buck risuonavano in ogni strada e in ogni auto.
Il 12 luglio 1973, però, tutte le radio di Calico Rock erano si...