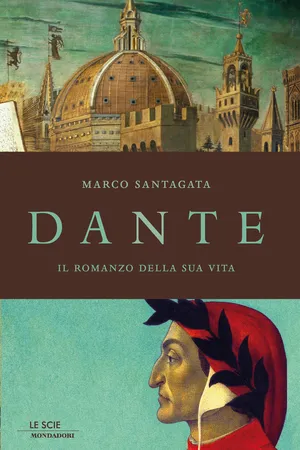![]()
![]()
la compagnia malvagia e scempia1
Arezzo e il blocco geopolitico antifiorentino
Dei fuorusciti fiorentini molti si rifugiano nella «bianca» Pistoia, i più nella ghibellina Arezzo. Quest’ultima città era il punto di riferimento di un’area regionale assai vasta: ne facevano parte il Valdarno superiore e il grande complesso montuoso che, verso nord, si estende fino alla Romagna. La nostra percezione della zona comprendente il Casentino, l’alto Mugello, il crinale e il versante romagnolo dell’Appennino, il Montefeltro è distorta dai confini amministrativi che oggi la dividono (Toscana, Romagna, Marche) e dal profondo cambiamento degli assi viari tra il Nordest e il Centro dell’Italia intervenuto in epoca moderna. Siamo portati a percepire come entità separate ciò che, allora, era sentito come un insieme unitario e a considerare come periferica una regione che ai tempi di Dante aveva ancora un notevole peso politico e strategico. In quest’area, priva di grandi centri urbani, sopravviveva, indebolito ma tutt’altro che spento, un sistema politico di stampo feudale imperniato su alcune grandi famiglie nobiliari. Pur tra molte disparità, vi prevaleva l’antiguelfismo, che si esplicava nella resistenza alle pretese papali-angioine nella zona feltresco-romagnola e all’espansionismo di Firenze in quella toscana.
La più potente consorteria della regione era quella dei Guidi, conti palatini. Fra Due e Trecento non erano più la grande famiglia unita che nel XII secolo estendeva i suoi possedimenti su vaste aree di Romagna e Toscana, ma, benché ristrettisi tra il Casentino e la fascia pedemontana che lambisce Faenza e Forlì, dominavano ancora un ampio territorio. Il loro declino era cominciato nei primi decenni del Duecento quando, come altre dinastie feudali, si erano divisi in vari rami, ciascuno dei quali manteneva il titolo comitale: di Bagno, di Battifolle, di Modigliana-Porciano, di Romena, di Dovadola. Li separavano interessi economici e schieramento politico: se i Guidi di Modigliana-Porciano erano fermamente ghibellini, quelli di Dovadola e di Battifolle erano guelfi; altri rami, come quello di Romena, oscillavano a seconda delle circostanze e delle opportunità.
Si estendevano tra il Mugello e il versante appenninico bolognese i possedimenti della grande famiglia ghibellina degli Ubaldini. Quelli del ramo della Pila (il cui uomo di spicco era stato quel cardinale Ottaviano nominato insieme a Federico II nel canto X dell’Inferno) avevano la loro base territoriale nel Mugello. Meno cospicue erano le famiglie montefeltrane, che sopperivano alle ridotte entrate economiche del territorio con i proventi del mestiere delle armi. Più volte abbiamo accennato al grande condottiero Guido da Montefeltro e a suo figlio Buonconte; fra Due e Trecento la figura di spicco è quella di Uguccione della Faggiola, feudatario della Massa Trabaria con sede principale a Corneto.
Diversa era la situazione del Valdarno superiore. Qui, infatti, erano insediate casate meno potenti di quelle della montagna tosco-romagnola, come gli Ubertini e i Pazzi (distinti dai Pazzi di Firenze, legati allo schieramento «nero»), entrambe infeudate ai Guidi. Queste famiglie erano state progressivamente spogliate di molti diritti e di molti possedimenti dal Comune fiorentino, e pertanto conducevano contro Firenze una sorta di guerriglia dai fiorentini considerata brigantaggio.
Che i Bianchi di Firenze, i grandi feudatari tosco-romagnoli, i ribelli del Valdarno e gli antichi fuorusciti ghibellini si incontrassero ad Arezzo era dunque nell’ordine delle cose. Probabilmente, a spingere i Cerchieschi a cercare subito un accordo con forze che, per un motivo o per l’altro, erano ostili a Firenze fu la fiducia di poter rapidamente rovesciare la situazione unendo alla loro potenza finanziaria l’esperienza militare dei Ghibellini fuorusciti e dei feudatari della montagna. E questo, fra i tanti, fu il loro errore più grande. Da esiliati che tentavano, legittimamente, di ritornare in patria si trasformarono in ribelli, in nemici non solo della parte «nera» ma dell’intera città.
Il successo degli assalti condotti nella primavera del 1302 ad alcuni castelli del Valdarno superiore sembrò dare loro ragione. Ma dovettero capire ben presto che azioni militari di corto respiro e, per di più, a così grande distanza dalla città non erano risolutive; e dovettero pure capire che Ubertini e Pazzi si muovevano soprattutto per i loro interessi: erano alleati, peraltro poco determinanti dal punto di vista militare, di cui non potevano fidarsi. La prova l’avranno nel luglio 1302, quando Carlino dei Pazzi, dietro la promessa di un compenso in denaro, della restituzione dei possedimenti confiscati e della liberazione di un figlio catturato poco prima, consegnerà al podestà di Firenze Gherardino da Gambara il castello di Castel del Piano (o Pian tra Vigne), che i fiorentini assediavano invano da tre settimane. Ne seguiranno prigionie ed esecuzioni. Nell’Inferno Camicione dei Pazzi, confitto nel ghiaccio della Caina in quanto traditore dei parenti, dichiarerà a Dante di «aspettare» che arrivi il suo congiunto Carlino, la cui colpa farà apparire più lieve la sua, che pure è gravissima. Insomma, i Bianchi avevano bisogno di collegarsi a forze antifiorentine più affidabili e più incisive. E, soprattutto, di portare la guerra nelle vicinanze di Firenze.
L’Università dei Guelfi bianchi
Nel frattempo i Bianchi si erano organizzati dando vita (probabilmente ad Arezzo, dove erano confluiti i loro maggiorenti, tra cui Vieri dei Cerchi) all’Università della Parte dei Bianchi di Firenze (Universitas partis Alborum de Florentia). Era una associazione che regolava i rapporti interni e gestiva quelli con i Ghibellini fuorusciti, con i signori feudali e con le città amiche. La costituzione di universitates sul modello delle magistrature nelle quali il partito si articolava in patria era quasi la norma sia per i Guelfi sia per i Ghibellini esiliati. Il fatto nuovo è che questa Università organizza una parte dei Guelfi contro un’altra parte. È sintomatico che, mentre i Bianchi vanteranno sempre il loro guelfismo, i Neri li tacceranno di ghibellinismo, fino al punto di chiamarli Ghibellini. Altra novità è l’ufficializzazione del passaggio semantico del termine «bianco» da segnale neutro (com’era quando designava la compagnia bancaria «bianca» dei Cerchi per distinguerla da quella «nera») a forte indicatore politico. L’Università è retta da un consiglio segreto di quattro membri, da un consiglio maggiore di dodici e da un capitano militare. Come primo capitano fu nominato il ghibellino Alessandro dei Guidi di Romena. Su questa nomina, avvenuta durante il periodo in cui l’Università era insediata ad Arezzo, avrà influito la circostanza che vescovo della città era Ildebrandino, fratello minore di Alessandro e lui pure ghibellino.
Una volta organizzati, i Bianchi individuano i loro veri alleati nelle famiglie feudali dell’Appennino. L’8 giugno 1302, a San Godenzo, una località del Mugello posta quasi sul crinale, vicino all’odierno passo del Muraglione, in un palazzo di proprietà dei Guidi di Modigliana-Porciano detto «dello specchio» perché, caso raro a quei tempi, dotato di vetrate, si incontrano diciotto eminenti personaggi di parte «bianca» e ghibellina: in rappresentanza dei Bianchi troviamo, oltre a Dante, nomi a noi ben noti, come Vieri dei Cerchi e Andrea dei Gherardini; tra gli esuli ghibellini, un nipote di Farinata, Lapo di Azzolino degli Uberti, già presente, forse, anche all’incontro di Gargonza. Persone, dunque, che in precedenza si erano duramente combattute e che adesso, davanti a un notaio, sottoscrivono un atto con il quale si impegnano a risarcire Ugolino degli Ubaldini dei danni che le sue proprietà nel Mugello avrebbero patito nella guerra imminente contro i Neri di Firenze. Inizia così la prima campagna mugellana, combattuta tra il giugno e il settembre 1302. Sarà ricca di scontri ma, nel complesso, inconcludente, cosicché finirà per rafforzare i Neri.
I quali cominciano anche a ottenere qualche significativo successo su un altro fronte di guerra, quello pistoiese. Qui entra in scena un personaggio che avrà un ruolo molto importante nella vita di Dante, il già citato marchese Moroello Malaspina di Giovagallo in Lunigiana. Dedito, come molti esponenti di grandi casati feudali, al mestiere di condottiero, nel 1302 si era messo al servizio di lucchesi e fiorentini assumendo la carica di capitano generale nella guerra contro la «bianca» Pistoia. Ai primi di settembre, dopo un lungo assedio, fece capitolare la fortezza di Serravalle: Dante, che dal 1306 sarà suo ospite e godrà della sua protezione, a quella vittoria ottenuta ai danni dei suoi amici politici di allora alluderà nella Commedia, con tono quasi celebrativo, paragonando Moroello a un fulmine che si forma nella valle della Magra e che si abbatte sul territorio pistoiese tempestosamente «sì ch’ogne Bianco ne sarà feruto».2
A peggiorare la situazione dei Bianchi interviene anche l’atteggiamento di Uguccione. Questi, dopo aver combattuto a lungo tra le file ghibelline in Romagna contro gli eserciti papali e angioini, nel 1302 era stato nominato podestà di Arezzo. I Bianchi, che credevano di avere in lui un sicuro alleato, ignoravano che proprio nei mesi in cui loro si rifugiavano nella sua città Uguccione si era riavvicinato alla Chiesa e ai Guelfi e aveva in corso trattative con Bonifacio VIII per ottenere benefici per sé, per il figlio e per il Comune aretino. Raggiunto l’accordo con il papa, Uguccione comincia a rendere difficile la vita dei fuorusciti, e così, tra la fine del 1302 e l’inizio del 1303, l’Università valica l’Appennino e fissa la sua base operativa a Forlì, che da molti anni era il centro del ghibellinismo romagnolo. Proprio il signore della città, Scarpetta Ordelaffi, assume la carica di capitano.
Sotto il suo comando la seconda campagna mugellana comincia presto, ma altrettanto presto i fuorusciti subiscono i primi rovesci. Particolarmente grave è la sconfitta patita nel tentativo di occupare il castello di Pulicciano, a poca distanza da Borgo San Lorenzo, che avrebbe consentito il controllo della principale via di comunicazione del Mugello. Qui, sulla metà di marzo 1303, i Bianchi e i loro alleati sono sbaragliati dai fiorentini guidati dal podestà Fulcieri da Calboli. Oltre che tra fiorentini, si trattò di uno scontro tra forlivesi, dal momento che la famiglia guelfa dei Calboli era rivale di quella ghibellina degli Ordelaffi, dai quali era stata esiliata da Forlì nel 1294. L’odio nei confronti dell’Ordelaffi può anche spiegare la particolare crudeltà del trattamento riservato da Fulcieri ai vinti, crudeltà, peraltro, di cui Fulcieri dà prova per tutto il corso della sua podesteria, tanto che i cronisti lo ricordano come «uomo feroce e crudele» e Dante, nel Purgatorio, ne traccia un impietoso ritratto come «cacciator» di carne umana.
In quello stesso mese di marzo, tuttavia, i Bianchi aprono con Bologna una trattativa che in maggio porta alla stipula di una vasta alleanza antifiorentina tra loro, Bologna, gli Ubaldini, la «bianca» Pistoia, le città ghibelline di Romagna (Forlì, Faenza, Imola) e Cervia, retta dalla famiglia guelfa dei Polentani. A capo dell’esercito è nominato il ferrarese, ma nemico degli Este, Salinguerra dei Salinguerri. Tuttavia l’alleanza, poderosa sulla carta, non ottiene risultati militari di rilievo. Per di più, sembra che ai Bianchi comincino a scarseggiare le risorse finanziarie, tanto che, fra maggio e giugno, sono costretti a contrarre prestiti, peraltro di non grande entità: il 18 giugno si riunisce a Bologna il loro stato maggiore al gran completo, compreso l’Ordelaffi, per accendere un mutuo di soli 450 fiorini. Sul fronte pistoiese, poi, i Bianchi devono registrare un altro tradimento dei Pazzi: questa volta è Pazzino dei Pazzi a cedere, in maggio, il castello di Montale, situato a metà strada tra Prato e Pistoia, dietro un compenso in denaro. Insomma, anche il secondo anno di guerra non produce buoni risultati. Tra i pochi eventi favorevoli i Bianchi possono registrare il fatto che Uguccione della Faggiola, chiusa la parentesi filopapale, era ritornato alla fede ghibellina e si era aggregato all’alleanza dei fuorusciti: ciò riapre loro le porte di Arezzo, che così ridiventa una delle loro principali basi operative. Nel novembre 1303, come capitano dell’Università troviamo non più Scarpetta Ordelaffi, ma Aghinolfo dei Guidi di Romena, fratello del primo capitano Alessandro.
Le novità che imprimeranno una svolta alla guerra tra Bianchi e Neri accadono in autunno, e non dipendono dalla volontà delle parti in causa. L’11 ottobre 1303, a poca distanza dall’oltraggio di Anagni, muore Bonifacio VIII. Un conclave particolarmente rapido elegge, il 22 dello stesso mese, il domenicano Niccolò di Boccasio, stretto collaboratore di Bonifacio ma di scarso peso politico, che prende il nome di Benedetto XI. Già nei primi mesi di pontificato si intromette nella complicata questione fiorentina nel tentativo di arrivare a una pacificazione tra le parti. Il tentativo susciterà grandi speranze nei Bianchi, ma ben presto si rivelerà velleitario, tanto da provocare una ripresa della guerra ancora più sanguinosa.
La solitudine dell’esule
Prima delle sentenze del 18 gennaio 1302 Dante lascia Firenze e si aggrega agli altri esuli ad Arezzo. È solo o è accompagnato dalla famiglia? I provvedimenti giudiziari non toccarono il fratello Francesco, che rimase a Firenze. Non sappiamo se vi abbia vissuto indisturbato o abbia avuto qualche guaio di riflesso: risulta che un cugino, Cione di Brunetto, nel 1306 fu tassato in quanto ghibellino (nome che veniva dato anche ai Bianchi ribelli); ma risulta pure che altri Alighieri, come Cione di Bello, militarono tra le file dei Neri.
Per quanto riguarda Gemma, Boccaccio non ha dubbi: «[Dante] lasciatavi [a Firenze] la sua donna, insieme con l’altra famiglia, male per picciola età alla fuga disposta, di lei sicuro, perciò che di consanguineità la sapeva ad alcuno de’ prencipi della parte avversa congiunta, di se medesimo or qua or là incerto, andava vagando per Toscana». Egli, dunque, avrebbe lasciato a Firenze sia la moglie sia i figli, ancora piccoli, e avrebbe imboccato da solo la strada dell’esilio. Boccaccio avrà avuto queste notizie dalle stesse persone che lo avevano informato del ritrovamento del quadernetto. In effetti esse collimano con quel racconto. Sono «amici e parenti», evidentemente in assenza di Dante, a consigliare Gemma di nascondere le cose più preziose in luogo sicuro. La prima redazione del Trattatello precisa che i forzieri erano stati portati in «luoghi sacri»: potrebbe trattarsi del convento francescano di Santa Croce, nel quale era frate Bernardo Riccomanni, figlio di Tana, lo stesso a cui Dante nel 1315 potrebbe aver inviato, ma è ipotesi quanto mai incerta, l’epistola «a un amico fiorentino». Abbiamo visto che Tana e il marito Lapo, tramite il fratello Pannocchia, hanno soccorso finanziariamente Dante; non sorprenderebbe, dunque, se anche in quei drammatici frangenti avessero prestato il loro aiuto convincendo il figlio a nascondere nel suo convento i beni da mettere al sicuro.
Che il piano di Dante fosse quello di lasciare moglie e figli a Firenze risulta con sufficiente chiarezza: dai primi giorni del novembre 1301 Corso Donati era il vero padrone della città, e Gemma era pur sempre una Donati. Era lecito supporre che una rete familiare di protezione si sarebbe stesa su di lei. È ipotizzabile che il padre di Gemma, Manetto Donati, abbia chiesto rassicurazioni. Del resto, sarebbe stato davvero difficile per i più stretti congiunti di Dante abbandonare Firenze per seguire un esule privo di sostanze economiche e, soprattutto, di protettori presso i quali collocare, se non sé stesso, almeno i suoi cari.
E però l’evolversi della situazione politica farà fallire questo disegno. Ben presto verrà Gargonza, si accenderà la guerriglia nel Valdarno superiore e l’atteggiamento dei Neri cambierà radicalmente. I Neri non perseguiranno più avversari da allontanare dal teatro della lotta politica, ma nemici che avevano tradito la patria. Da qui le sistematiche condanne a morte e una repressione che coinvolgerà anche i parenti dei condannati.
Il 9 giugno 1302 il Comune nomina un ufficiale con il compito di amministrare i beni dei condannati per baratteria o per colpe politiche, di cacciare dalla città i loro figli che avessero superato i quattordici anni e le loro mogli (e questi provvedimenti saranno addirittura inaspriti nel gennaio dell’anno successivo). Che uno degli ispiratori di quella delibera sia stato quel Nicola Acciaioli che alcuni anni prima aveva manomesso, con l’aiuto di Baldo d’Aguglione, il fascicolo giudiziario per lui compromettente dà il segno di quanto fosse coesa la cricca che agiva intorno a Corso. Nel mese di giugno, dunque, Gemma è costretta a lasciare Firenze. Per le ragioni appena dette, è improbabile che abbia raggiunto Dante, il quale, in quel periodo, si muoveva tra Arezzo, il Mugello e il Casentino. È più probabile che i Donati o i Riccomanni abbiano provveduto a sistemarla con i figli in qualche proprietà fuori Firenze e si siano fatti carico del loro sostentamento. Nulla di positivo sappiamo dei rapporti intercorsi fra Dante e la sua famiglia dopo quella data. Secondo Boccaccio, con la moglie non si incontrò più. Ma questa è una idea sua, tutta da dimostrare. Alcuni indizi, al contrario, inducono a credere che un paio di anni dopo la famiglia si sia, temporaneamente, ricongiunta.
Nella mischia
Dante entra subito in azione. Quasi certamente partecipa all’incontro di Gargonza, di sicuro alla formazione dell’Università dei Bianchi. Come i suoi compa...