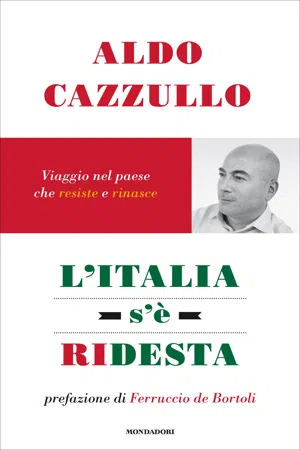![]()
Arrivo in città sotto la più grande nevicata degli ultimi dieci anni, e quasi non la trovo più.
Dov’è finita Bologna?
Dove sono finite le grandi famiglie dell’industria? I Gentili hanno venduto i saponi Panigal ai tedeschi, i Sassoli de’ Bianchi hanno venduto la Buton agli americani, i Goldoni hanno venduto agli inglesi, i Ferretti (barche) ai cinesi, i Gazzoni Frascara hanno venduto l’Idrolitina e le Dietorelle agli svizzeri; ma il caso più doloroso è quello dei Galletti, che hanno venduto la mortadella Alcisa ai modenesi. Ai Galletti resta però il ristorante Diana, tempio della borghesia cittadina, dove eredi delle varie casate, dopo aver investito in alloggi da affittare agli studenti, si ritrovano per il pranzo della domenica.
Dov’è finito l’arcivescovo di Bologna? Una volta c’era Giacomo Biffi, il Montanelli della Chiesa, il capo-ombra della destra cattolica. Poi arrivò Carlo Caffarra, moralista in senso tecnico, tempra da battaglia e mente sottile, capace di fustigare i costumi e di concepire un teorema per dimostrare l’immortalità dell’anima: la vita è una piramide, quella che noi vediamo è solo una delle facce, le altre appariranno quando arriveremo in vetta. Caffarra era partito forte, ha battagliato con Cofferati quand’era sindaco, si era ritagliato uno spazio nella vita pubblica, sembrava destinato a diventare uomo di punta della Chiesa italiana; a un tratto, è sparito. Ha scritto un libro con la principessa Alessandra Borghese, detta la Papessa. Ogni 4 ottobre commemora San Petronio, ogni 31 dicembre celebra un Te Deum in cui denuncia la decadenza della città, quindi si richiude nel silenzio. Ma è un uomo di valore, forse sta solo preparando il ritorno.
Dove sono finiti i cinema del centro di Bologna? I più grandi hanno chiuso: l’Arcobaleno di piazza Maggiore, il Metropolitan e l’Imperiale di via Indipendenza. Se non altro, al posto del cinema Ambasciatori c’è la libreria Coop, arrivata seconda al concorso dei negozi più belli al mondo (il vincitore è in Cina). Ma dell’Apollo hanno fatto un centro commerciale, dal Giardino, dal Marconi, dall’Adriano e dal Minerva hanno ricavato appartamenti, sempre da affittare a studenti; chiusi anche il Settebello, l’Olimpia, l’Embassy, il Fulgor; il Nosadella ha traslocato in periferia; il Fellini di viale XII Giugno ora è una sala scommesse.
Dove sono finite le fabbriche di Bologna? Chiusi i cantieri Fochi, chiuse le officine Casaralta. Chiusa la Moto Morini e la Malaguti, regge la Ducati – comprata dai tedeschi dell’Audi –, che però non è più la fabbrica di un tempo, dove lavoravano tante operaie da indurre William, leggendario macellaio dal collo taurino, ad aprire bottega ai cancelli; e ai colleghi, che gli chiedevano notizie, rispondeva: «Vedo passare ogni giorno settemila ragazze, vuoi che non ne abbia avute il dieci per cento?» (William non diceva esattamente «avute».)
A proposito: dove sono finiti i macellai di Bologna? Erano più di 700 all’apice del boom economico; ora sono meno di cento. Decimata una categoria importante nella storia di una città sanguigna e gaudente: beccai erano i Carracci, sublimi pittori; beccai erano i Bentivoglio, che quando divennero notai e signori di Bologna conservarono la bottega, per ricordare a se stessi da dove venivano. Simbolo di vigore e potere, la mercatura delle carni ha esercitato per secoli una primazia sulle altre, segnata anche dalle gesta erotiche; così, quando un macellaio confidò ai colleghi che la moglie lo tradiva con un fruttivendolo, venne espulso dalla categoria. Fu un sodale di William, Raffaellino, a motivare la sentenza: «Sono tre secoli che noi frequentiamo le mogli dei fruttivendoli, e finora non era mai accaduto il contrario!» (Raffaellino non disse esattamente «frequentiamo».) Quando nel 1999 uno di loro si candidò a interrompere 54 anni di governo comunista, un barone universitario disse che un ex macellaio con la licenza media non poteva fare il sindaco di Bologna. Il giorno dopo, Giorgio Guazzaloca fu travolto dall’abbraccio di artigiani e operai comunisti, che come lui non avevano potuto studiare.
Dov’è finita la Bologna della politica? Questa era la capitale dell’altra Italia, del partitone comunista. Poi è diventata il laboratorio dell’Ulivo, inventato da Nino Andreatta, costruito da Prodi e da Parisi. Ma il Partito democratico, almeno come lo sognavano Andreatta e suo figlio Filippo, non è mai nato o perlomeno ha perso le radici bolognesi. Gli intellettuali del Mulino litigano, hanno fatto fuori il direttore della rivista, Piero Ignazi. Per il resto, a Fini di bolognese resta solo l’accento, Casini torna qui la domenica per portare al Diana la madre e il fratello Federico, identico a lui. Non si riesce neppure a trovare un sindaco bolognese: Cofferati era di Cremona, Delbono di Mantova. Incappato in un brutto scandalo – la fidanzata segretaria, le missioni-vacanza in coppia, il bancomat finanziato dall’amico imprenditore –, si dimise dopo che le bolognesi sfilarono sotto il Comune con uno striscione definitivo: «Contro la crisi, bancomat per tutte». Adesso c’è Virginio Merola, da Santa Maria Capua Vetere, ma non è che finora abbia lasciato tracce; tanto meno quelle degli spartineve, che non si sono ancora visti.
Dove sono finiti i cantautori, gli artisti, gli intellettuali bolognesi? Qui avevano preso casa Gianna Nannini e Renato Zero, Antonio Albanese e Diego Abatantuono, Umberto Eco e Michele Serra: se ne sono andati tutti. Neppure Francesco Guccini abita più in via Paolo Fabbri 43, nel quartiere piccoloborghese della Cirenaica, accanto al vecchio pensionato del numero 45, cui dedicò una delle sue canzoni più malinconiche; e quando lo seppero, i vicini del numero 41 andarono a bussare a Guccini all’alba, badando a non essere visti, e gli sussurrarono: «Noi preferiremmo non comparire…». Per fortuna Bologna ha ancora un nume tutelare, uno spirito folletto che vive sui tetti, un genio del luogo che non la lascerà mai.
La prima cosa che faccio, quando arrivo a Bologna, è andare a trovare Lucio Dalla. Stamattina mi trascino a piedi sotto la neve dalla stazione a San Petronio, passo davanti ai bassorilievi di Jacopo della Quercia cui nessuno fa caso ma che Dalla ama e giustamente perché sono un capolavoro del Rinascimento italiano, giro a sinistra in via Massimo d’Azeglio e al numero 15 cerco il suo eteronimo sul campanello: «Commendator Domenico Sputo».
La casa di Lucio è in realtà fatta di molte case, una dentro l’altra. La stanza che preferisco è quella dove c’è un crocefisso ligneo inchiodato al soppalco. Si affaccia sui tetti di San Petronio, dove da ragazzo gli capitava di uscire, «per sentire gli odori dei mangiari e i discorsi della gente», e talora di addormentarsi (Dalla era abituato a dormire dappertutto. Arrivato a Roma, passava la notte sulle sedie dei bar di via Veneto, in tasca i soldi solo per il cappuccino che ordinava ai camerieri venuti a svegliarlo). Oggi è affettuoso, come sempre, ma non è del solito umore. La colpa non è della neve, che anzi gli mette allegria. È che deve andare a Sanremo, e non ne ha nessuna voglia.
Dalla detesta Sanremo. Soprattutto da quando vi è morto Luigi Tenco. Già solo nominargli il festival lo indispone. Tenco era suo vicino di stanza. Fu lui a dare l’allarme. Di quella notte dice di non ricordare quasi nulla, di non avere un’idea precisa di quanto sia accaduto. Spiega però che il suicidio era una possibilità che quelli come Tenco volevano sempre avere a portata di mano; non a caso giravano con la pistola. Il loro mito erano gli chansonniers francesi, poeti maledetti che cantavano il malamore, a cui di vivere o morire importava poco. Non a caso anche Gino Paoli si è sparato e da allora vive con un proiettile nel cuore. Lucio è molto legato a Paoli. Fu lui a suggerirgli di cantare, quando Dalla pensava solo a suonare. Invece non sopporta Celentano. E il pensiero di trovarlo a Sanremo non giova al suo umore.
È stata decisiva l’insistenza di un amico di giovinezza: Gianni Morandi. Mi racconta Lucio che andavano insieme tutte le domeniche allo stadio, a tifare per il Bologna. Ma lo spareggio del 1964 contro la Grande Inter si giocò a Roma, e loro non avevano i soldi per andarci. Così accesero la radio davanti a una parete bianca, immaginando di proiettare la partita sul muro. «Quando segnò Fogli, dalle finestre aperte arrivò il grido di 400 mila persone, il grido della città.»
Stamattina la città è muta. I pochi rumori salgono come soffocati dalla neve. Non ci sono neppure i musicisti di strada che tradizionalmente suonano sotto casa di Dalla, da quando lui reclutò un gruppo per un concerto. I ragazzi che stazionano in via D’Azeglio negli ultimi tempi sono molto cambiati. Non assomigliano più ai barboni romantici di Piazza Grande. Piuttosto, a quelli disperati di Com’è profondo il mare: «Siamo i gatti neri, / siamo pessimisti, / siamo i cattivi pensieri / e non abbiamo da mangiare».
Dalla però non è pessimista su Bologna. Dice che la situazione attuale gli ricorda la guerra impari eppure vittoriosa contro l’imperatore Federico II, «quando Rolandino de’ Passeggeri, che non era un condottiero ma il capo dei glossatori, oggi diremmo i filologi, arringò la città e la portò al trionfo nella battaglia di Fossalta». Mi racconta cose che non scriverò nell’articolo, ma mi restano impresse. «Guarda che l’Italia non è messa affatto male. Anzi, sono convinto che siamo alla vigilia di un nuovo Rinascimento. Sta cambiando tutto. Anche in politica. Questo governo di solidarietà nazionale ci farà bene. Bisogna andare oltre la conflittualità esasperata di questi anni. Accendi la tv. Quella insulsa, cinica, volgare, perde spettatori ogni giorno, non la guarda quasi più nessuno. Apri i giornali. Quelli aggressivi, isterici, pieni di insulti, che fino a poco tempo fa sembrava conducessero le danze, non contano più nulla. Come fai a non vedere i segni del nuovo? La gente diventa più attenta, va in profondità, è sensibile alla bellezza. Ci attendono anni di grande spiritualità, di fede. Non di religione; di fede.»
Mi fa riascoltare la canzone che porterà a Sanremo. L’ha scritta Pierdavide Carone, racconta di un ragazzo che ama una prostituta ma ne è respinto. L’avevo sentita già il mese scorso, nella cantina medievale che Dalla usa come studio di registrazione. C’erano anche i musicisti di Marta sui tubi, il gruppo indie prodotto da Lucio. Poi siamo andati a teatro, all’Arena del Sole, dove Dalla ha aperto la rappresentazione di Viva l’Italia! con una sua versione dell’inno di Mameli che ha emozionato molto i bolognesi. Lo ringrazio ancora per quel regalo che mi ha fatto. Mi risponde che non aveva mai cantato l’inno in pubblico, è stato felice di farlo nella sua città.
Mi accompagna alla porta. C’è anche Marco Alemanno, che vive con lui. I ragazzi della troupe che hanno filmato l’intervista sono felici di averlo conosciuto, Claudia trova il coraggio di dirgli che Cara è la sua canzone preferita: «Conosco un posto nel mio cuore / dove tira sempre il vento / per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. / … Almeno non ti avessi incontrato / io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato». Ci abbracciamo. Lucio è piccolo, mi devo chinare per baciarlo sulle guance. Ha una barbetta ispida, che punge. Non crederei mai se qualcuno mi dicesse che è stata l’ultima volta che l’ho visto.
L’appuntamento è al museo della città. Ipertecnologico, appena inaugurato. L’ha voluto lui, l’uomo più potente di Bologna. Gli amici, i colleghi, i professori dell’università mi hanno confermato che qui, ora che Prodi ha respinto la tentazione di fare il sindaco, comandano sempre i soliti due: Vasco Errani, presidente della Regione, molto legato alle cooperative, in particolare a quella del fratello; e Fabio Roversi Monaco, presidente della Fondazione Carisbo. Quindi c’è da preoccuparsi se Roversi Monaco, interrogato sulla sua Bologna, parla di «decadenza comoda».
Nato nel 1938 a Addis Abeba, figlio del governatore della regione di Sabbatà, per strada viene fermato da parroci che gli chiedono di restaurare anche la loro chiesa, come ha fatto con San Colombano e con il Compianto di Niccolò dell’Arca, lo splendido gruppo in terracotta con le Marie che piangono il Cristo.
Spiega Roversi Monaco che i due veri punti di forza sono l’università e la Fiera. Lui è stato rettore dell’università per 15 anni e presidente della Fiera sino a sei mesi fa, e ammette che le cose non vanno benissimo: la città resta ricca, ma ancora non s’accorge del ridimensionamento. Biffi la definiva «sazia e disperata»; ora non è neppure così sazia. I mitici asili nido costano fino a 575 euro al mese, come collegi svizzeri; la metropolitana non si è fatta, e 49 bus «intelligenti» Civis, pagati e mai usati, languono nei depositi. Della Fiera si parla sui giornali per l’arte, che riguarda poche centinaia di mercanti e galleristi (nel 2012, cinquanta in meno), e per il Motorshow, detestato dai bolognesi perché porta il turismo del sacco a pelo. I soldi si fanno con le fiere dei cosmetici – Bologna è la prima città d’Italia per consumo di profumi –, delle piastrelle (Cersaie) e dell’edilizia (Saie); ma la concorrenza di Milano si fa sentire. A Milano (e a Torino) sono già finite le storiche banche bolognesi: la Carisbo a Intesa, il Credito Romagnolo a Unicredit.
L’università con i suoi 83 mila iscritti regge, impoverita però dai tagli e dal meccanismo di cooptazione, che non produce più scuole come quella di economia: Caffè, Andreatta, Sylos Labini, Prodi, Quadrio Curzio. Soprattutto, Bologna ha divorziato dai suoi studenti. Lo si vide nei giorni dell’assassinio di Marco Biagi, quando i neolaureati non interruppero il rito delle corone d’alloro e del pranzo con i parenti. Lo si è visto quando i centri sociali hanno contestato la laurea a Napolitano.
Erano gli studenti del gruppo Bartleby, gli anarchici di Fuori Luogo, gli arrabbiati che occupano l’aula C di Scienze politiche, i duri del Crash, i dialoganti del teatro Tpo. Vado a trovare, sempre sotto la neve, quelli di Bartleby, che vivono in una vecchia stazione della Croce Rossa ribattezzata come lo scrivano di Melville, quello che diceva «preferirei di no», dove custodiscono la collezione di riviste letterarie del poeta Roberto Roversi. Per strada non c’è nessuno, solo un fruttivendolo pachistano. Inutile chiedere indicazioni a lui: è a Bologna soltanto a vendere frutta. Dalle vie dei pachistani di solito clochard e punk girano al largo, perché «quelli menano».
I ragazzi di Bartleby raccontano ciò che si legge sugli annunci immobiliari: non si trova un letto a meno di 400 euro, una stanza a meno di 500, un monolocale a meno di 600; mangiare in mensa costa sette euro, come a Montecitorio; e la città li guarda di malocchio, ricambiata. Da campus urbano, quali erano, i portici di via Zamboni e di piazza Verdi sono diventati luogo di spaccio, scippo, o anche semplicemente insulti e sguardi aggrottati.
Bologna non era solo la capitale dell’altra Italia, comunista. Rappresentava anche il sogno di una città laboriosa come Milano e calorosa come Napoli. Il crocevia d’Italia: l’Appennino che comincia subito fuori Porta Saragozza, il Mediterraneo in fondo alla via Emilia. Il degrado dei rapporti umani si tocca con mano, come altrove, ma qui è più doloroso vedere il motociclista puntare il pedone passato col rosso, notare lo sguardo avido del bottegaio in attesa dietro l’insegna «compro oro».
Questo non significa che Bologna sia diventata una città qualsiasi. Anche nei giorni della grande gelata, i bolognesi li trovavi per strada, anche un po’ più sorridenti del solito, qualcuno con gli sci di fondo, altri a tirarsi palle di neve sugli scalini di San Petronio. Un professore o ricercatore universitario ogni cento abitanti, i grandi collezionisti d’arte come gli Enriquez e i Golinelli, 250 comitati pro o contro qualcosa, una vita culturale e artistica che può tornare tra le più ricche d’Europa e ogni tanto consegna alla scena nazionale uno Stefano Benni, un Freak Antoni, un Alessandro Bergonzoni.
Passati gli azzardi di Consorte, Unipol e le Coop tentano di creare con Premafin il secondo gruppo assicurativo del paese. Ci sono famiglie e fabbriche che resistono, per esempio nel settore del packaging: i Vacchi, i Marchesini, i Seragnoli, che impacchettano sigarette e finanziano il centro per i malati terminali. I Maccaferri esplorano le energie alternative, la Datalogic di Romano Volta ha il business dei codici a barre, un ramo dei Sassoli de’ Bianchi si è inventato la Valsoia. Persino Bergonzoni, il grande affabulatore, ha una fabbrica, dove passa due pomeriggi la settimana.
Bergonzoni abita in un loft in via del Pratello, la strada delle prostitute e dei tiratardi. Apre una bottiglia di lambrusco, affetta mortadella e parmigiano, e parla, parla, parla. Della tournée teatrale e degli ingranaggi che produce, delle sue opere d’arte contemporanea e dei suoi cinquanta operai, del padre e della domanda di viti che è in forte ripresa, «dopo qualche anno difficile ora scoppiamo di lavoro». Poi esce a passeggio, si diverte davanti alla statua di Ugo Bassi – sacerdote e martire del Risorgimento – coperta di neve, si inoltra per i vicoli, dove a conoscere i percorsi giusti puoi ritrovarti perfettamente solo, senza un passante, tanto meno un turista.
Bologna non è una città turistica. Ma dovrebbe diventarlo, a maggior ragione adesso che è a mezz’ora di treno da Firenze. Dopo i restauri di conventi, affreschi, palazzi, assomiglia sempre più alla definizione che ne diede Pasolini: «La città più bella d’Italia». Pasolini era di parte: Bologna era la città di suo padre, il tenente Carlo Alberto Pasolini, che il 31 ottobre 1926 fermò la mano di Anteo Zamboni, anarchico quindicenne che stava sparando su Mussolini e fu linciato dai fascisti. Certo Bologna, nonostante i bombardamenti e le ricostruzioni, è la città italiana che ha conservato meglio l’impianto medievale, e un poco l’antica arte di vivere, che contempla anche la pietà e la speranza. Quando la moglie del macellaio Raffaellino si ammalò di Parkinson, anche lui si fece ricoverare con un sotterfugio al Giovanni XIII, e passò gli ultimi dieci anni a espiare le proprie colpe e tenerle le mani. E mi piace pensare che da qualche parte ci siano ancora oggi due ragazzi che ascoltano le partite del Bologna immaginando di proiettarle contro un muro bianco, e che un giorno diventeranno Dalla e Morandi.
Il display del telefonino segnala che mi cerca Armando Nanni, il direttore del «Corriere» di Bologna. Un bravo giornalista, un caro amico. Mi fa piacere sen...