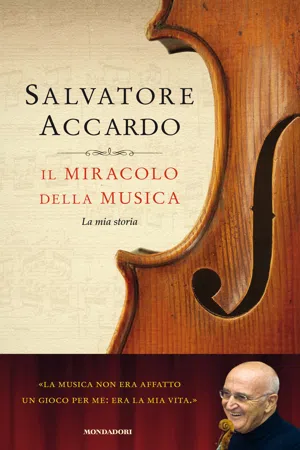![]()
Se penso alla mia vita mi sento di paragonarla a un rondò. In musica, il rondò è la ripetizione dello stesso tema molte volte. E in fondo la mia esistenza, fin dai primi anni, è stata così: albergo, prove, concerto, viaggio, albergo... Ma come è nella musica, il rondò della vita è una ripetizione che non deve essere mai davvero uguale perché altrimenti è finita. Il miracolo della musica è proprio questo. Puoi suonare il Concerto per violino e orchestra di Beethoven tutte le sere, centinaia di volte, e sarà sempre diverso. Lo sarà per tante ragioni: perché tu sei diverso, l’orchestra che suona con te è diversa, la sala è diversa o lo è il pubblico. La stessa partitura cambia molto da un’esecuzione all’altra. E le migliori interpretazioni non avvengono mai in privato, a casa, bensì in contatto con il pubblico. A casa, sei tu solo: suoni, provi, ma non è lì che farai la grande esecuzione. Essa nasce dall’emozione e l’emozione è qualcosa che scaturisce da te ma anche dal pubblico che ti ascolta. Quindi c’è uno scambio di energia, di amore, di tutto. Anche di disperazione, talvolta. Per questo un’esecuzione non sarà mai uguale all’altra. Ho sentito musicisti affermare il contrario. Mi dispiace per loro. Soprattutto se, a sostenerlo, è un musicista celebre. La musica è veramente un’alchimia, un miracolo.
Come ho detto, dopo aver vinto il concorso di Ginevra nel 1956, e soprattutto dopo il premio Paganini, iniziai a viaggiare per tenere concerti. Ma anche per frequentare corsi di perfezionamento. Fin dai primi anni che seguirono il diploma al conservatorio cominciai a frequentare le lezioni dell’Accademia Chigiana a Siena. L’idea di D’Ambrosio era di farmi studiare con George Enescu, che all’epoca era considerato un insegnante straordinario, ma non solo. Era anche un eccezionale musicista perché, oltre che violinista, era pianista, compositore e direttore d’orchestra. Enescu aveva origini rumene ed era uno dei docenti più richiesti: perfezionarmi con lui sarebbe stato il massimo cui potessi ambire.
Purtroppo, però, Enescu morì nel maggio 1955, proprio prima che io andassi a Siena. Ma, a quel punto, avevo già fatto tutte le domande e compilato i moduli per frequentare i corsi. Il conte Chigi Saracini, mecenate dell’Accademia, dopo avermi ascoltato mi aveva iscritto ad honorem alle lezioni e sarebbe stato stupido non cogliere quell’opportunità. Così il mio maestro disse, senza troppa convinzione: «Vai lo stesso, vediamo chi ci sarà al posto di Enescu». Ebbi una doppia fortuna. In primo luogo perché, al suo posto, c’era la sua assistente, Yvonne Astruc, una musicista notevole, soprattutto per la conoscenza della musica francese. La Astruc, in quanto sua assistente, aveva naturalmente tutte le diteggiature di Enescu, le sue indicazioni sulle arcate e il resto dei suoi appunti. Quindi, in un certo qual modo, le idee del grande musicista sull’approccio al repertorio le ho apprese comunque. E in secondo luogo perché, prima di iniziare con lei, ebbi un altro insegnante: Nathan Milstein, uno dei violinisti più talentuosi di tutti i tempi. Teneva un seminario di una settimana. Quindi le prime lezioni me le impartì proprio Milstein, con la Astruc presente come osservatrice.
Ero un ragazzino di quattordici anni e passare da D’Ambrosio a Milstein era per me un sogno. Ma non ero impacciato o timido, anzi, ho sempre avuto una voglia enorme di suonare per grandi musicisti. Incontrarlo e poterlo fare per lui fu importantissimo. L’aspetto curioso è che, quando lo vidi per la prima volta a Siena, rimasi colpito da un certo profumo (credo fosse un tipo di legno) che pervadeva la stanza dove teneva lezione. Lo stesso profumo lo sento sempre quando parlo di lui. La mente funziona con processi formidabili. Di recente un mio allievo mi ha raccontato che gli è capitato un fatto simile. Avevamo preparato insieme il Concerto di Mendelssohn, che lui avrebbe poi suonato in Germania. Durante la preparazione nel mio studio, gli indicavo certe correzioni e gli raccomandavo alcuni passaggi. Dopo il concerto, mi ha chiamato dalla Germania: «Maestro, quando sono arrivato al punto dove lei mi diceva sempre di fare attenzione, ho sentito il profumo del suo studio». È così, ci sono collegamenti anche olfattivi che ci rimangono dentro. Come era successo a me con Milstein: quel profumo di legno mi si è insinuato, indelebile, nella memoria.
Da allora sono tornato a Siena ogni estate, prima come allievo e poi, dal 1972, come insegnante. All’Accademia Chigiana un tempo i corsi estivi erano molto lunghi, duravano due mesi, tutto luglio e agosto. Ma l’aspetto interessante era l’opportunità di incontrare i numerosi musicisti che frequentavano l’Accademia. Tanto per fare qualche nome, i docenti erano Andrés Segovia (chitarra), Pablo Casals (violoncello), André-Nicolas Navarra (violoncello) e Alfred Cortot (piano) che teneva dei seminari speciali su Chopin. L’insegnante in carica di pianoforte era Guido Agosti, un eccellente didatta; per la direzione d’orchestra ci fu prima Carlo Zecchi, poi Sergiu Celibidache. E Nicanor Zabaleta per l’arpa. I migliori musicisti di quell’epoca si raccoglievano lì.
Il fatto di incontrarli, di trascorrere due mesi a contatto con loro ha creato amicizie che sono poi durate nel tempo. A raccontarlo ora sembra una vacanza. E di fatto, dopo i corsi, la sera ci si vedeva tutti al Fonte Gaia, un bar della città, per un caffè o per bere qualcosa, e si parlava. Non solo con gli insegnanti, ma anche con gli allievi che, come me, si formavano in quegli anni. E gli altri studenti si chiamavano Claudio Abbado, Zubin Mehta, Daniel Barenboim, John Williams e Charles Dutoit. Ci ritrovavamo tutti lì, d’estate.
Sono esperienze, queste, che non si possono dimenticare. Tanto per dare un’idea dell’atmosfera che si respirava, ricordo che un anno, per il saggio organizzato al termine del corso di direzione d’orchestra della classe di Zecchi, Abbado diresse una Suite di Bach, Mehta un tempo della Prima sinfonia di Brahms, Barenboim l’Ouverture dall’Egmont di Beethoven, e io suonai il Terzo concerto di Mozart. A Siena hanno ancora la locandina. Allora era solo un saggio ma, sapendo dove saremmo arrivati, fa una certa impressione...
Siena è stata davvero una tappa fondamentale. Prima di arrivarci ero un ragazzo che suonava il violino piuttosto bene, ma è lì che sono diventato un musicista. Anche perché ho cominciato a fare musica da camera sul serio; prima avevo suonato qualcosa in conservatorio, ma a Siena seguii proprio il corso specifico con Riccardo Brengola. Lui insegnava insieme ad altri colleghi del Quintetto Chigiano, famoso negli anni Quaranta-Sessanta. Nella musica da camera, ogni musicista suona in modo individuale: è raro che due diversi strumenti procedano all’unisono. Eppure, quelli coinvolti dalla partitura dialogano fra loro, perciò la difficoltà sta proprio nel non prevaricare. Brengola è stato un docente fantastico perché mi ha fatto capire, anzitutto, come si suona, ascoltando, questo genere di musica (non è come esercitarsi da solo a casa o con il maestro), come si danno gli attacchi (in modo che ogni strumento inizi a suonare al momento giusto). È così che, partendo da diverse individualità (musicali e umane) si forma un gruppo omogeneo. Che è un fatto fondamentale quando si suona. Non basta eseguire bene una parte: se non si sa ascoltare, si rischia di compromettere il lavoro degli altri. E anche il proprio. Facendo musica da camera, ti rendi conto che la tua liberà finisce dove comincia la libertà di chi suona con te. Questa è la vera democrazia.
Le nostre giornate estive erano molto fitte di impegni. Fin dalla mattina si tenevano le lezioni, perché c’erano molte classi. Le mie, di violino, erano sempre nel pomeriggio, tre volte la settimana. Nel tempo libero, andavo a sentire altri corsi. Era fantastico avere l’opportunità di ascoltare gli insegnamenti di Casals, piuttosto che quelli di Celibidache o di Cortot.
È interessante sapere come è nata l’Accademia Chigiana. Essa è opera di un mecenate, il conte Guido Chigi Saracini (lo stesso che nel 1955 mi ammise ai corsi), che aveva una bellissima residenza, divenuta poi sede dell’Accademia: un palazzo spettacolare, con decine di stanze. Come molti senesi, il conte non viaggiava volentieri, preferiva starsene in città. Si narra che non si fosse mai recato neppure a Firenze. Però amava talmente la musica che un giorno decise: «Invece di andare a sentire tutti questi musicisti in giro per il mondo, li farò venire qui da me». E così, dal 1932, per due mesi all’anno iniziò a circondarsi di grandi artisti.
Io andai all’Accademia la prima volta negli anni Cinquanta. E di lì erano già passati, in qualità di docenti, mostri sacri come il pianista Alfredo Casella e il violinista Arrigo Serato. Che poi sono gli stessi musicisti che mio padre aveva conosciuto durante la sua famosa crociera. Vi passò anche Antonio Guarnieri, un direttore d’orchestra pari a Toscanini. Il conte, oltre ai musicisti, invitava personaggi famosi che amavano molto la musica. Per esempio, la regina Elisabetta del Belgio, madre di Maria José. Sua maestà arrivava ogni estate e si trasferiva in casa del conte per due mesi interi. Ricordo di aver suonato un po’ di musica da camera con lei, perché Elisabetta aveva studiato il violino, a livello amatoriale, con un famoso artista belga, Eugène Ysaÿe. In realtà, si narra anche che fra loro fosse nato un rapporto non prettamente musicale. Ma è un pettegolezzo non verificabile. Comunque sia, la regina veniva ogni anno, si piazzava a Siena e seguiva tutte le lezioni. E con noi allievi faceva un po’ di musica da camera. Mi ricordo un’esibizione con lei, Brengola, altri insegnanti e studenti. Confesso che anche conoscere questi personaggi non appartenenti alla cerchia dei musicisti è stato speciale; nel complesso, era una realtà stimolante.
Il conte è morto nel 1965, ma è rimasta la Fondazione Chigiana che in seguito fu rilevata dal Monte dei Paschi di Siena, garantendo che tutto questo mondo non sparisse. Oggi, ovviamente, c’è un direttore artistico (il mio caro amico Aldo Bennici), affiancato da varie altre persone, mentre prima in pratica c’era solo il conte che faceva e decideva tutto da solo. Anche ora l’Accademia è aperta soltanto d’estate, per due mesi: i corsi, però, sono diventati molto più numerosi e durano di meno. E si sono aggiunte le lezioni per gli strumenti a fiato (flauto e clarinetto). Adesso che sono aumentate le classi, può accadere anche che ci siano corsi dello stesso strumento tenuti da docenti diversi: tre settimane uno, tre settimane un altro, e un allievo può seguire più di un docente o cambiarlo. È un peccato non avere più corsi così lunghi, ma i tempi sono mutati. Negli anni Cinquanta, per esempio, non c’erano tutti i vari festival estivi, e i musicisti non erano impegnati nei mesi di luglio e agosto. Allora, l’estate equivaleva a mesi di «libertà».
Lezioni di musica, ma soprattutto lezioni di vita. Questo è stato il mio percorso professionale, dai primi passi ai corsi di specializzazione. Fu proprio a Siena, in piazza del Campo, luogo d’incontro di noi ragazzi, che conobbi Claudio Abbado. Allora non ci si immaginava ancora cosa sarebbe diventato, ma già si capiva che quel giovane era dotato di grande talento. Come Daniel Barenboim, che fra l’altro era un pianista eccezionale, suonava bene già a dodici anni. Quando lo conobbi, Barenboim incominciava a dirigere. Iniziò proprio con Carlo Zecchi. Daniel ha un anno meno di me, ma già allora era un fenomeno, in tutti i sensi. Claudio, invece, a quell’epoca aveva più di vent’anni, perché è del 1933, e Zubin Mehta lo stesso. L’età media di chi frequentava i corsi era questa: noi così giovani eravamo un po’ delle eccezioni. C’era il diciannovenne John Williams, il chitarrista allievo di Segovia, poi diventato direttore d’orchestra (ha lavorato anche con il regista Steven Spielberg per alcune colonne sonore).
Del nostro gruppo faceva parte anche Charles Dutoit che suonava la viola, divenuto poi, lui pure, direttore d’orchestra. Ma questo, naturalmente, sarebbe accaduto molto tempo dopo. Dutoit venne per frequentare il corso di musica da camera. Chi non è mai venuto a Siena, invece, è Riccardo Muti, unica eccezione. Venne Martha Argerich, ma non subito. Anche Maurizio Pollini era dei nostri, sebbene si aggiungesse molto tardi per dei seminari sulla musica di Arnold Schönberg. Insomma, diciamo che dall’Accademia Chigiana sono passati tutti i cosiddetti grandi musicisti del nostro tempo.
Lì, inoltre, ho conosciuto quello che per anni hanno cercato di fare passare come il mio grande rivale: Uto Ughi. Perché in Italia bisogna sempre ricreare le dinamiche Coppi-contro-Bartali, se no sembra che non ci possa essere interesse per un’arte o uno sport. Così sono nate le antinomie Abbado-Muti e Accardo-Ughi. Invece, niente di tutto questo. A parte il fatto che la musica non è una manifestazione sportiva, non ha alcun senso creare rivalità. Uto e io siamo due musicisti del tutto diversi e nel mondo c’è posto per entrambi, fortunatamente. E poi, come se ci fossimo solo noi due! È pieno, di violinisti... Il miracolo nella nostra arte è proprio questo: puoi fare musica in modo diverso, emozionando in modo diverso.
Uto è più giovane di me, ha un paio di anni in meno, perché è nato nel 1944. Ci siamo conosciuti in Accademia, nella classe di Yvonne Astruc. Uto studiava lì da prima ancora che arrivassi io, con Enescu, di cui aveva seguito le lezioni anche a Parigi. Quando lo conobbi aveva solo dieci anni ed era un vero prodigio. Ci siamo sentiti subito affini, perché eravamo i più giovani violinisti dell’Accademia. Lui era accompagnato da suo padre, io da mia madre. Siamo diventati presto amici e abbiamo fatto gli studi a Siena insieme.
Nel corso degli anni, poi, ci siamo incontrati tantissime volte. Ma una delle più importanti è stata quando abbiamo tenuto un concerto insieme a Roma, per beneficenza. Era il 1993 ed era un evento a favore dei bambini della Bosnia e della Croazia, organizzato dal «Messaggero» in collaborazione con la Croce Rossa. Avevamo definito la nostra partecipazione «Una goccia nel mare di ciò che non si fa», però gli incassi di quella serata furono di circa 100 milioni di lire. Per l’occasione abbiamo suonato con l’Orchestra di Santa Cecilia i concerti di Vivaldi e Bach per due violini e ho diretto la Quarta sinfonia di Beethoven. Da quell’esecuzione, fra l’altro, è nato un bellissimo disco. Altre volte abbiamo suonato insieme, sempre a Siena: i concerti di Vivaldi per tre violini, quattro violini, poi dei sestetti di Brahms. E a Napoli, al San Carlo, dove io ho suonato la viola (uno strumento che adoro) nella Sinfonia concertante di Mozart. Parecchia musica, insomma. Ma a differenza di me, Uto non è molto attratto dalla musica da camera. Ovviamente la fa, però lui è soprattutto un solista. Devo ammettere che, senza dubbio, è uno dei più straordinari talenti che abbia mai conosciuto.
Mi ricordo che, a dieci anni, suonava già in modo esemplare la Chaconne di Bach, che è una composizione di notevole difficoltà tecnica e interpretativa.
A Siena non sono nati solo rapporti professionali importanti, ma anche vere amicizie. Come quella con Abbado, con cui ho praticamente girato il mondo e che, negli anni, ho avuto modo di conoscere anche al di là della musica. Ma le vacanze insieme sono arrivate più avanti nel tempo. Ho suonato con lui in tournée negli Stati Uniti e in tutta Europa, dalla Francia alla Gran Bretagna alla Germania. Ho tantissimi ricordi professionali, sia con lui sia con Zubin Mehta. Anche con Barenboim ci siamo incontrati spesso a Londra e persino in Israele.
Insomma, ci sono amicizie che sono eterne. Soprattutto nell’ambiente della musica: puoi non vederti per qualche anno, perché succede, se non si lavora insieme; capita che uno stia da una parte del mondo e uno dall’altra, però se i rapporti sono speciali, appena ti ritrovi è come se ti fossi lasciato ieri. Le vere amicizie sono così. Per noi poi c’è, in più, il legame della musica, che è un legame diverso da tutti gli altri. È indissolubile, ti tiene insieme per la vita. A unirci c’è anche il modo di affrontare le partiture, comune a noi musicisti di quella generazione. Perché prima di noi c’è stato un periodo, «romanticissimo», dai primi anni del Novecento fino agli anni Sessanta, in cui si affrontavano le partiture in modo completamente diverso, cambiando i coloriti, le articolazioni, anche le note, ed effettuando numerosi tagli.
Infatti, la nostra generazione, specializzatasi negli anni Cinquanta, si è distinta proprio per l’interesse e l’impegno dimostrati nel volere tornare alle origini, nel risalire alla partitura originale. Questa volontà si è concretizzata negli anni Sessanta, e anche noi abbiamo dato il nostro contributo, cercando di interpretare la musica in modo diverso. Alla base del nostro lavoro di ricerca ci fu la presa di coscienza che ogni trascrizione di un pezzo musicale aveva aggiunto elementi alla partitura originale: volontariamente quanto alle indicazioni su come interpretare l’opera, meno intenzionalmente nel caso di errori di scrittura (capitavano perfino casi di note diverse, da una partitura all’altra); per cui a un certo punto la curiosità di vedere il testo originario diventò una necessità. Riscoprire l’Urtext, come si dice in gergo, significava emendare i molti errori commessi nel corso del tempo e che si erano accumulati nelle varie edizioni. Per esempio, ogni revisione contiene diverse diteggiature e soluzioni tecniche. Ma non sono quelle del compositore, appartengono a chi lo ha interpretato in un momento successivo.
A difesa dei musicisti che ci avevano preceduto bisogna dire che, durante le due guerre mondiali, non doveva essere facile recuperare i manoscritti originali. Però il rispetto della tradizione legata ai concertisti venuti prima di noi rischiava di trasformarsi in una gabbia, imprigionando la nostra espressività. Milstein diceva: «La tradizione è la morte della musica». Aveva ragione, nel senso che, se ci si basa solo sulla tradizione (cioè su quello che è avvenuto prima) sostenendo che, per esempio, sui Capricci di Paganini bisogna eseguire un fraseggio di un certo genere o affermando che esiste solo una determinata interpretazione, tutti andranno avanti con lo stesso tipo di fraseggio e di tradizione. Invece, per mantenere viva la musica, bisogna cercare anche il nuovo, insito fra le note scritte duecento anni fa. E per trovarlo, questo nuovo, bisogna andare molto indietro, oltre quello che ti ha insegnato la tradizione.
Io sono profondamente convinto che, se certi musicisti avessero avuto la possibilità di reperire i manoscritti o le edizioni originali, lavorando sulle partiture Urtext, avrebbero iniziato sicuramente prima ad affrontare la musica in modo più fedele. L’onestà di un esecutore consiste proprio nel far capire quello che ha scritto l’autore e dunque nel non stravolgere i testi. La nostra ricerca ha portato buoni risultati e oggi anche i concorsi più prestigiosi o le più ambite masterclass (lezioni collettive in cui un maestro si mette a disposizione degli allievi) chiedono ai candidati di studiare sugli spartiti originali. A questo proposito ricordo un aneddoto molto divertente. In classe, a Cremona, una mia allieva, dopo alcune osservazioni sul fatto che non rispettava il testo, mi disse che lei non voleva suonare come tutti gli altri. Al che le feci notare che, se avesse suonato esattamente come era scritto, sarebbe stata l’unica al mondo.
Le lezioni senesi estive erano una boccata d’aria fresca e l’occasione per ritemprarmi dopo aver viaggiato, fra tournée e impegni vari, per il resto dell’anno. Dopo essermi fatto conoscere con i primi concerti, fin dagli anni Cinquanta iniziai a spostarmi fuori dell’Italia, in Europa e anche oltreoceano, entrando così in contatto con importanti musicisti internazionali. Non mi stancherò mai di dire che questo tipo di incontri sono vitali per un musicista. Certo, l’insegnante con cui si studia è fondamentale per acquisire la padronanza tecnica, per capire quanta serietà e intransigenza si debbano usare quando si affronta una partitura. Però quello che poi ti fa davvero crescere e fa di te un musicista completo sono gli incontri con i colleghi e non necessariamente solo quelli che suonano il tuo strumento. Io ho imparato moltissimo da tutti, per esempio da Michelangeli, Segovia, Casals, Celibidache, Giulini... Uno dei primi «grandi» che conobbi, al di fuori dei corsi di perfezionamento, fu Ojstrach. Come ho detto, per me lui è stato un punto di riferimento e il tempo passato insieme mi ha formato molto più di tante preziose lezioni.
Lo incontrai nel 1958, avevo appena vinto il premio Paganini. Ojstrach venne a fare una tournée in Italia che prevedeva una serata alla sala Scarlatti del conservatorio di Napoli. Io ovviamente andai e, subito dopo il concerto, mi presentai: «Sono un violinista, ho vinto il Paganini». E lui, con mio stupore, mi disse che aveva già sentito parlare di me: «È stato Brengola». Il violinista sovietico aveva conosciuto Riccardo Brengola a Bruxelles, in occasione del Concorso musicale Regina Elisabetta del Belgio (organizzato dalla regina Elisabetta che avevo conosciuto a Siena). La prima edizione del premio risale al 1951 ed era per soli violinisti. Ma le competi...