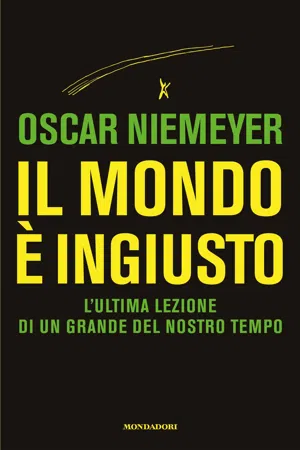![]()
Salendo lentamente a piedi la Rua das Laranjeiras, la “strada degli aranci”, un’alberata promenade un po’ aristocratica e un po’ slabbrata, e a Rio può capitare spesso, a un certo punto è bene prestare attenzione sulla destra a una piccola apertura tra due vecchie case.
È un vicolo, attraverso cui si accede a una corte, e che a prima vista assomiglia a uno scenario falso.
Si chiama Largo do Boticário. E si capisce subito che qui si è consumato un abbandono: antica architettura coloniale quasi cancellata dal tempo. Circa dieci case formano quella che sembra proprio la corte di una capitaneria portoghese del XVIII secolo. Il suo nome si deve al boticário, il dentista Joaquim Luís da Silva Souto, incaricato di curare le bocche della famiglia reale portoghese, e che qui abitava, in una fazenda che ormai non c’è più. L’atmosfera bucolica però è rimasta. Intorno c’è solo verde: manghi, jacas, palme, flamboyant. A terra, sampietrini mal messi, sulle facciate delle case resistono pochi azulejos originali, le ceramiche portoghesi con i loro disegni blu su bianco, inconfondibili. Nel centro della piazza c’è un pozzo e, porgendo l’orecchio, si può avvertire un torrente, che non si vede. E dov’è? Passa sotto. Bisogna affacciarsi su una specie di roggia ed eccolo, esiguo, immerso nell’ombra.
È il fiume Carioca. Che scende dalla foresta, s’inabissa da qualche parte e qui si lascia scorgere solo per un attimo. Nel Cinquecento dava da bere a tutta la città: il nome gliel’avevano messo gli indios Tamoios, e significa “casa del cascudo”: un pesce dalle dure squame argento, simili all’armatura dei conquistatori lusitani. E dunque significava anche: casa dei portoghesi.
E così, non la spiaggia di Ipanema, non il Pan di Zucchero, non la Lapa con i suoi bar consacrati al samba, ma questo è il cuore di Rio, qui è nato tutto. Qui sono nati i carioca.
E qui, nel dicembre del 1907, è venuto al mondo Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares. Suo nonno possedeva una di queste case coloniali della Rua das Laranjeiras con le iniziali di famiglia sulla facciata, grandi finestre quadrate e i mandorli nel giardino. Famiglia numerosa, tradizionale. In quel giardino, Niemeyer disegnava senza matita e senza foglio; disegnava il paesaggio che aveva intorno.
L’amore per il disegno lo ha portato naturalmente all’architettura. Nel 1932 entra nel gruppo di lavoro di Lucio Costa, il più apprezzato architetto e urbanista brasiliano di quegli anni: è un cenacolo dove, oltre al lavoro, vengono discusse e analizzate le idee che dominano l’epoca, cioè l’International Style. Ed è in seno a quel gruppo che, nel 1936, il giovane Oscar stringe la mano per la prima volta a Le Corbusier, il maestro svizzero del Movimento Moderno, che a Rio era già arrivato nel 1929 per contribuire al nuovo piano urbanistico della città e alla costruzione della sede del ministero dell’Educazione.
Per un architetto della generazione di Niemeyer (in Italia potremmo prendere come esempio Gio Ponti, classe 1891), Le Corbusier è il catechismo. Ma non è il solo: c’è una costellazione di pianeti che fondano la base dell’architettura moderna, e sono i tedeschi Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) e Walter Gropius (1883-1969) e certamente l’americano Frank Lloyd Wright (1867-1959). del quale quasi chiunque ha ammirato almeno una volta la celebre “casa sulla cascata”. Ma c’è anche un finlandese, ed è nato solo nove anni prima di Oscar Niemeyer, vale a dire Hugo Alvar Henrik Aalto, più noto semplicemente come Alvar Aalto (1898-1976).
Se lo storico Eric J. Hobsbawm si fosse ispirato alla vita di Niemeyer per il titolo del suo saggio più celebre, quello sul Novecento, non lo avrebbe certo intitolato Il Secolo breve, bensì, al contrario, “il Secolo lungo”. Niemeyer raccoglie l’eredità di questi padri, nati nel diciannovesimo secolo e ne fa una sintesi molto personale, ribellandosi, e portandola fino a oggi, secolo XXI. Una ribellione, la sua e quella dei colleghi brasiliani, che non ha mancato di suscitare reazioni forti tra i “padri” europei. Nel marzo del 1955 la rivista “Modulo” dava conto di una querelle apparsa su un numero della britannica “Architectural Review” dedicato alla produzione brasiliana e intitolato Report on Brazil. Vi comparivano interventi di celebri critici e architetti, come Gropius, Ernesto Rogers, Max Bill, Hiroshi Ohye e il cui bilancio era un timido apprezzamento con pesanti riserve, in cui l’architettura brasiliana veniva in qualche modo “giustificata” dal clima tropicale, la natura rigogliosa, le donne profumate e sensuali.
Non stupisce: il Brasile soffre da sempre di una lettura travisata, esotistica, come se la bellezza del paesaggio, il meticciato, l’esuberanza naturale fossero di impedimento allo svilupparsi di serie correnti culturali. Insomma, una lettura con la puzza sotto il naso, che a ben vedere continua tuttora, secondo cui Brasile significa unicamente futebol, bossanova, spiagge, mulatte, qualcosa di vagamente peccaminoso che attrae ma in fondo non merita grande approfondimento.
E così Gropius parlava degli “inganni di Niemeyer”, Max Bill insisteva sull’architettura come “arte sociale” (forse per alludere che le curve di Niemeyer non potevano esserlo) e il professor Ohye scriveva che Niemeyer “più che un architetto è uno scultore che disegna plasticamente edifici”.
Quando io lo incontro per la prima volta, il 15 aprile 2005, nel suo studio di Copacabana, ho di fronte un uomo di novantotto anni a cui faccio una domanda che sgorga da una curiosità personale: perché c’è così tanta acqua nei suoi progetti? La risposta è rapida e chiara: perché l’acqua riflette l’architettura. Niemeyer lo dirà sempre, in diverse occasioni: l’opera non è soltanto l’oggetto, ma anche quello che lo circonda e i vuoti, gli spazi. Come i colonnati. Quello del Palazzo Mondadori, ispirato al ministero degli Esteri di Brasilia: lo spazio tra le colonne dà il ritmo all’edificio, un ritmo musicale.
Quel giorno Niemeyer era seduto nel suo studio in penombra, con la matita in mano, e una risma di grandi fogli bianchi da riempire.
Come nell’aprile del 2005, anche nel 2012 sapevo di poterlo trovare al lavoro, nel suo studio, nell’attico dell’edificio Ypiranga, nella parte finale dell’Avenida Atlantica: un palazzotto curviforme che sembra uscito dalla sua matita, ma non lo è, dal...