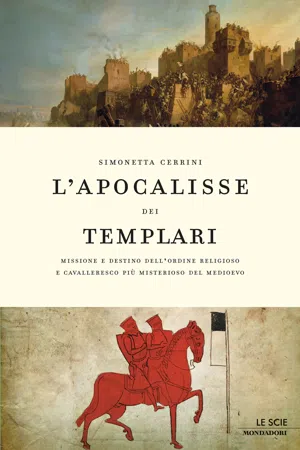![]()
Chi sono dunque i cavalieri templari al di fuori del campo di battaglia? Se alziamo di poco lo sguardo sull’affresco, ci si presenta una scena molto particolare che ci aiuterà a completare l’identikit del templare. Siamo ancora in Terra Santa: a suggerircelo le palme, i datteri e il colore della sabbia del deserto, sparso ovunque. Malgrado sia ben leggibile solo la parte sinistra dell’affresco, i protagonisti si distinguono chiaramente. Sono un gruppo di quattro frati templari in abito bianco in un convento fortificato su cui campeggia una croce. Dal sottarco o loggiato che li ospita si sporgono verso un leone fulvo che si è arrampicato su un albero di palma, di cui addirittura riconosciamo i datteri. Il leone è giunto all’altezza dei templari.
Ci siamo interrogati a lungo sul significato della scena e un po’ frettolosamente abbiamo visto in quel leone un aggressore. Sappiamo che tanti pellegrini erano attaccati dai leoni in Terra Santa e la regola stessa dei templari, pur vietando la caccia, dice esplicitamente che la caccia al leone va praticata. Ma in questo caso ci siamo sbagliati. Credo che sia stato Alain Demurger a rimetterci sulla diritta via: il leone non è affatto aggressivo, e in effetti uno dei cavalieri quasi gli tocca con la mano la zampa. Qual è il significato da dare a questa immagine? È possibile più di una lettura. Cominciamo con l’applicare lo schema dei «quattro sensi della Scrittura». Il secondo livello di interpretazione è quello allegorico. «Quid credas allegoria», recita infatti il distico del nostro Nicolas de Lyre. E cioè «l’allegoria dice ciò che bisogna credere». Nel nostro caso, l’allegoria di una battaglia materiale è senz’altro una battaglia spirituale.
In battaglia il templare affronta il nemico visibile, ma tutto sarebbe vano se non combattesse continuamente contro un altro nemico: se stesso. Ce lo dice in modo molto chiaro uno dei primi sostenitori dei templari, Guigues I de la Grande Chartreuse. Guigues, nato da una nobile famiglia, entrò nel «deserto» della Certosa e, divenutone priore, tra il 1121 e il 1127 mise per iscritto la regola e le consuetudini dell’ordine stabilite dal fondatore, san Bruno di Colonia († 1101), nel 1084. L’ordine dei certosini combinava l’esperienza eremitica con quella monastica. Il riferimento a un «deserto» ideale che Guigues viveva non in Terra Santa, ma fra le montagne pressocché inaccessibili delle Alpi a nord di Grenoble, senz’altro aiutava la comprensione del «fenomeno templare», altrettanto estremo e altrettanto nuovo. Il messaggio del priore certosino al maestro Ugo, che Guigues chiama «priore», e ai suoi confratelli templari è semplice e al contempo rigoroso. I templari non devono dimenticare che il vero combattimento è quello contro il nemico interiore; occorre che l’anima sia liberata dal male, che ciascuno abbia conquistato se stesso e che il templare conservi il dominio del suo corpo, prima di scagliarsi contro il nemico esteriore.
Ma lasciamo parlare lo stesso Guigues.
Invano attacchiamo i nemici esteriori, se prima non abbiamo battuto i nemici interiori. E sarebbe troppo vergognoso e indegno voler comandare a un qualunque esercito, se non avremo dapprima assoggettato i nostri corpi. Chi infatti sopporterebbe che noi volessimo estendere il nostro dominio su ampi territori se poi lasciamo che la schiavitù ignominiosa dei vizi si eserciti su poche motte di terra, cioè sulle nostre carni?
Come a dire: se non avete conquistato voi stessi, anche la grande vittoria di Nablus e tutti i vostri exploits guerrieri sono da considerarsi vani, vergognosi e indegni. Questa lettera è la prova che i templari non erano frati di facciata, ma ciò che si attendeva da loro era un’impresa davvero gigantesca: vivere ogni giorno nell’unità spirituale di mente e corpo pur non potendosi separare dal mondo. Infatti, per obbedienza alla propria vocazione, i frati cavalieri non rinunciano al ruolo ottenuto nella società: i cavalieri templari facevano già parte della cavalleria prima di entrare nell’ordine. Sono dei «combattenti» a tutti gli effetti, come l’imperatore, il semplice cavaliere o il piccolo feudatario. È un’impresa davvero molto rischiosa quella di vivere «nel» mondo senza essere «del» mondo, perché la tentazione è continua, e viene dai successi come dagli insuccessi, dalle vittorie come dalle sconfitte. È questo, forse, il fascino che ancora oggi può rappresentare la spiritualità templare per un laico cristiano: accettare di vivere immerso nelle contraddizioni del mondo, confidando di mantenersi completamente obbediente, anima e corpo, pensieri e azioni, sentimenti e passioni, allo Spirito Santo. «Spirito sancto intimante» (per comando dello Spirito Santo), infatti, si erano radunati a Troyes i Padri che avevano redatto e approvato la regola del nuovo ordine religioso.
Guigues – perché sia efficace ciò che ha scritto – termina la lettera con una richiesta precisa: la sua esortazione e il suo insegnamento siano letti a tutti i templari durante il Capitolo, l’assemblea periodica dei frati. Infine, chiede ai templari di ricordare i certosini «quando pregate nei sacri luoghi affidati alla vostra custodia». Un mirabile scambio di favori spirituali dal deserto di roccia al deserto della Terra Santa.
Altri teologi intervengono in modo più scolastico sulla cifra templare del doppio combattimento, da condurre sia contro l’avversario visibile sia contro quello invisibile. Il punto di partenza, per san Bernardo, è la Lettera di san Paolo agli Efesini (6,12): «La nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti». A differenza di Paolo, l’abate cistercense sostiene che la nuova cavalleria deve affrontare con la stessa tenacia entrambi i combattimenti, il doppio conflitto (De laude novae militiae, «Elogio della nuova cavalleria», 1). Da cavaliere nato in una famiglia di cavalieri, san Bernardo insiste sull’unicità e sull’alto valore di una scelta che, sebbene insolita, coniuga le due battaglie; in fondo, aggiunge Bernardo, non è raro assistere a esempi di resistenza militare al nemico e d’altra parte, cosa pur lodevole, si vede che il mondo è pieno di monaci!
Il tema della lotta contro il diavolo e le sue tentazioni è quello che affronta «Ugo il peccatore» nella Lettera ai cavalieri di Cristo. Per il maestro Ugo (che forse è il nostro Ugo di Payns) non ci sono affatto due battaglie, ma una sola: quella contro il diavolo e le sue tentazioni. Vincere il diavolo significa che il cavaliere di Cristo deve innanzi tutto restare fedele alla sua professione religiosa, che prevede di «portare le armi contro i nemici della fede e della pace per la difesa dei cristiani». In tempo di pace combattono la propria carne con digiuni e astinenza, e quando si insinua l’orgoglio i templari gli resistono e lo battono; in tempo di guerra combattono con le armi i nemici della pace che fanno danni o che li vogliono fare. La posizione di Ugo è molto più radicale di quella di san Bernardo, perché si basa sulla necessità che l’essere umano sia integro qualunque cosa faccia, con il corpo o con la mente. Se è unito in se stesso, non può che agire in modo conforme allo Spirito che lo abita.
Il deserto
Abbiamo visto che nel combattimento interiore il nemico è il diavolo. Ma qual è il campo di battaglia? Il deserto. Gesù fu tentato nel deserto per quaranta giorni. Questo è il modello che ispira tutte le esperienze eremitiche, maschili e femminili. Nei primi secoli del cristianesimo molti uomini e donne si ritirarono dalle città nei deserti di Egitto, Palestina e Siria. San Gerolamo († 420), Padre e Dottore della Chiesa, aveva vissuto a lungo in Oriente per studio e per penitenza, ed era un grande sostenitore dell’ascesi dei Padri e delle Madri del deserto, al punto che fondò vari monasteri a Betlemme e scrisse la biografia di alcuni anacoreti. Gerolamo si dedicò inoltre alla prima traduzione latina della Bibbia, che divenne il testo di riferimento per tutto il Medioevo e molto oltre con il nome di «Vulgata».
Mi chiederete cosa c’entri san Gerolamo con San Bevignate e i templari. Ebbene, fin dal 1243 i templari perugini disponevano di una precettoria formata da due entità distinte: San Giustino d’Arna e, proprio nella zona di Porta Sole, San Gerolamo. Tra il 1256 e il 1283 San Gerolamo fu sostituita dalla nuova chiesa di San Bevignate che, di conseguenza, doveva mantenere sotto qualche aspetto il culto per il santo frequentatore dei deserti di Terra Santa. E il legame non poteva essere proprio il nostro leone?
Vediamo cosa ci racconta a questo proposito l’arcivescovo di Genova, Iacopo da Varazze († 1298), nella sua celebre Leggenda aurea, una delle opere più lette e conosciute del tempo che l’autore cominciò a scrivere nel 1260. Il giorno della festa di san Gerolamo, il 30 settembre, leggiamo che verso sera
… un leone entrò nel monastero zoppicando. Appena lo videro, i suoi confratelli fuggirono, ma Gerolamo andò davanti a lui come l’avrebbe fatto per un visitatore. Il leone gli mostrò che era ferito al piede e Gerolamo chiamò i frati ordinando loro di lavare i piedi del leone e di cercare con attenzione la ferita. Si scoprì che dei rovi gli avevano ferito la pianta dei piedi. Fu medicato con ogni cura e, guarito, rimase con la comunità come fosse un animale domestico.
Questo celebre episodio ha fatto sì che il leone divenisse nell’iconografia l’animale che faceva coppia con san Gerolamo, come il maiale con sant’Antonio o il drago con san Giorgio. Alla luce di queste informazioni, alcuni storici come Alain Demurger hanno visto nell’affresco una rappresentazione dell’episodio occorso a Gerolamo nel deserto della Palestina. Solo che quei monaci che stavano nel deserto nel frattempo erano divenuti templari, come testimonia la croce posta sulla torre del loro convento fortificato. Sono d’accordo con Chiara Frugoni quando, a proposito del leone, suggerisce: «Mi sembra che sia da escludere l’idea che rappresenti i saraceni, visto che proprio sotto c’è una battaglia con uomini in carne e ossa». Questo leone, infatti, indica «la bestia», la parte animale di sé che l’uomo deve saper domare per poterne utilizzare la potente energia naturale. Quando il santo ha domato il «suo» animale, riesce a domare anche l’animale reale, che si incarnò in un leone per Gerolamo, e in un lupo per san Francesco, nella vicinissima Gubbio, qualche decennio prima.
I templari conoscevano queste storie? Sì, le leggevano e anzi le avevano anche tradotte dal latino in volgare. Andando a curiosare tra gli scaffali delle biblioteche templari, troviamo una traduzione in anglo-normanno delle Vite dei Padri dedicata al templare Henri d’Arci, della precettoria di Temple Bruer, nel Lincolnshire. Si tratta di una raccolta agiografica di grande successo che narra le vite e i detti dei Padri del deserto, dei monaci, degli anacoreti, degli eremiti, uomini e donne. Raccoglievano, in sostanza, il fiore della spiritualità del deserto, quella a cui i templari si sentivano più vicini. Accanto a questo troviamo un altro testo templare interessante, che peraltro era già contenuto nelle Vite: la Vita di santa Taide, la peccatrice redenta.
Taide era una prostituta di lusso egiziana, potremmo dire una escort dei nostri tempi. L’anacoreta Paffluzio giunse in città dal deserto della Tebaide e, fingendo di essere un cliente, entrò da lei. Le mostrò del denaro chiedendole però di recarsi in una stanza dove nessuno avrebbe potuto vederlo. Allora Taide gli disse: «Se Lei teme Dio, non c’è luogo che sia nascosto a Lui». L’abate Paffluzio le domandò perché, sapendo di Dio e del suo regno, e dei tormenti che l’attendevano, non si pentiva. La donna chiese tre ore di tempo, quindi fece un pubblico rogo di tutto quello che le era stato donato, e infine si rinchiuse in una piccola cella di un monastero femminile da cui non uscì per tre anni. Mangiava pane e acqua, e ripeteva incessantemente, rivolta a Oriente: «Voi che mi avete fatto, abbiate pietà di me». Paffluzio, mosso a compassione, si recò dall’abate Antonio per sapere se Dio l’avesse perdonata. Il santo abate chiese a tutti i discepoli di pregare e vegliare tutta la notte. Paolo, il principale discepolo dell’abate, ebbe allora una visione: un grande letto nel cielo, ricoperto di stoffe preziose e guardato da tre vergini, la Paura delle pene future, la Vergogna per i peccati commessi e l’Amore della giustizia. Poi sentì una voce che gli assicurava che una simile grazia era destinata alla peccatrice Taide. San Paffluzio, confortato dalla notizia, andò subito da Taide a comunicarle che Dio l’aveva perdonata.
Se torniamo a San Bevignate, scopriamo un’altra figura di donna che in un primo tempo era stata prostituta in città e poi era divenuta un modello di ascesi e penitenza nel deserto: Maria Maddalena. Sulla sinistra della cella absidale troviamo infatti una versione eremitica della santa, vestita dei soli capelli rossi che le arrivano fino ai piedi. Quarant’anni prima il pittore locale Bonamico l’aveva interpretata nello stesso modo nella chiesa di San Prospero, sempre a Perugia. Secondo Gaetano Curzi, chi dipinse la Maddalena di San Bevignate può essere lo stesso che affrescò la parte alta della controfacciata. Il culto di Maria Maddalena da parte dei templari è variamente testimoniato: possedevano sue reliquie e il suo nome era nell’elenco dei santi che dovevano festeggiare. Una lista che papa Innocenzo II aveva preparato per loro in occasione del concilio di Pisa del 1135.
La Maddalena penitente è una donna del deserto venerata dai templari. Ci fa pensare alle prime «sorelle» del Tempio, le suore che all’inizio condivisero alla pari il sogno templare, ma che dal 1129 non trovarono più spazio nella nuova istituzione religiosa. Ci furono delle eccezioni, lo sappiamo, come quella di suor Ermengarda precettrice della commenda doppia, cioè maschile e femminile, di Rourell, presso Tarragona, ma le presenze femminili nella storia del Tempio restarono comunque episodi isolati. La Maddalena templare di San Bevignate non è un caso unico, ma è segnale di una vasta presenza femminile di tipo eremitico che risuona in tutta la zona: per esempio Monteluce e Fontenovo. Come rileva Giovanna Casagrande, tutto quel territorio rivolto a Oriente e ad Assisi aveva idealmente ricreato accanto alla città di Perugia e attorno alla chiesa di San Bevignate il deserto della Terra Santa. I templari ne erano ancora i custodi.
San Bevignate, il santo misterioso: novità in diretta
La grande chiesa templare al centro di un pullulare di istituzioni religiose e di fermenti laicali era dedicata a un santo: Bevignate. Ma chi era costui? Se osserviamo gli affreschi della parete centrale dell’abside, in basso a destra, notiamo un santo vescovo, con la mitria, i paramenti e il bastone pastorale, che benedice Bevignate; tra i due, un rotolo dispiegato in verticale su cui si legge: «Sanctus Benvegnate in suo reclusorio per octo…». Cosa ci dicono queste parole? Intanto che Bevignate era santo, come confermato anche dall’aureola. Inoltre che era un «recluso», cioè che si era chiuso volontariamente in una cella. C’è poi il numero otto, a indicare, probabilmente, che non restò recluso per sempre, ma per un periodo di tempo preciso: di otto anni? o di ottant’anni? Non lo possiamo sapere. Infine, l’immagine ci suggerisce che la sua vita di penitente fu riconosciuta dall’istituzione ecclesiastica: il vescovo ne è testimone. È importante, perché serviva ad allontanare ogni possibile accusa da Bevignate e, quindi, dai templari che lo avevano sostenuto. In quegli anni vicini al 1260, che secondo i seguaci di Gioacchino da Fiore avrebbe segnato l’avvento dell’era dello Spirito, ogni esperienza religiosa riconducibile a un radicalismo spirituale, se non avallata da un vescovo, rischiava di essere perseguitata.
Detto ciò, l’affresco non ci dice neppure in che epoca sia vissuto. In effetti, se cerchiamo notizie su di lui, scopriamo che Bevignate ha fatto di tutto per nascondersi sia dagli onori dell’altare sia dalla pubblica venerazione. Viene menzionato la prima volta nel 1256, in una lettera che il potente templare Bonvicino scrisse al comune di Perugia circa la costruzione della chiesa «Sancti Benvegnati». Nel 1260 lo stesso frate Bonvicino, appoggiato dal comune e dal vescovo, chiede a papa Alessandro IV di aprire un’inchiesta sulla vita e suoi meriti «beati Benvignatis». Nel 1266 e nel 1267 i «frati di san Bevignate», cioè i templari, rinnovano la richiesta al papa, senza esito. Nel 1277 sembra che sia giunto il momento tanto desiderato: il pontefice si trova a Viterbo insieme con il maestro del Tempio Guillaume de Beaujeu. Subito il comune di Perugia manda un’ambasciata a papa Giovanni XXI per chiedere la canonizzazione di Bevignate. Purtroppo il papa muore e non se ne farà nulla. Poco dopo, comincia la triste parabola discendente dell’ordine. Nel 1291 il maestro Guillaume de Beaujeu cadde eroicamente durante la battaglia di Acri, che segnò di fatto la fine degli Stati latini d’Oriente. Secondo la Cronaca del Templare di Tiro, il maestro fu colpito a morte da un giavellotto e rispose a gran voce ai crociati che avevano creduto che se ne stesse andando via: «Signori, non posso più perché sto morendo! Guardate il colpo». Detto questo si strappò il dardo e fu portato dai suoi al Tempio di Acri, dove morì. Le successive tragiche vicende dell’ordine, l’arresto dei templari del regno di Francia nel 1307, tutti i processi che i templari subirono in Europa e infine la soppressione dell’ordine nel 1312, lasciarono per sempre in disparte la questione della canonizzazione di Bevignate.
Malgrado ciò, la chiesa perugina veniva già utilizzata dai templari e nei primi anni Ottanta del Duecento fu probabilmente consacrata o riconsacrata. Ma la venerazione a Bevignate non si interruppe mai, anche nei secoli successivi. Il popolo perugino continuava a venerarlo, e così il comune, visto che neppure i potenti templari erano riusciti a farlo dichiarare santo, decise di occuparsene a modo suo. Il 14 maggio, giorno della morte di Bevignate, era considerato festivo per alcune istituzioni cittadine già negli statuti del 1342-1343. Ma nel 1453 il comune di Perugia per delibera comunale decise di proclamare santo Bevignate «che secondo la sua Leggenda nacque e crebbe nel nostro contado e nella nostra città condusse una vita pia e degna di lode. Benché non faccia parte del catalogo dei santi, tuttavia dalla santità della sua vita e dalla frequenza dei miracoli che per i suoi meriti la divina bontà rese numerosi ed evidentissimi sia in vita che in morte, non si deve dubitare che si trovi in quella gloria superna e nel numero dei santi». E così il 14 maggio, da quell’anno, divenne festa cittadina. Bisogna però attendere addirittura il 1609 perché la Chiesa riconosca la santità di Bevignate. In quell’occasione i corpi di sant’Ercolano, san Pietro abate e san Bevignate furono traslati con una solenne processione. E finalmente, ma solo nel Seicento, san Bevignate ebbe anche una sua «Vita», raccontata da Ludovico Iacobilli: divenne un soldato romano del V secolo, convertito e penitente, che si fa eremita in un bosco (la foresta è l’equivalente occidentale del deserto) presso Perugia, aiuta i poveri facendo maturare olive e grano, libera dal carcere due innocenti e resuscita un bambino ucciso dal lupo.
È stata letta una traccia medievale della sua leggenda negli affreschi della chiesa templare, sulla lunetta dell’arco trionfale, a sinistra, dove, in un riquadro, un lupo sta per divorare una persona. Ma chi può escludere che Iacobilli abbia scritto di quel miracolo proprio per aver visto l’affresco duecentesco di San Bevignate? Ammesso e non concesso che la vittima del lupo dipinta nell’affresco perugino fosse proprio un bambino… Oppure Bevignate – questa è l’ipotesi oggi più convincente – fu un eremita del XIII secolo che viveva nella zona di Monteluce - Porta Sole, dove poi sarebbe stata costruita la chiesa in suo onore. In quest’ultimo caso, i templari avrebbero potuto ospitarlo sui loro terreni. Chiara Frugoni ci propone di osservare l’abito bianco con il cappuccio di Bevignate e di confrontarlo con quello dei templari raffigurati sulla controfacciata: sono identici. Bevignate – è la sua proposta – poteva esser stato un templare. Aggiungo io che sia Bevignate sia i templari portano la barba, e vedremo più avanti quale fosse l’importanza e il significat...