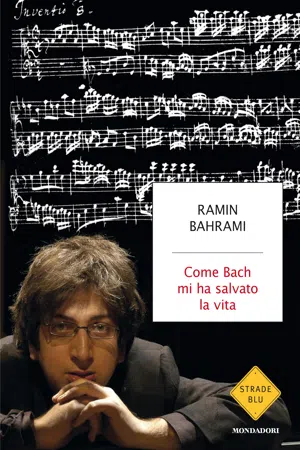![]()
In ogni storia che si rispetti, tuttavia, non ci sono solo ombre, ma anche luci, oasi in cui la memoria può trovare rifugio. E, fatto inspiegabile per un bambino che allora aveva meno di due anni, i miei ricordi dei momenti felici precedenti la rivoluzione islamica sono così luminosi da meritare un posto d’onore in questo racconto. Proprio da lì voglio quindi cominciare.
In vacanza sul Mar Caspio
Tornando indietro con la mente ai miei primi ricordi mi sembra quasi di sprofondare in un sogno, da cui affiorano alla coscienza le immagini delle villeggiature sul Mar Caspio che ogni estate trascorrevo con la mia famiglia al completo: mio padre, mia madre e i miei due fratelli, entrambi maggiori di me.
A ben guardare, il Mar Caspio è sia un mare interno sia uno dei più grandi laghi al mondo, con una superficie più estesa rispetto a quella dell’intera Italia e un volume di acqua quasi pari a quello di tutti gli altri laghi del mondo messi assieme. Il dubbio se definirlo mare o lago nasce dal fatto che le sue acque hanno una lieve salinità, pari a circa un terzo di quella del mare, e dalla caratteristica di non presentare alcuno sbocco nell’oceano, pur ricevendo il tributo di fiumi importanti come il Volga e l’Ural. Il Caspio bagna ben cinque paesi, dalle repubbliche dell’ex Unione Sovietica al mio. La sua costa meridionale, a nord di Teheran, è facilmente raggiungibile aggirando la catena dei monti Elburz.
Vista la distanza relativamente breve fra la località di villeggiatura e la nostra casa a Teheran, andavamo in vacanza in auto, fermandoci per strada ad assaporare il kluché, tipico biscotto del Nord della Persia, che mio padre comprava dai contadini che incontravamo lungo il tragitto. È questo uno dei primi ricordi che ho di mio padre, il quale, in virtù della sua importante posizione lavorativa, era sempre impegnato nel corso dell’anno. Potevo quindi godere della sua compagnia solo nel periodo estivo. Malgrado la sua giovane età, infatti, mio padre era già il direttore di due grandi aziende, la Siemens Iran e la Brown Boveri.
Attraverso il nonno paterno, Mehdi Bahrami, considerato forse il più importante archeologo persiano, la famiglia di mio padre era entrata in stretto contatto con quella imperiale e, di conseguenza, anche con le idee dell’Occidente, come tutte le famiglie iraniane appartenenti a quello stesso rango. La mia visione della contaminazione fra Occidente e Oriente in Bach si deve forse anche a questo fatto, senza contare che mio padre era di madre tedesca e aveva studiato in Inghilterra, mentre mia madre ha origini russo-turche.
La famiglia di mia madre, come ho già accennato, discende da uno dei più celebri sovrani degli ultimi secoli, quel Nadir Shah Afshar soprannominato «il Napoleone di Persia». Se il lato paterno della mia famiglia aveva raggiunto il prestigio attraverso la cultura e la ricerca, quello materno era caratterizzato da elementi quali la ricchezza e il potere, un potere diretto esercitato su possedimenti quattro volte più estesi della Svizzera, oltre che da contatti diretti fra il mio bisnonno materno Amir Afshar e l’ultimo zar di Russia.
Prima della riforma agraria attuata dallo shah, i possedimenti terrieri rivestivano una notevole importanza in Persia che, a differenza di quello che si può pensare, è un paese molto fertile, con una produzione ricca e variegata: grano e orzo sono coltivati principalmente nella zona occidentale, accanto ad arance, pesche, meloni, mele e limoni, mentre nel resto del paese, nelle aree meno aride, si coltivano melograni, uva, fichi e datteri. Negli anni precedenti la riforma, tuttavia, il principale prodotto dell’economia nazionale era il riso, coltivato in massima parte proprio lungo le rive del Mar Caspio.
Il tratto di costa che discende dai monti Elburz è infatti particolarmente fertile grazie alle precipitazioni abbondanti. Ho impressa nella memoria l’immagine delle donne al lavoro nelle risaie, né dimenticherò il profumo dell’erba, accompagnato dalla brezza dolce che soffiava increspando l’acqua. In quei luoghi da favola andavamo a cavallo fra i prati e le foreste, ricche di animali selvatici, dai lupi agli orsi ai cinghiali; nuotavamo direttamente in mare, circondati dalle tinte sgargianti di una fitta popolazione ittica, che contribuisce tuttora a una produzione di caviale assai rinomata.
Il fabbro Almas e il giardiniere Guchali
Ricordando quel periodo mi viene naturale parlare di due nostri aiutanti le cui figure, di un’umanità squisita, erano ammantate ai miei occhi infantili di un’aura di magia: Monsieur Almas, il fabbro, e Guchali, il giardiniere.
Monsieur Almas, di origine armena, dopo l’esilio dello shah divenne «trafficante» illecito di vodka, non per scelta ma per necessità: il popolo persiano ha sempre amato la carne di maiale e le bevande alcoliche occidentali, ma con la rivoluzione khomeinista divenne un reato essere trovati in possesso di simili derrate. Questo «traffico», che ho scherzosamente definito illecito, destava in me un enorme fascino e tanta simpatia, poiché rappresentava il coraggio e la voglia di vivere di un popolo deciso a non permettere a dogmi, che non erano neppure nostrani, di avere il sopravvento, di instaurare una rigidità e una chiusura non consoni allo spirito libertario dell’impero di Ciro il Grande.
L’altra figura mitica che contribuiva ad allietare le nostre vacanze era il giardiniere Guchali, la cui somiglianza con Charlie Chaplin-Charlot era sconvolgente, persino nella goffaggine dei modi. Guchali era il custode della freschezza dell’erba, uomo così sensibile da commuoversi annaffiando le rose del giardino della nostra villa; ogni volta che arrivavamo da Teheran ci veniva incontro con il tè e un vassoio colmo di dolci tipici. Quando, pochi anni dopo, nel 1981, giunse la Guardia rivoluzionaria a confiscare la nostra amata villa, curata in ogni dettaglio da mio padre e da lui con amore infinito, il giardiniere non seppe trattenersi e si mise a piangere a dirotto come un bimbo che perde un genitore. Con la sua umanità Guchali mi mostrò l’essenza della vera fratellanza e dell’amicizia che ci può essere fra gli esseri umani.
I ricordi delle villeggiature di famiglia sul Mar Caspio fanno parte del clima idilliaco in cui vissi fino all’età di cinque anni circa, prima che la situazione precipitasse nel vero senso della parola. Un clima in cui era davvero forte in me la sensazione di una commistione fra Oriente e Occidente, commistione in cui era possibile godere di tutto ciò che di bello c’era nelle due culture senza la necessità di proclamare la superiorità dell’una sull’altra.
La nonna Anne-Frieda e il nonno Mehdi
Grazie alla nonna paterna di origine tedesca, Anne-Frieda, avevo e ho tuttora la fortuna di festeggiare due volte il nuovo anno. Non dimenticherò mai i Natali che trascorrevamo con mio padre, i miei due fratelli, la mamma e la nonna, splendida donna che si era innamorata di mio nonno Mehdi, l’archeologo, al loro primo incontro, nella biblioteca della Sorbona. A distanza di anni lei amava sempre raccontare la scena, vivida nel suo ricordo e che sembrava tratta da un film di Hollywood. Pare infatti che quel giorno, mentre andava a ritirare un volume in biblioteca, inciampasse, facendo cadere a terra il libro; mio nonno, rapido, lo raccolse e glielo porse. Fra i due scoccò la scintilla. Fu un vero colpo di fulmine.
Dopo qualche anno e la nascita di mio padre a Berlino, la coppia decise di trasferirsi in Persia, paese che la nonna amò da subito e per sempre. Qui la mitica Anne-Frieda si trasformò in Farideh Bahrami, mutandosi da «prussiana» in un’autentica persiana. Ricordo infatti che parlava perfettamente la nostra lingua e cucinava i nostri piatti tipici con una disinvoltura sconcertante. L’unica cosa che non riuscì mai a correggere fu la caratteristica «r» tedesca, per cui «Ramin» diventava «Rrramin!», o «Parviz» «Parrrviz». Io trovavo quel suo accento irresistibile.
Tuttavia, quando i miei genitori parlavano in tedesco con lei, provavo sempre un senso di agitazione, poiché quel modo di esprimersi suonava molto duro alle mie orecchie di bambino. Con il passare degli anni, però, il rifiuto si è trasformato in vero e proprio amore per la musicalità della lingua e la profondità della cultura tedesca. Sono infatti convinto che nella musica del mio compositore preferito (Bach, naturalmente!), nell’enunciazione di certi soggetti di fuga, le cadenze finali siano tipicamente riconducibili alla lingua tedesca; d’altronde, lo stesso biografo Nikolaus Forkel afferma che la musica di Bach è paragonabile a un dialogo continuo: si ha la sensazione di percepire delle voci che si parlano e si cercano fra loro per fondersi in un cosmo multiforme.
Anne-Frieda è mancata in Iran due anni dopo la mia partenza. Purtroppo l’ultimo tratto della sua vita fu reso difficile da un Alzheimer impietoso: la nonna non aveva sopportato la rivoluzione, la guerra, l’arresto del figlio... l’unica cosa che le era rimasta nella memoria, viva come un tempo, era la musica, in particolare i Lieder del suo amato Schubert.
Mio padre Parviz
Il solo elemento di ansia in quegli anni era per me rappresentato dall’asilo, esperienza che affrontavo come una costrizione, quasi come una galera, visto che nel 1979, all’epoca in cui cominciai a frequentarlo, vi risuonava spesso (come dappertutto nel paese) l’invocazione in arabo «Allah Akbar». Alle mie orecchie di piccolo musicista le esortazioni integraliste suonavano già come dissonanze difficilmente risolvibili, procurandomi uno stato di angoscia costante.
Tutto il resto mi sembrava, invece, uscito da una favola, in una Teheran dinamica dove spesso accompagnavo mio padre nello svolgimento delle svariate mansioni legate ai suoi ruoli dirigenziali. Sfortunatamente, gli impegni di lavoro lo portavano via molto spesso, troppo per un bambino come me, estremamente sensibile, addirittura pauroso (ero capace di spaventarmi persino per il rumore troppo forte di un microfono!), e prima che quel periodo idilliaco finisse potei godere assai poco della sua presenza. Tuttavia, mi ricordo perfettamente di lui.
Rammento la sua eleganza innata, la sua capacità di parlare parecchie lingue, la sua prerogativa di eseguire più operazioni contemporaneamente (dote che mi ha trasmesso e di cui vado molto fiero), nonché la sua estrema generosità. Oltre a queste attitudini molto importanti per un dirigente competente, efficiente e al tempo stesso sensibile e profondo, fu chiaramente fondamentale per la mia precoce formazione la sua passione smisurata per la musica. Non dimenticherò mai le sue improvvisazioni sullo Schimmel di casa nostra o sullo Steinway della nonna tedesca, pianoforte che mio padre aveva acquistato da giovane.
Nel corso dei suoi studi in Inghilterra aveva avuto la fortuna di seguire le lezioni di una assistente di Jasha Heifetz e spesso diceva scherzando che, se avesse continuato a studiare violino, avrebbe potuto diventare più bravo di Yehudi Menuhin. A casa nostra avevamo tutti i dischi di Menuhin, quelli di Heifetz e di von Karajan, accanto a quelli di Frank Sinatra, Charles Aznavour e di altri celebri cantanti di quegli anni: solo musica di grande livello artistico, ma con la massima apertura a tutti generi!
Sono cresciuto ascoltando a colazione le sinfonie di Brahms e Beethoven, mentre nel pomeriggio, dopo essere stati a prendere un café glacé (prelibatezza di cui sento ancora il gusto in bocca: lo ricordo denso, intenso, colmo di sicurezza e di tranquillità), tornavamo a casa e spesso ascoltavamo il Concerto per violino di Čajkovskij, il pezzo preferito da mio padre, violinista mancato. Oserei quasi dire che il Concerto è stato la colonna sonora della mia infanzia, con le sue oscillazioni fra sereno e burrascoso, come la stessa vita di Pëtr Il’ič: sole/tempesta, chiaro/scuro, pace/guerra.
Purtroppo quei bei momenti erano destinati a finire presto.
Lezioni di francese
I ricordi del periodo del conflitto con l’Iraq sono chiaramente quelli più vividi. L’ansia provocata dallo scoppio della guerra ci faceva porre in cima alla scala dei valori la sopravvivenza fisica. Eravamo sempre sul chi vive, sottoposti alla minaccia continua dei bombardamenti. Eppure quei momenti terribili rappresentavano paradossalmente anche una splendida occasione di aggregazione e di solidarietà, erano l’occasione per sperimentare una vicinanza umana impensabile e impossibile nell’odierno Occidente globalizzato, in cui viviamo così «felicemente», lontani da guerre e miserie. Pur esposti al rischio imminente di morte, eravamo contenti, apprezzavamo con più intensità ogni singolo istante di vita. Personalmente, da quella esperienza ho imparato che si può essere più infelici in un ambiente calmo, ma freddo e distante, che nel pericolo più estremo, condiviso però con persone unite dal dolore.
Fra gli orrori e le sofferenze della guerra vi erano tuttavia anche momenti positivi, come le mie lezioni settimanali di francese. Imparare questa meravigliosa lingua era per me un sollievo, una specie di scudo contro le brutture cui eravamo sottoposti quotidianamente da quando era scoppiata la rivoluzione islamica. Le lezioni di francese compensavano in qualche modo quelle paure così forti che non sono mai più riuscito a superare del tutto.
Lo stesso effetto riuscivano a ottenerlo le prime note che, grazie a mia madre, avevo imparato a strimpellare sul pianoforte.
Fu in quel periodo che cominciai a sentire e ad apprezzare fortemente l’importanza della musica classica che, insieme al francese, divenne il mio modo di sfuggire a un presente drammatico. Ricordo le lunghe improvvisazioni in stile beethoveniano, i pomeriggi trascorsi sul tavolino del salotto facendo finta di essere il nuovo von Karajan (anzi, credevo addirittura di essere meglio di lui!): solo così mi sentivo al sicuro. Dentro di me la musica aveva vinto per sempre la lotta contro l’ansia, gli orrori e la violenza di tutti i giorni.
L’arresto di mio padre
Fu proprio negli anni della guerra che accadde l’avvenimento di certo più penoso e più gravido di conseguenze per la mia vita: nel 1983 mio padre fu arrestato con l’accusa di tradimento e cospirazione, avendo collaborato con lo shah prima della rivoluzione. Colpevoli o no (e lui non lo era assolutamente), a quel tempo era sufficiente possedere un libro o mostrare un qualsiasi altro segno che suggerisse un’apertura nei confronti dell’Occidente per venire arrestati.
Parviz Bahrami era «colpevole» di aver progettato scuole moderne per il suo paese, accusato di svolgere un’attività che, seguendo il cammino tracciato dalla sua famiglia, in qualche modo perseguiva un desiderio di espansione e di sviluppo della cultura. Per inciso, mio nonno Mehdi era stato il primo studente iraniano mandato a studiare alla Sorbona da Reza Khan Pahlavi I, e per questa ragione era assai famoso in Iran (anche se diventò «famigerato» per i pasdaran).
Mio padre finì quindi nelle galere rivoluzionarie da cui, purtroppo, non uscì vivo. Vi morì nel 1990 e ancora oggi non sappiamo dove siano i suoi resti. Eppure, egli era l’esempio vivente di come le culture con la C maiuscola, quella occidentale e quella orientale, potessero riunirsi in una sola per esprimere qualcosa di straordinariamente coeso e privo del minimo conflitto, esempio ritenuto fortemente destabilizzante dal rigido ordine politico-religioso instaurato in Iran dopo la rivoluzione.
Se da un lato quell’evento fu la causa materiale della rovina della mia famiglia e della mia giovane esistenza, dall’altro esso costituì la pietra miliare della mia istruzione e realizzazione musicale. Infatti, fu proprio in seguito alle commoventi lettere colme di affetto e di incoraggiamenti che mio padre mi spedì dal carcere che avvenne il mio primo contatto con il genio universale e senza tempo di Johann Sebastian Bach. Da quel contatto scaturì per me una missione, che promisi di portare fino in fondo a ogni costo, sostenuto dal ricordo del mio meraviglioso papà.
Per la mia formazione musicale in quegli anni furono certamente fondamentali i primi rudimenti impartitimi da mia madre, così come l’esempio offertomi dalle ispirate improvvisazioni di mio padre e l’ascolto di tanta musica eccellente, cui ho accennato in precedenza. Ma ricordo anche altri episodi che vi contribuirono.
Una volta, per esempio, quando avevo solo quattro anni, dopo che avevamo ascoltato insieme un disco di Claudio Arrau, mio padre mi disse con tono molto pacato: «Ramin, dovrai studiare molto per riuscire un giorno a suonare così». La frase colpì la mia suscettibilità infantile ed ebbi una reazione violenta, presuntuosa e arrogante: gli diedi uno schiaffo e scappai di corsa in camera mia, dove rimasi chiuso per più di due ore. Mi sono spesso domandato il perché di un gesto tanto inconsulto. Forse mi ero sentito ferito perché era stata messa in discussione l’unica certezza che avevo trovato fino ad allora. Solo più tardi compresi che in quella frase non c’era il desiderio di umiliarmi, ma solo una profonda, sacrosanta verità.
Mia madre Shahin
Per me bambino, avere una madre che aveva studiato con un certo Kapuczinsky, allievo di Arthur Rubinstein e insegnante al conservatorio imperiale di Teheran, aveva facilitato, ovviamente, l’apprendimento dei primi rudimenti musicali. In quegli anni, però, la mamma, oltre a iniziarmi all’alfabeto musicale, pensò bene di trovarmi un vero insegnante. Organizzò così un incontro con il maestro Forsi, un giovane pianista che all’epoca avrà avuto sì e no trent’anni, il quale venne a casa nostra per ascoltarmi.
Ricordo che, a orecchio, io avevo imparato due fra i pezzi forti della mamma, ossia Per Elisa di Beethoven e la Marcia turca di Mozart, e cercavo di suonarli nella maniera più coinvolgente possibile. Peccato che il coinvolgimento non destasse particolare entusiasmo nel giovane professore; gli procurò, anzi, un cert...