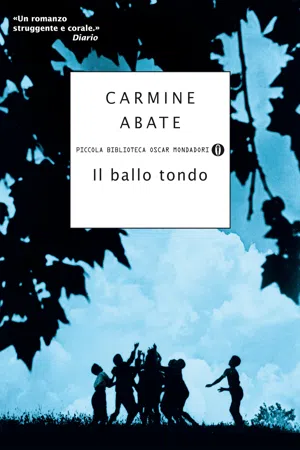![]()
Balliam balliam, ragazze, la vallja di Costantino il Piccolo, sposo solo per tre giorni. Poi riceve l’ordine dal Gran Signore di raggiungere l’esercito. Parte. Parte, naturalmente, e combatte per nove anni senza lamentarsi, finché passati nove anni e nove giorni, ohi, fa un sogno Costantino, un sogno spaventoso: e bukura, la bella, stava per mettere corona con un altro. Costantino sospira; così forte sospira che sente il Gran Signore. Il quale la mattina, appena sa il motivo di quel sospiro, così parla al suo fedele Costantino: «Prendi la nona chiave, apri la nona stalla, prendi il cavallo palombino, quello nero come le olive, quello più veloce del nibbio; mettigli la sella d’argento, la cavezza mettigliela d’oro, e va’ alla tua Hora, dove sta la tua sposa». E Costantino va veloce più del nibbio, riposandosi poco di notte e di giorno, finché tocca la sua terra, finché è nella sua Hora. Qui incontra zotin pjak, il vecchio padre, che però non lo riconosce. «Dove vai, zoti pjak?» «Vado a precipitarmi da una rupe, mia nuora stamattina mette corona con un altro». E il figlio al padre: «Torna indietro, zoti pjak, ché io sono Costantino». E il padre al figlio: «Costantino, figlio mio, sprona il tuo cavallo veloce che la trovi alla porta della chiesa». E Costantino va più avanti, dove incontra zonjën pjakë, la vecchia madre. E la scena si ripete, si ripetono le parole, e Costantino non perde altro tempo: galoppa, vola con il suo cavallo veloce più del nibbio, e la trova in chiesa, appena in tempo per gridare al prete di metter via quelle corone, perché lui è Costantino, Costantino della prima corona.
![]()
Questa di Kostantini i vogël era l’unica storia albanese che conoscesse il mio amico Costantino Avati, prima di recarsi con il nonno alla fiera della Marina. Era una delle poche rapsodie che da bambini sentivamo cantare ai cortei nuziali, dopo la celebrazione del matrimonio. A volte, se il corteo era in vena, ci si prendeva per mano, adulti e bambini, e in cerchio si ballava al ritmo monotono ma allegro della vallja: Lojmë lojmë, vasha, vallen. E siccome le valle cominciavano tutte con lo stesso invito a ballare rivolto alle ragazze, della vallja di Costantino il Piccolo l’unico verso che io tenessi a mente era il primo. Costantino Avati, invece, sarebbe stato in grado di recitarne interi passaggi a memoria e ciò per due motivi: perché il protagonista si chiamava Costantino e perché zonja Elena, sua madre, non si stancava mai di ripetere, dopo aver sentito il canto, che la stessa bella storia d’amore l’avevano vissuta lei e il marito Francesco Avati.
Era stato così, raccontava zonja Elena: al ritorno dal militare, lui, il futuro sposo, la vede quattordicenne, l’età in cui era sbocciata come un fiore. Lì per lì, non la riconosce: era una bambina quando era partito, ma ora lei è a casa Avati, portatagli dal destino su un piatto d’argento. Non c’è bisogno che i parenti gliela raccomandino. Lui ha occhi per vedere e cervello fino per capire e dunque le promette di sposarla il più presto possibile. Dopo, però. Dopo aver fatto quello che si era giurato fin da bambino: deporre un ramoscello d’ulivo benedetto sul posto dove era morto il padre, una miniera di carbone, nella Merica Bona. Così, mentre quasi tutti i suoi coetanei emigrano in Francia per lavoro, lui s’imbarca da Genova alla ricerca di una tomba fatta di macerie nere.
È stato via per nove mesi e nove giorni, nove mesi lunghi come nove anni, ed è ritornato proprio in tempo per mandare a monte il nuovo fidanzamento che il padre di lei, zoti Lissandro, stava combinando con un giovane di Puhërìu. Sì, con la stessa tempestività di Kostantini i vogël, per restare fedele alla besa, la parola data. A Hora, il nostro paese, lo chiamano subito il Mericano, per via di quel viaggio nella Merica, di cui il superbo giovane non ha mai voluto parlare con nessuno; ma forse anche per quei baffetti curati alla Clark Gable, la cui dolcezza tentatrice aveva inondato dallo schermo del cinema tutte le donne di Hora, durante le nove proiezioni di Via col vento.
Nell’arco di venti mesi, zonja Elena diede alla luce due bambine: Orlandina e Lucrezia. Poi aspettarono impazienti la nascita del maschietto, anche se tutti dicevano che il maschietto in casa ce l’avevano già ed era Lucrezia, una vera burraçë fin dai primi anni di vita: giocava solo con i maschi e come un maschio orinava, all’impiedi, e fischiava infilando quattro dita in bocca.
Otto anni dopo Lucrezia, nacque finalmente lui.
A differenza delle sorelle, il piccolo Costantino non era la sintesi dei genitori, non avendo ereditato né l’esuberanza fisica e i capelli blunotte della madre, né gli occhi camaleontici del padre, del colore del marmo cipollino con striature ora verdi smeraldo ora grigie, a seconda dell’umore e del tempo. Costantino era gracile e di carnagione olivastra, con due occhi stralunati, grandi e castani. Forse come carattere assomigliava di più al nonno materno, portato a fantasticare, a parlare instancabilmente per ore e a tacere inspiegabilmente per giornate intere.
Fu il nonno, nani Lissandro, a condurlo alla fiera estiva della Marina, sostituendo anche in questo il Mericano che, dopo la nascita del figlio, era stato costretto a emigrare in Germania. E così da quel giorno gli occhi di Costantino s’ingrandirono ancora di più, come quando di mattina ci si sveglia da un lungo sonno, inondati all’improvviso da un fascio di luce. Questo fascio di luce era il racconto di nani Lissandro che gli faceva scorgere delle radici storiche e mitiche, fino allora del tutto ignorate.
Più o meno la stessa cosa è successa a tanti bambini di Hora, me compreso. Fino al giorno della fiera, ignoravamo persino che Hora fosse stata fondata cinque secoli prima dai profughi albanesi che non volevano sottomettersi ai turchi invasori delle loro terre. A casa parlavamo si neve, come noi, in arbëresh, e poi a scuola, dall’età di sei anni, cominciavamo a imparare il litisht, cioè l’italiano. Il tutto con naturalezza; senza chiederci il perché e il percome. Per nostra fortuna c’era la fiera della Marina; e allora, chissà perché, i nostri accompagnatori si sentivano in dovere di raccontarci la storia approssimativa del nostro passato remoto.
Il mio amico Costantino, alla fiera, vi fu accompagnato all’età di nove anni. Oggi, quando per le ferie ritorniamo entrambi a Hora dalle città forestiere in cui lavoriamo, mi parla di quel giorno col tono epico che era dei vecchi rapsodi albanesi. Del resto, come può parlare uno che passa tutto il suo tempo libero a raccogliere, a ordinare, a tradurre in italiano le antiche rapsodie arbëreshe e poi le memorizza al computer del suo ufficio in un ministero romano? Io lo lascio parlare a ruota libera e lui va oltre il giorno della fiera e termina con «e poi?».
All’epoca in cui comincia la sua storia, io avevo otto anni e non lo frequentavo abitualmente come avrei fatto in anni più recenti. Fu dunque un caso che mi trovassi anch’io nella piazzetta della sua gjitonia, il vicinato, quando Costantino annunciò al mondo con orgoglio: «Ho visto volare l’aquila a due teste, ieri, alla Marina!». E mentre raccontava l’evento nei particolari, io rivissi le scene come in un film già visto chissà quando, immedesimandomi subito nel protagonista.
![]()
La seconda volta che Costantino Avati vide comparire l’aquila a due teste aveva diciotto anni e, per paura di essere preso per pazzo, non solo non ne parlò con nessuno, ma cercò di convincersi che forse aveva sognato a occhi aperti. Sulla prima comparsa, invece, non aveva dubbi e, sebbene da allora sia trascorso un quarto di secolo, ne serba ancora dei fotogrammi nitidi, qua e là staccati tra loro, sullo sfondo fisso del colore del cielo: azzurro, naturalmente, ma chiazzato di sbuffi di nuvole.
Lo aveva svegliato bruscamente la voce stridula e nervosa di sua madre, quel mattino, poco prima che i galli del vicolo cominciassero a cantare. Doveva sbrigarsi, gli diceva, se voleva andare alla fiera della Marina con nani Lissandro. Senza farsi pregare, come quando doveva andare a scuola, balzò dal lettino e in un baleno s’infilò i pantaloni senza toppe e la camicia di nylon verde dei giorni di festa.
Nel vicolo rischiarato dalla luce dell’alba, il vecchio Baialardo abbaiava ai gatti acciambellati sui balconi e nani Lissandro caricava due sacchi di fichi secchi sul mulo, imprecando contro il porcodemonio che lo aveva fatto debosciare: la vecchiaia è una carogna, një pjak ësht si një fjetë e thatë, un vecchio è come una foglia secca: una volta, un sacco di fichi lo lanciava in aria con una mano sola, ripeteva il nani, mentre ora a ottant’anni...
Per prima cosa Costantino lo salutò con un «mirëdita» sorridente, per fargli capire che era il bambino più felice del mondo, dopodiché lo aiutò a legare al basto le quattro capre che il nani era riuscito ad allevare quell’anno.
Poi buio.
Dieci anni prima, proprio alla fiera della Marina, il nani aveva venduto una cinquantina di capre, le sopravvissute all’inverno delle grandi nevicate e poi al gelo glaciale mandati dal porcodemonio. Centoventi capi gli erano morti: di fame, di freddo o sbranati dai lupi scesi dalla Sila. Per sé aveva tenuto Chicchinella e Gigina, le due capre più prolifiche e mansuete, e Baialardo, un grosso cane da mandria color caffè, con chiazze bianche attorno agli occhi neri. Non si sarebbe mai sbarazzato di loro, per nessuna ragione al mondo; erano vecchi amici, ricordi corposi e caldi. Alla fiera vendeva solo le tre, quattro caprette che le generose Chicchinella e Gigina figliavano e due sacchi di fichi bianchi che egli stesso raccoglieva e metteva a seccare nella sua quota di terra all’uscita del paese.
Di nuovo luce.
Arrivati in piazza, nani Lissandro sputò contro il portone del Palazzo di don Morello, come aveva fatto ogni volta che era passato di là prima dell’alba, esprimendo così il suo disprezzo verso i ricchi di Hora. Sì, una volta, all’epoca dell’occupazione delle terre, quando pareva che il mondo stesse per capovolgersi, aveva tentato di appiccare il fuoco al massiccio portone di noce, ma ci aveva rimediato un colpo di pistola che gli aveva sfiorato l’orecchio destro, e una settimana alla caserma dei carabinieri, durante la quale si era vergognato di se stesso per aver dovuto rinnegare l’accaduto.
Fuori paese s’infilarono nella mulattiera che ripida e stretta scendeva verso la striscia costiera della Marina. In fila indiana, dietro al mulo che faceva l’andatura, ticchettavano le quattro capre, il vecchio Baialardo coi suoi grandi occhi spalancati e il nani che strascicava i piedi pesanti e pensava ad alta voce e urlava qualcosa al mulo o si rivolgeva a Costantino o guardava il cielo, il sole rosso fuoco che lento usciva dal mare, schizzandovi sopra una lunga pennellata giallorossa. Fu a quel punto, quando anche Costantino guardava fisso verso l’orizzonte, che il nani cominciò a parlargli con voce grave, come se gli stesse rivelando una verità sacra.
Al di là dell’orizzonte, un giorno d’agosto come oggi, il mare è quieto, salpano tre galee di profughi: la prima è carica di giovani, la seconda di ragazze e la terza di pane e vino. Sbarcano sul lido della Marina, preceduti dalla grande aquila a due teste che li ha guidati e protetti giorno e notte, da quando sono stati costretti ad abbandonare l’Arbërìa, invasa dai turchi. Noi abbiamo lo stesso gjak, lo stesso sangue, di quelle genti.
Parlava con un’altra voce, grave e seria, con strascichi musicali alla fine delle frasi e una pronuncia così stretta che Costantino stentava a capirlo.
È stato Scanderbeg in persona a consigliare ai suoi di fuggire. Lui, con un pugno di uomini coraggiosi, è riuscito a resistere per anni all’esercito turco, il più potente e numeroso del mondo. Poi, ammalatosi di malaria, dopo aver incontrato l’ombra di vento che è la morte, ha detto al figlio: Fiore abbandonato, lule e kësaj zëmër time, fiore di questo mio cuore, prendi tua madre e tre galee, le migliori che hai, e fuggi subito di qui, perché se lo sa il turco, ucciderà te, e tua madre diventerà schiava. Ma prima di fuggire, quando arrivi al lido, lega il mio cavallo a un cipresso. Dispiega la mia bandiera e in mezzo legaci la mia spada. Quando soffia la tramontana, il cavallo nitrisce, la bandiera con l’aquila a due teste sventola e la spada tintinna. Se il turco li sente, si spaventa e, pensando alla morte che dorme sulla mia spada, non v’inseguirà per dove andate.
In un attimo a Costantino questo Scanderbeg fu più familiare di Garibaldi, l’Eroe dei Due Mondi che aveva studiato a scuola, e, montato sul mulo come se montasse sul cavallo del cipresso, si impadronì della storia con un lungo sospiro e uno sguardo a raggiera nel vuoto. Solo molti anni dopo, raccogliendo i canti e le rapsodie arbëreshe, si sarebbe accorto che il racconto del nani era un miscuglio di antiche rapsodie, i tasselli iniziali delle radici mitiche del suo mondo. Ma intanto aveva capito come mai a Hora si parlasse una lingua così diversa da quella che parlavano Zorro alla TV e il maestro a scuola e i litirj del circondario.
Arrivarono al piano e attraversarono la fiumara, dopo essersi rinfrescati in un rigagnolo che si perdeva tra pietre levigate e piatte.
L’aria cominciava a essere afosa. Il coro assordante delle cicale cresceva col crescere del giorno, e i mosconi e i tafani impazziti, imitati da nuvolette di moscerini, si poggiavano sul dorso sudato del mulo, sul muso bavoso delle capre, sul naso di Costantino, agli orli umidi degli occhi di Baialardo, sulle mani magre del vecchio; si poggiavano, ronzavano attorno e si poggiavano di nuovo e di nuovo ronzavano, disegnando una scia a zig zag nell’aria corposa.
Ora che il mare era vicino, Costantino non riusciva più a vederlo, nascosto com’era dai tronchi di platani giganti e, dietro di essi, dalle chiome di aranci, mandorli, fichi e ulivi. Insomma, non c’era niente da fare. Non c’è niente da fare. A chi il grano, a chi i sudori, pensò nani Lissandro ad alta voce ed era come se avesse parlato ai giardini di don Fidele Monello che aveva di fianco o al mulo che aveva davanti, non certo al nipote che gli stava alle spalle e che aveva sentito quella frase rotolare nell’afa.
L’ingresso alla Marina lasciò Costantino a bocca aperta. Puntò gli occhi verso il mare che vedeva sciabordare alla fine della strada dritta e polverosa. E non sentì più la voce del nani e i campanacci delle capre; non s’avvide degli escrementi a forma di olive e di mandarini di cui era costellata la strada e che pestava imbrattando le scarpine nuove; scorse appena, come da una macchina in corsa, le bancarelle zeppe di cianfrusaglie e di noccioline americane, disposte ai bordi della strada, e gli zingari e gli altri commercianti venuti da paesi lontani a vendere muli infiocchettati, vacche svizzere, aratri d’acciaio, tessuti di velluto, maialini, sigari toscani, statuette di Sant’Antonio; e non udì che l’eco dei martellanti «Huè, huè, pesce fresco, sardella da salare» dei pescatori, o dei suadenti «Ohi, ohi, che bel sale» delle donne, o dei richiami rimati del «Mago di Rossano che legge il destino nella mano». Costantino seguiva il nani come un automa, ipnotizzato dall’azzurro del mare-cielo.
«Costantì, Costantì, svegliati» lo scosse due, tre volte il nani, afferrandolo per un braccio. «Hai visto che abbiamo venduto le capre e i fichi a buon prezzo! Che fortuna, quest’anno! Ora andiamo a mangiare un boccone sulla spiaggia; verso sera, quando i prezzi si abbassano, compriamo le sarde e il sale.»
Arrivati sulla spiaggia, il vecchio si levò a fatica gli scarponi e le calze di lana; Costantino lo imitò, ancora un po’ stordito dai rumori della fiera e dall’immensa distesa d’acqua azzurra. A piedi nudi si avvicinarono alla riva del mare, seguiti da Baialardo che scodinzolava come un cucciolo. A un passo dall’acqua nani Lissandro s’inginocchiò sulla sabbia bagnata, vi appoggiò i palmi delle mani e, chiusi gli occhi, la baciò con la stessa tenerezza di cui è capace un bambino piccolo che baci la madre. Su questa spiaggia erano sbarcati i suoi antenati cinque secoli prima, spiegò a Costantino che con uno sguardo pieno di stupore gli aveva chiesto il perché di quel bacio. Per un attimo, Costantino fu attratto dalle labbra sottili del nani, imperlate di granellini di sabbia luccicanti. Ma poi si concentrò sulle piccole onde che si frangevano ai suoi piedi: ogni piccola onda gli portava un pensiero, un interrogativo: cos’avranno provato gli arbëreshë quando abbandonarono l’Arbërìa? Speravano di rivedere prima o poi la loro terra? Che volto avevano? Che lavoro facevano? Dove vissero i primi tempi? In che modo?
Come se avesse letto nei pensieri del nipote, il nani gli disse tranquillo: «Mangiare è stata la prima cosa che hanno fatto; avevano portato pane e vino, te l’ho raccontato, o no? Anche noi abbiamo pane e vino. Dunque, mangiamo, ti va?». E mentre mangiavano pane con formaggio di capra e fichi freschi, videro un altro vecchio, bianco come nani Lissandro, ripetere il rito del bacio. Era alto e scheletrico e camminava saltellando, come se a ogni passo volesse spiccare il volo. Al nani brillarono gli occhi: quel pazzo, disse, era Luca Rodotà, il rapsodo di Corone, il suo amico più caro, sottolineò con orgoglio, che da oltre mezzo secolo incontrava il giorno della fiera.
Costantino non fece caso al viso del vecchio, ma sicuramente era magro e stralunato, con due occhi del colore del cielo dopo la pioggia. Avrà avuto pure una lunga barba bianca e, inseparabile, a tracolla, una specie di mandolino con una corda sola, la lahuta, che gli copriva in parte il corpetto rosso. Così l’avrebbe rivisto qualche anno dopo; così se lo ricorda oggi.
I due vecchi si abbracciarono fraternamente. «Skumetiri se ki ësht Kustandini» disse il rapsodo e baciò Costantino come se lo conoscesse da sempre.
In breve si formò una piccola folla attorno ai tre. Erano arbëreshë di altri paesi del Catanzarese e del Cosentino. Si conoscevano tutti da anni e perciò diedero vita a un parlottio fitto fitto, in arbëresh e, quando non si capivano, in uno storpiato dialetto calabrese. Benché li ascoltasse attentamente, Costantino capiva solo in parte quello che gli uomini andavano dicendo; ognuno di loro parlava a modo suo, e chi diceva katundi, chi hora, chi vend, chi u paisi, per dire la stessa cosa. Ma i problemi che avevano e che introducevano con scoppiettanti po po po, quelli erano identici, come gocce d’acqua marina: l’affitto della terra che aumentava di anno in anno, l’uva con la peronospora, la voglia di andare a lavorare in Germania, come ormai facevano in tanti. Dunque bisognava rassegnarsi: nessuno avrebbe parlato dell’aquila a due teste, né del passato mitico che li accomunava; il presente prosaico li schiacciava tutti senza pietà. Invece: «Proprio in questa terra maledetta doveva posarsi l’aquila!» esclamò nel bel mezzo della discussione un uomo che dall’accento doveva essere di Puhërìu.
«Zitto, non bestemmiare!» lo rimproverò il rapsodo di Corone. «Le terre non sono mai maledette; sono gli uomini che sanno essere maledetti; che sono capaci di succhiare il sangue ai propri fratelli. L’aquila non ha nessuna colpa!» E così dicendo fissò il sole, dopo aver alzato il volto verso il cielo, con un movimento lento, ca...