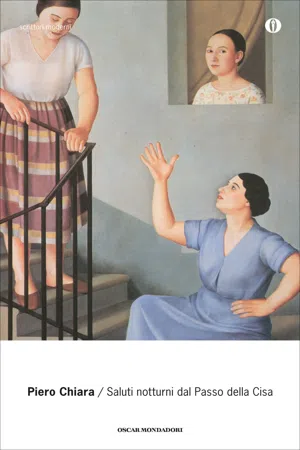![]()
![]()
Nella primavera d’una trentina d’anni or sono si era fatto notare a Parma, dove aveva preso alloggio nel migliore albergo, un tal Pilade Spinacroce, proveniente dal Sud America e apparentemente intenzionato a stabilirsi in città o meglio ancora in qualche località dei dintorni, se gli fosse capitato di comprar bene una villa padronale, magari circondata da un bel podere.
Si era fatto notare, lo Spinacroce, non solo per la sua aria forestiera, ma anche per la sua taglia, che eccedeva largamente la media. Chi lo incontrava sull’entrata d’una banca o nella “ruota” d’ingresso dell’albergo, dove aveva la sua base, non poteva fare a meno di voltarsi a guardarlo e di stare un momento a considerare la sua figura. Portava, benché i rigori dell’inverno avessero già ceduto ai primi tepori di primavera, un soprabito scuro di gabardine più lungo davanti che dietro e un cappello nero floscio, che ne accrescevano la corposità. La sua faccia, che si vedeva sotto l’ala del cappello e che solitamente teneva chinata, era quella d’un pizzicagnolo o di un negoziante di maiali: massiccia, carnosa, senza espressione.
Un curioso di quelli che abbondano nelle città di provincia avrebbe subito rilevato che lo Spinacroce doveva soffrire di calli e di duroni, oltre ad avere un paio di “noci” deformate e dolenti all’attacco degli alluci. Infatti portava scarpe larghe, di pelle morbida, e camminava cedendo sulle gambe storte, per pesare il meno possibile sui piedi.
Tale era il suo aspetto, dal quale sembrava possibile dedurre un carattere forte, scontroso, combattivo.
Ma di un uomo come lo Spinacroce, al di là dei dati apparenti, sarebbe stato del massimo interesse conoscere l’animo o anche soltanto la mente, quel che aveva capito del mondo, quali strade aveva battuto, per esempio nel campo delle più comuni conoscenze. Sapere quel che pensava dell’aldilà, di Dio, delle sofferenze umane. La sua storia e specialmente quella parte che trova posto in queste pagine, addirittura lo esigerebbe. Ma come venirlo a sapere dal momento che è vano supporre, o peggio immaginare simili dati?
Si potrebbe forse utilizzare a tale scopo un filo, assai sottile e fragile, fornito da persona che ebbe occasione d’avvicinarlo più volte: il notaio Quarenghi, di Parma, presso il quale fece capo per un certo tempo.
«È uno che legge» disse un giorno il notaio parlando di lui. I pizzicagnoli, i mediatori, i piantatori o gli impresari impegnati ad arricchire, normalmente non leggono. Lo Spinacroce invece leggeva, come si poté accertare meglio in seguito, non solo libri sulla situazione economica e politica del mondo, ma anche romanzi del primo Novecento, italiani e stranieri. Leggeva inoltre un paio di quotidiani e non è detto che si limitasse alla politica, alla cronaca e alla Borsa. Nel corso della giornata poteva estendere il suo interesse anche alla terza pagina e agli inserti speciali. Le pareti dello studio, al pianterreno della villa dov’era andato ad abitare, erano coperte di libri antichi, acquistati insieme allo stabile e al mobilio. Libri mai toccati, belle legature, opere in venti e più volumi, forse mai aperti da più generazioni. Ma nella stanza in alto dove dormiva, sotto il tetto, aveva i “suoi” libri, fra i quali alcune opere di Simenon, una decina di volumi verdi della “Medusa” e un libro di poesie di Guido Gozzano: La via del rifugio. Semplice indizio non tanto di un interesse alle riflessioni sul mondo fatte da qualche ingegno letterario, quanto di un certo distacco dalle cose pratiche, che rivelava una natura non inaridita dal denaro e dalle lotte sostenute per accumularlo.
Simili uomini, che stanno nella nostra società tra la massa e le confraternite degli intellettuali, dei ricchi e dei potenti della politica, vengono comunemente detti imprenditori, in quanto hanno intrapreso attività industriali e commerci senza badare al genere, ma con una determinazione, una tenacia, una capacità di fatica che stupisce i pacifici. Sono, codesti, gli uomini che fanno camminare il mondo, in che direzione non importa, come non importa l’attività delle formiche, delle api o d’altri animali che sembrano inutili e hanno invece il loro compito nel meccanismo della natura.
Lo Spinacroce si diceva originario della città di Parma, benché nessuno a Parma lo ricordasse. Emigrato intorno al millenovecentotrenta, aveva sposato a Salta, nell’interno dell’Argentina e ai piedi delle Ande, la figlia di un piccolo albergatore anche lui di Parma, impiantato da più di vent’anni in Sud America.
Erano notizie vaghe, lasciate cadere da lui stesso nei discorsi con mediatori e direttori di banca coi quali era entrato in contatto.
Da Salta a Buenos Aires, da Buenos Aires a Temperley nell’estremo sud, lo Spinacroce era stato volta a volta impresario di costruzioni, importatore di macchine per l’agricoltura, piantatore di caffè, allevatore di bestiame, ma soprattutto affarista e speculatore.
Mortagli la moglie e non trovando più gradevole il mondo degli affari in Argentina dopo l’avvento dei regimi autoritari, aveva deciso, verso i sessant’anni di età, di ritornare nei luoghi nativi per passarvi una vecchiaia tranquilla, lontano dai traffici e disponibile soltanto a qualche modesto impiego di denaro, nel caso gli si fossero presentate delle buone occasioni.
Nel giro di poche settimane, pur illudendosi di passare inosservato, si era fatto conoscere da mezza città, frequentando banche, studi notarili, mediatori, geometri e ingegneri. Subito si era sparsa la voce della sua ricchezza, che consisteva, secondo le opinioni correnti, soprattutto in una scorta cospicua di valuta pregiata: dollari, marchi e franchi svizzeri, che aveva tesaurizzato in Argentina e che gli era riuscito di trasferire chissà come in Italia, dopo aver liquidato ogni sua proprietà e interesse nel Sud America, diventato a suo parere un mondo di miseria, dove non c’era più posto per persone oneste e laboriose come lui, ma solo per politicanti e avventurieri.
Alto come era, grasso di spalle e un po’ anche di ventre, col capo sempre piegato sul petto ma lo sguardo diritto in avanti, lo Spinacroce imponeva rispetto e considerazione non solo per la sua fama di uomo danaroso, ma anche per i suoi modi asciutti, da uomo d’azione che sapeva sempre quel che c’era da fare, in ogni occasione. Nonostante l’età ormai più che matura, aveva capelli abbondanti, lisci e ancora quasi del tutto neri. I baffi, che portava cortissimi, erano più neri che grigi, ma ispidi come i crini d’uno spazzolino per i denti.
Dopo varie trattative, l’Americano, come veniva chiamato nei caffè, aveva trovato quello che cercava: una vecchia villa signorile ma senza pretese, circondata da un vasto parco, nei dintorni di Langhirano. La villa era abbandonata da qualche anno, ma in un mese o due venne ripulita. L’arredamento era ottocentesco, solido e di ottima qualità: bei mobili di noce che lo Spinacroce seppe apprezzare, ampie poltrone e divani coperti da velluti pregiati.
Contento del suo acquisto, l’Americano andò ad abitarvi dopo aver assunto un giardiniere e una cameriera tutto fare. Da quel giorno non lo si vide più nei caffè né per le strade di Parma. Abbandonato ogni contatto con i professionisti ai quali aveva dovuto ricorrere, si era chiuso nel suo possesso, quasi che la cordialità e la bonomia dimostrate con saggia misura a Parma non avessero più ragione di manifestarsi da quando aveva raggiunto il suo scopo. A Parma andava in media una volta al mese, facendosi accompagnare in macchina da un noleggiatore di Langhirano, tal Angelo Beretta. Metteva il naso in qualche banca e tornava subito alla sua villa.
Benché non si curasse degli altri, gli altri non avevano smesso di tenerlo d’occhio e di farne conto, sia per i suoi denari e sia per la curiosità che destava. Sotto una maschera bonaria il suo viso lasciava infatti scorgere un’ombra di mistero.
Si era saputo che aveva una figlia, venuta in Italia dieci anni prima di lui, insieme a un medico italiano, il dottor Francesco Salmarani che aveva conosciuto e sposato in Argentina contro la volontà del padre.
Myriam Salmarani nata Spinacroce, una distinta signora di trentacinque o quarant’anni all’incirca, viveva a Bergamo col marito oculista dal quale aveva avuto un figlio, Albertino, affetto fin dall’infanzia d’una disfunzione glandolare detta morbo di Simmons, per la quale era cresciuto in modo anormale, tanto che a sedici anni era alto quasi due metri, spaventosamente magro e di aspetto mostruoso. Andava in giro tenuto per mano dal padre e dalla madre, col volto stralunato, che volgeva a destra o a sinistra senza ragione e buttando avanti le gambe come per dare calci a una palla.
Qualche anno dopo e quando lo Spinacroce si era già insediato nella sua villa di Langhirano si venne a sapere che i Salmarani, pur abitando a Bergamo dove il medico aveva il suo studio, passavano i mesi dell’estate a Lerici, in una villetta sul lungomare, a ridosso di un antico parco e con vista su tutto il golfo.
La casa di Lerici era stata acquistata dallo Spinacroce col proposito di stabilirvisi in vecchiaia. L’aria di Langhirano, buona per i prosciutti e per le bondiole, poteva diventare sconsigliabile, gli aveva detto un medico, se l’enfisema polmonare del quale già soffriva si fosse aggravato col passare del tempo.
Nell’estate di quell’anno la signora Myriam aveva ottenuto dal padre l’uso della villetta di Lerici ed era andata ad abitarla insieme al figlio, con l’intenzione di trascorrere anche la stagione fredda in riviera, affinché il povero Albertino beneficiasse del clima marino e anche perché i Salmarani si vergognavano di far vedere per le strade di Bergamo il ragazzo, che con la crescita aveva preso un aspetto sempre più allampanato e macilento.
Fin dall’inizio di quel soggiorno al mare della sua famiglia, il dottor Salmarani aveva preso l’abitudine di andare ogni sabato in visita ai suoi, coi quali passava tutta la domenica, per prendere poi la via del ritorno appena la moglie e il figlio si ritiravano nelle loro stanze.
Quando, all’inizio dell’estate, si era trattato di farsi concedere dal vecchio Spinacroce l’uso della casa al mare, i due coniugi erano andati più volte nella villa di Langhirano, con il ragazzo, che appena vedeva il nonno si agitava e cominciava a farfugliare, ballonzolando come un babbuino sulle lunghe gambe e alzando le braccia come se volesse abbracciarlo. Lo Spinacroce si ritraeva un po’ disgustato da quel nipote, che gli pareva una giusta punizione per la figlia, la quale invece di sposare un grosso piantatore di caffè oriundo svizzero di Montevideo che le aveva proposto, si era lasciata irretire da un mediconzolo italiano senza soldi e senza voglia di lavorare, arrivato in Argentina per far fortuna in qualunque modo e magari anche attraverso un ricco matrimonio.
Prima di allora Myriam aveva frequentato raramente la villa, benché si fosse riconciliata col padre fin dai primi tempi del suo ritorno in patria. Sapeva che il padre vedeva di malocchio suo marito e addirittura con ripugnanza il povero Albertino, ma sentendosi erede e avendo anche lei notizia forse più precisa degli altri della ricchezza del genitore non voleva perdere contatto con lui. Arrivava al punto di mettere il naso nei suoi interessi, informandosi sui terreni che aveva acquistato nei dintorni dopo aver comperato la villa e giungendo perfino a sindacare la scelta delle donne di servizio, delle quali lo Spinacroce pareva stancarsi facilmente, tanto che le sostituiva una dopo l’altra, passando dalle prime che erano sulla cinquantina, a giovani donne di trenta e anche venticinque anni.
L’ultima di queste, così intelligente e servizievole da render superfluo ogni altro aiuto in casa salvo quello d’un giardiniere che lavorava a giornata, era una giovane di non più di trent’anni, Maria Malerba, originaria d’un paese dell’Appennino parmense ma domiciliata a Langhirano.
Nonostante la sua aria di donna sicura della propria forza, Maria si portava dietro il peso di un errore di gioventù: un figlio di cinque o sei anni, di padre sconosciuto. Morti da tempo i suoi genitori, abitava a Langhirano con una zia, una cugina e il bambino, ma dopo il collaudo come governante dello Spinacroce, durato non più di un mese, andò a stare nella villa, dove occupava una stanza al pianterreno, di fianco a un bagno di servizio.
Lo Spinacroce, che nei primi tempi aveva dormito in una grande camera da letto del primo piano, si era trasferito in una specie di mansarda forse una volta abitata dalla servitù, accanto alla quale c’era un bagno. Il locale, che prendeva luce da due finestre ad abbaino sulla facciata della villa, era basso di soffitto ma ampio e luminoso. Il signor Pilade vi aveva sistemato la sua raccolta di oggetti esotici: pelli di leopardo e di leone con le teste imbalsamate, maschere di legno, scudi di cuoio con infilate lance e zagaglie, trofei di frecce e archi, pelli di serpente, crani di bisonti e d’altri animali cornuti, tamburi, un piccolo caimano imbalsamato e alcune grandi farfalle tropicali dentro cassette di vetro. Tra le due finestre aveva il letto, grande e quadrato, bassissimo e coperto durante il giorno da una pelliccia di guanaco. Per terra si stendevano, oltre alle pelli di leone e di leopardo, pelli di vacca, di zebra e di cavallo. Pareva la stanza di un esploratore. Lo Spinacroce vi stava a suo agio, qualche volta delle giornate intere, a sfogliare giornali e riviste che gli arrivavano dal Sud America, a leggere o più probabilmente a dormire, nella pace e nel silenzio che gli garantiva il folto parco intorno alla villa.
Maria si occupava del pianterreno o piano rialzato dove oltre alla sua stanza, che era sul retro verso l’orto, c’erano da un lato la cucina e la sala da pranzo e dall’altro i locali di rappresentanza: i salotti, lo studio, un grande soggiorno e una sala da biliardo.
Il primo piano, con le camere da letto, gli spogliatoi e un bagno assai lussuoso, appariva dall’esterno chiuso e come avulso dal resto della villa. Le persiane della facciata e anche quelle verso l’orto, sempre chiuse, facevano pensare, agli osservatori poco accorti, che la villa fosse disabitata o che ospitasse solo un guardiano.
Le donne di servizio dello Spinacroce, fin dalla prima, ebbero sempre ordine di spolverare superficialmente i mobili della sala di biliardo e di limitare la pulizia ad una scopatura settimanale. Il bel locale rettangolare era ammobiliato con un paio di sedie e un divano, aveva due specchi alle pareti, tendaggi alle finestre e un doppio lampadario in ottone che si abbassava a un metro e mezzo dal piano del biliardo. Sul fondo, di fronte alla porta d’ingresso, la parete era quasi completamente coperta da un mobile complicato che comprendeva due rastrelliere per le stecche e una cassettiera sovrastata da uno specchio ovale, dov’erano custodite le bilie, i birilli e gli altri accessori del gioco. Solo allo Spinacroce era noto che una parte del mobile, montata su due cardini, poteva essere staccata dal muro come una porta. Un accorgimento che gli era stato rivelato dal mediatore e destinato a nascondere un armadio a muro, chiuso da una porta blindata simile a quella di una cassaforte, con tanto di serratura di sicurezza e con un dispositivo per formare il numero occorrente a liberare i meccanismi di chiusura. La porta blindata era mascherata da una porta comune a due battenti. Appiccicata con la colla alla parte interna del battente destro, lo Spinacroce aveva trovato una busta gialla dentro la quale, su di un foglio piegato in quattro, era scritta la spiegazione dei vari congegni di sicurezza e indicata la cifra necessaria ad aprire la cassaforte. In fondo al foglio si leggeva: “La chiave è appesa all’interno del battente di sinistra”. La chiave infatti era al posto indicato.
Maria, nel fare le pulizie, si era accorta del nascondiglio dove lo Spinacroce doveva aver collocato la sua favolosa scorta di dollari, marchi e franchi svizzeri, ma aveva rimesso a posto la rastrelliera senza dir nulla, badando a lasciarla staccata di qualche centimetro, così come l’aveva trovata.
Quando di tempo in tempo il vecchio si chiudeva nella sala del biliardo, sentendo gli schiocchi delle palle Maria credeva che si divertisse a giocare da solo. Invece, pur dando qualche colpo di stecca, si dedicava ad altre operazioni, perché quella era per lui la stanza del tesoro.
![]()
In quell’estate, quando ormai avevano ottenuto l’uso continuativo della casa al mare, i Salmarani, in un viaggio di andata a Lerici attraverso il Passo della Cisa che era la strada più breve, deviarono per Langhirano. Fu in quella occasione che si accorsero del mutamento avvenuto nella servitù. Era scomp...