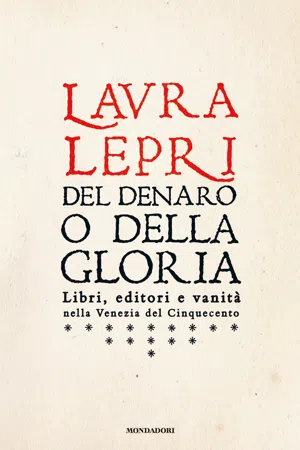![]()
Era stato il suo destino fin dalla nascita, e tale sarebbe rimasto fino a quel giorno di fine settembre del 1542 quando avrebbe esalato l’ultimo orgoglioso respiro: l’esistenza di Giovan Francesco Valier sarebbe stata un incessante susseguirsi di ambizioni, riconoscimenti, solitudine, polemiche, ricche prebende, amicizie importanti e sospetti molto velenosi. Valerio, così lo chiamavano, alla latina, i tanti illustri amici, fu un uomo di successo e di potere. Del resto, la vita lo aveva allenato ben presto a navigare per l’alto mare aperto.
Era figlio naturale di Carlo Valier, gentiluomo di grande autorità in Venezia, che avrebbe sostenuto sempre con energia, affettuose raccomandazioni e parecchio denaro quel figlio al quale la condizione di illegittimo, sia pur riconosciuto, non avrebbe mai concesso alcun privilegio.
Solo la carriera ecclesiastica, rifugio accogliente e molto ambito in quegli anni, avrebbe potuto assicurargli un adeguato posto nel mondo; e il giovane Valier, appena poté, la percorse con tenacia, sorvegliato con tenera apprensione da quel genitore che, sopra ogni cosa, voleva vederlo diventare un “homo da bene”. “Per suo amore”, più di una volta si disse disposto a spendere anche “qualche migliara de ducati”, purché Giovan Francesco riuscisse a conquistare un’adeguata posizione sociale.
L’ideale sarebbe stato raggiungere Roma e mettersi al servizio di qualche cardinale importante. La Chiesa, mater dulcissima, avrebbe potuto dargli quello che la legge degli uomini non consentiva che avesse.
Così, il ragazzo Valier si fece chierico giovanissimo, prendendo i voti nel 1505. E, ambizioso e volitivo qual era, nel giro di nemmeno una decina d’anni riuscì a raggiungere il suo obiettivo, diventando il segretario del potente cardinale Bernardo Dovizi da Bibbiena.
Prima, però, per allenarsi alle relazioni di alto lignaggio, grazie al padre, che all’occasione curava gli interessi dei Gonzaga a Venezia, trafficò per un certo tempo con il marchese di Mantova, recandosi spesso in quella città e prodigando le proprie energie per ambasciate e scambi di cortesie fra i signori del luogo e l’intellighenzia veneziana.
Uno dei suoi più cari amici, forse il prediletto, era Pietro Bembo, colui che sarebbe diventato un uomo decisivo per le patrie lettere, scrittore, poeta e teorico del volgare letterario. Avevano la stessa età e Giovan Francesco fin da ragazzo aveva avuto modo di frequentare abitualmente la sua dimora sulla Fondamenta del Vin, in pieno Canal Grande, ai piedi del ponte di Rialto.
Anzi, fu proprio muovendosi nelle stanze del grande palazzo dei Bembo che il Valier s’appassionò a quel culto delle “antichità” che stava prendendo piede a inizio secolo, diventando ben presto anche lui collezionista di busti, medaglie e monete latine.
Già, appena ne aveva le possibilità, Valerio imitava l’amico Pietro. Era il suo modello: ricco, coltissimo, di nobile famiglia, con un padre che rappresentava con ogni autorevolezza le istituzioni cittadine. Quello che anche lui avrebbe potuto essere.
Fatto sta che già nel 1505 Valerio scriveva al nobile vicentino Giovan Giorgio Trissino, chiedendogli in prestito con insistenza, proprio a nome del Bembo, una medaglia che rappresentava una donna dal sembiante molto simile a quello che aveva ispirato il personaggio di Berenice negli Asolani, il dialogo sull’amore che Pietro aveva fatto stampare proprio in quell’anno. Quella medaglia, però, il Trissino, non l’avrebbe più rivista. Ancora a distanza di dieci anni ne avrebbe richiesta la restituzione a misser Bembo. Molto probabilmente era rimasta nella collezione del Valier.
Dal canto suo, Pietro Bembo mostrava sempre parecchia indulgenza nei confronti del suo coetaneo; chissà, forse sapendo che non poteva contare sulle sue stesse certezze sociali e familiari.
Lui, a differenza del caro Valerio, fin da giovane aveva seguito più volte il reverendissimo genitore nelle tante ambascerie per la Serenissima; e molto presto aveva preso a muoversi per le città italiche anche da solo – accompagnato cioè solo dal fido Cola Bruno, suo segretario –, educato a essere uomo di mondo, capace di squisite bienséances, quelle ottime maniere di cui sarebbe diventata regina la Francia nel secolo successivo, il cui alfabeto, però, era stato coniato nell’Italia delle corti.
Era andato a studiare il greco a Messina, per esempio, in compagnia del coetaneo Angelo Gabriele, fratello dell’amico Trifone. Da quella città di antica cultura, dopo aver frequentato le lezioni del maestro Lascaris, era tornato con la sua prima opera scritta in latino, il De Aetna, stampata da Aldo Manuzio senza alcun indugio. Pur essendo molto più giovane di Aldo, il Bembo non si era peritato a suggerirgli, con buona grazia s’intende, di inserire qualche elemento di punteggiatura nel suo trattato di geografia. E fu così che, in un testo a stampa, comparve per la prima volta la virgola uncinata.
Poi, aveva ripreso a soggiornare presso le varie corti della penisola, muovendovisi con le volute eleganti di un pesce nel suo acquario.
Fu proprio al coetaneo Valerio che Pietro si rivolse, nell’aprile del 1505, per far avere a Isabella d’Este Gonzaga tre sonetti che aveva appena composto: teneva molto alla relazione, per il momento solo epistolare, con quella signora colta e attenta all’arte, quale si era già mostrata Isabella con il padre Bernardo. Era una donna di straordinaria cultura, anch’essa amante della classicità romana – lo testimoniava la sua ricca collezione di statue d’epoca latina –, nonché eccellente conoscitrice di musica.
Di lì a qualche anno, lo stesso Valier le avrebbe sottoposto un madrigale, scritto di suo pugno. Intanto, si prodigava per tener vive le relazioni fra la nobildonna e la famiglia Bembo.
Capitava spesso, infatti, che Isabella chiedesse in prestito a Sua Eccellenza Bernardo quadri e antichi manoscritti conservati nella biblioteca di famiglia, una delle più ricche della città, insieme a quella di Marin Sanudo. Così, solo per godere della loro bellezza. In capo a qualche mese, li restituiva.
Quell’anno, a fine giugno, Pietro sarebbe passato da Mantova per incontrarla finalmente di persona, ma intanto, da attento cultore della norma mondana, aveva voluto farle un omaggio letterario, approfittando dei buoni uffici di “messer Zoan Valerio, parte de la mia famiglia”, come le annunciò per lettera.
Quel giovane uomo, esuberante, generoso, e abile nel riconoscere le buone frequentazioni, si prestava volentieri ad assolvere incarichi di varia natura, foss’anche un semplice gesto di cortesia.
Come il recupero di quell’“horologiuzzo, fino et molto ben fatto” che Bernardo aveva mandato a riparare proprio a Mantova, ma che, dopo la morte dell’orafo al cui cesello si doveva l’oggetto, rischiava di andare perduto se non fosse intervenuto il marchese stesso. Quando sua signoria avesse voluto aiutarlo a tornarne in possesso, “Zuanfrancesco” glielo avrebbe riportato. Così scrisse il Bembo senior al Signore mantovano, pregandolo di intervenire.
Erano in molti a Venezia, fra nobili e mercanti, a collezionare orologi pregevolmente intarsiati dagli orafi più valenti in circolazione nella pianura padana. Il tempo era un valore per tutti.
Intanto, fra un favore e un’ambasceria, il chierico Valerio frequentava la classe dirigente e ne apprendeva modi e regole di comportamento.
Nel biennio fra il ’10 e l’11, recapitò molte lettere del marchese alla Serenissima, contenenti importanti notizie militari. Per un periodo si fece addirittura mediatore di una proposta di assunzione di quel nobiluomo di Mantova a capitano generale dell’esercito veneziano, come riportò puntualmente il Sanudo. Nulla continuava a sfuggire al cronista di quello che succedeva in città, mentre le responsabilità di Giovan Francesco Valier diventavano sempre più delicate e importanti.
In quegli anni di apprendistato non trascurò, oltre alle relazioni sociali, nemmeno gli studi umanistici e, sulla scia di Boccaccio, prese a scrivere “alcune novelluzze”, parte delle quali inviò al suo signore mantovano con la preghiera di “accettarle et goderle”.
Giovan Francesco stava rivelando doti di brillante novellatore: gli piaceva raccontare storie e aneddoti, soprattutto se alludevano a faccende amorose un po’ piccanti. Erano il suo passepartout mondano. Grazie a quelle bagatelle si trasformava in un irresistibile intrattenitore di conoscenti e amici. Amava farli sorridere, meglio se con malizia.
Aveva un carattere conviviale, allegro, sia pur attraversato, di tanto in tanto, da qualche nuvolaglia nera. E coltivava una vera e propria passione per le “moderne historie”, quei fatti veri che avessero per epicentro le donne.
Negli anni avrebbe raccolto un numero infinito di quelle storie, e buona parte le trasformò in novelle scritte. La tradizione in lingua volgare non mancava di certo. Ma ben presto, per irrobustire il suo tirocinio letterario, prese a misurarsi anche con il poema epico-cavalleresco, e con la forma più classica della poesia, il sonetto. Scrisse in versi e in prosa, provò e sperimentò, senza, tuttavia, portare mai a compimento alcuna opera, rivelando così una certa discontinuità nell’applicarsi alla scrittura. Non come l’amico Pietro, sistematico, rigoroso e produttivo fin dalla gioventù.
Forse a quel periodo, o più verosimilmente ad anni di poco successivi, potrebbe risalire un lungo componimento poetico sul quale merita di soffermarsi con qualche attenzione; e non solo perché quei versi mostrano una certa approssimazione, un impaccio, un’innegabile precarietà nella tensione fra lessico e metrica, segno, ahimè, del suo dilettantismo. È soprattutto la materia a meritare un indugio.
Al tema dell’infelicità amorosa, poco originale a dire il vero, di pedissequa scuola umanistica, si sovrappone, infatti, una fantasia mortuaria densa di significati, se ci fosse concesso di fare del facile biografismo.
Ebbene, in quei versi l’io lirico che vi si esprime, ovviamente “lasso” poiché colpito “al cor” da ferita mortale, immagina di soccombere giovane e di invocare “qualche parola” di pietas da quegli “spiriti altier” che tanto l’hanno amato.
Sfilano a quel punto in sequela gli amici dai quali si invoca il ricordo postumo: il coetaneo Andrea Navagero; il poeta marchigiano Marco Cavallo – ben inserito in Venezia grazie al Bembo, finito suicida, tuttavia –; il mantovano Antonio Tebaldeo, precettore di Isabella d’Este, poeta in volgare e sodale del Valier durante il soggiorno romano; e il “Dovizio gentil”, il potente cardinale Bibbiena alla cui protezione il Valier avrebbe mostrato per sempre riconoscente memoria.
Gli amici saranno un cardine fondamentale nella sua esistenza, fino all’ultimo dei suoi giorni. La sua vera famiglia.
Tale “ghirlanda” di fratelli è evocata dall’oltretomba da un io che è stato il primo artefice dei suoi mali, “che corse volontario a sue ruine”, “poi che ’l maggior suo fal fu il desiare”.
Naturalmente, la colpa chiamata in causa è, apparentemente, quella del desiderio d’amore ma, sottotraccia, forse c’è qualcosa di più: la sua ambizione. Il poeta, infatti, non ha saputo discernere, riconoscere gli “inganni del mondo”, né “star costante / ne l’adversa fortuna e ne gli affanni”. Se l’avesse fatto, se avesse tenuta dritta la barra del disincanto e insieme della fermezza d’animo, ora non si dorrebbe delle sue “tante noiose angoscie, biasimando ad alta voce / a un tratto, come fa, gli occhi e le piante / Perché queste il menâr troppo veloce / ove non dovea gir quelli a mirare / cosa che ancor veduta assai gli nuoce”.
I suoi occhi hanno visto quello che non dovevano vedere. Da cui l’angoscia, la noiosa angoscia, la depressione, diremmo oggi. Forse si è trattato di un tradimento, qualcosa a cui era meglio non assistere. Non guardare, non vedere.
La suggestione è inevitabile.
Infatti, se con atto arbitrario si proiettasse tale malessere profondo, ma soprattutto le sue cause, sul futuro del Valier, potremmo far assurgere il suo malinconico stato d’animo anche a sinistra premonizione. Molte cose non avrebbe dovuto vedere nella sua vita, Giovan Francesco Valier.
Ma non volendo precorrere troppo i tempi, né indulgere soverchiamente nelle letture dei fondi del caffè, preferiamo seguire quella schiera di spiriti eletti, là dove si sono tutti trasferiti. Per il Valier e i suoi sodali, infatti, sono iniziati gli splendidi anni romani.
Giovan Francesco fu chiamato alla corte pontificia per entrare al servizio di Bernardo Dovizi da Bibbiena, il cardinale che, qualche anno prima, aveva seguito in esilio, a Urbino, Giovanni de’ Medici. Era stato proprio in quella città che il Bibbiena aveva stretto un forte legame, di stima e d’affetto, con Baldassar Castiglione, all’epoca non ancora chierico.
Appena divenuto papa con il nome di Leone X, quel Medici aveva nominato cardinale il Bibbiena medesimo che, a sua volta, convocò nella capitale Giovan Francesco Valier, permettendogli di entrare finalmente a far parte di uno degli establishment più potenti nella penisola. Anzi, il più potente, insieme a quello veneziano. Quest’ultimo era ormai ben noto al Valerio.
Intorno al 1515, Roma vide riunita una nutritissima accolita di amici: oltre al Valier arrivarono Pietro Bembo, assunto nella segreteria di Leone X e addetto ai “brevi” – dispacci scritti per affari di ordinaria amministrazione pontificia che lui vergherà in alto stile ciceroniano –, Baldassar Castiglione, ambasciatore dei duchi di Urbino, e Andrea Navagero, giunto da Venezia per studiare l’arte classica. La crème de la crème umanistica. Bella solida e in intensa relazione intellettuale.
Due anni prima, per esempio, proprio in Urbino, il Castiglione aveva partecipato alla fortunata messa in scena della Calandria del Bibbiena, beffa amorosa in cinque atti nel cui prologo “rivoluzionario” si annunciava l’assoluta novità di una commedia “in prosa, non in versi; moderna non antiqua; volgare non latina”. Il teatro si stava aprendo alla contemporaneità.
Per contro, nel Cortigiano il Bibbiena sarà uno dei conversatori più acuti e brillanti. Come a dire che il sodalizio del gruppo era agli atti, nella vita e nella scrittura.
Tutti insieme, oltre che la corte pontificia – immersa in un carnasciale permanente, fra cacce, mascherate, banchetti, spettacoli e lussurie di ogni natura, fonte di scandalo e delle più feroci reprimende di Lutero e dei riformatori –, presero a frequentare anche il grande Raffaello, già all’apice della fama.
In una lettera dei primi di aprile del ’16, fu lo stesso Pietro Bembo a informare il cardinal Bibbiena che prevedeva di compiere, per l’indomani, una gradevole gita a Tivoli, fra i resti delle dimore romane. Proprio in quegli anni l’amore ritrovato per la classicità da tutti gli umanisti aveva individuato un magnifico simulacro nelle rovine della villa Adriana.
In compagnia di uno dei suoi segretari, Agostino Beazzano, del Castiglione, del Navagero e del medesimo Raffaello, scriveva il Bembo al Bibbiena, avrebbero passeggiato fra terrazze, forre, caverne e impetuose cascate naturali.
Solo più avanti, nella seconda metà del secolo, quei luoghi sarebbero stati piegati dalla mano dell’uomo trasformandosi, almeno in parte, in uno dei più sontuosi modelli di giardino all’italiana: in quel momento erano ancora rupestri e incontaminati loci amoeni che ben si prestavano a fantasie e peregrinazioni di virgiliana ascendenza.
Discettando di antichi e di moderni, quegli uomini di eclettica cultura solidarizzavano anche nel patire la dissociazione fra le ambizioni letterarie e gli impegni istituzionali, fra il bisogno di solitudine, silenzio, riflessione – così come l’aveva intimamente sentito un altro maestro, il Petrarca –, e i più feroci intrighi politici: era l’argomento preferito, il tema esistenziale per eccellenza in quell’inizio di Cinquecento. E lo sarebbe rimasto a lungo.
Di lì a poco, Raffaello, in quel periodo intento nello studio dei volti, avrebbe ritratto sia il Castiglione sia il Navagero. Il magnifico dipinto dedicato all’amico Baldassarre gioca sulla gamma dei toni bruni degli abiti, di intensa e calda armonia. Un elegante copricapo cela le stempiature, e la fronte, serena, è illuminata da un lembo di camicia color panna.
Il veneziano Andrea è immortalato insieme al Beazzano: l’insolito ritratto a due “voci” mira a catturare le diverse, simmetriche psicologie grazie alle proiezioni della luce: più semplice, chiara, mite, connotata da una dolce bonomia, quella del segretario del Bembo; più aus...