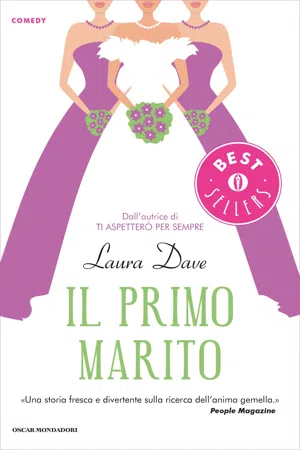Una delle prime cose che mi aveva insegnato Checking Out era quanto poteva essere meraviglioso l’inizio di un viaggio. Nella vita non c’è nulla di più appagante della sensazione che al principio di un’avventura tutto è possibile e si può fare quel che si vuole. Si può raggiungere Amsterdam da Bruxelles a bordo di una macchina decappottabile, oppure trascorrere un pomeriggio di sole da Don Alfonso a Sant’Agata sui Due Golfi a mangiare il limone più fresco del mondo (con buccia e tutto), o passare una serata a cantare al karaoke del Townhouse di Tokyo. Puoi fare un milione di scelte diverse, o anche nessuna, senza particolari conseguenze. Ci ho messo un po’ di tempo a capire quanto sia impagabile una sensazione del genere e perché.
Non solo perché all’inizio di un viaggio il mondo ci appare luminoso e alla nostra portata, ma anche perché ci viene dato di crederci di nuovo. All’inizio – prima che comincino a intravedersi delle incrinature, prima che il tempo inizi a stringere, prima che facciamo una scelta sbagliata; prima che ci rendiamo conto che qualcosa sta andando a rotoli per colpa nostra – all’inizio, ci è dato di credere che stavolta andrà tutto bene.
Quando io e Griffin arrivammo a Williamsburg per la prima volta e percorremmo la sonnolenta via principale, passando davanti al campanile della chiesa e all’ufficio postale, con gli alberi di Natale ancora in mostra e una neve leggera che cadeva posandosi sullo strato bianco rimasto dal giorno prima, non sapevo bene perché fossi tanto commossa e soddisfatta. Eppure estrassi subito la macchina fotografica e cominciai a scattare. Nel corso degli anni avevo percorso la via principale di centinaia di cittadine, ed erano tutte composte da elementi molto simili. In verità, ne avevo viste di molto più pittoresche. Stavolta però c’era qualcosa di diverso. Quella via aveva qualcosa di speciale. Come se ci fossi già stata. O come se avessi saputo che ci sarei tornata, e quella non fosse la prima volta che la vedevo, bensì la millesima. È una cosa che riconosci in modo inequivocabile, come se quello fosse il luogo in cui avresti dovuto essere.
Evidentemente sprizzavo entusiasmo da tutti i pori, perché Griffin abbassò la macchina fotografica per guardarmi negli occhi. Mi fece un sorrisone enorme.
«La prima impressione non è niente male, eh?» disse.
Annuii. «Eh, sì» risposi.
Griffin imboccò una strada a destra e poi un’altra, finché non ci ritrovammo alla periferia della città, con le incantevoli schiere di case in stile Craftsman che luccicavano nella neve come splendidi gioielli. Man mano che ci allontanavamo dal centro, gli edifici erano sempre più distanziati e cominciavano a spuntare le prime fattorie. Alla fine svoltammo per l’ultima volta a destra, in Naples Road, e lui rallentò.
Eccola lì, una modesta e solitaria villetta in stile Craftsman: la casa di Griffin, la casa dei miei sogni. Non è un’esagerazione romantica, come a dire che era la casa più bella che avessi mai visto in vita mia o che avevo sempre desiderato. No, il fatto era che l’avevo vista veramente in sogno. Di notte, ma anche di giorno, nei miei sogni a occhi aperti. Aveva gli stessi infissi azzurri e pilastri robusti, una veranda di legno con tanto di sedie a dondolo. Due finestre al piano superiore che ti fissavano come un paio di occhi. Un comignolo bianco di mattoni. Mi veniva voglia di sorridere.
Naturalmente, c’era stata la cerimonia di matrimonio. In una piccola cappella alle porte di Las Vegas, nel bel mezzo della nostra traversata degli Stati Uniti. Non erano mancati un bel vestitino bianco avorio e due testimoni settantenni, e Griffin che declamava per me la poesia Felicità. Poi c’era stata la continuazione, molto divertente (e troppo veloce), del viaggio in auto, la nostra mini luna di miele. Insomma, tante cose. Ma nulla fu come quell’istante in Naples Road, seduti in macchina, con dietro il rimorchio più minuscolo del mondo contenente i pezzi della mia vecchia vita che avevo deciso di portare con me (alcune poltroncine a strisce, gli armadietti con il mio archivio, le mie foto preferite di Mila). Stavo fissando questa casa che ero sicura di avere già visto, e questo fu l’inizio della mia nuova vita, del mio matrimonio.
Rigirai l’anello nuziale che portavo al dito. «Allora» domandai «adesso è qui che abitiamo?»
Fece di sì con la testa. «Sì, adesso abitiamo qui. Sei pronta a entrare?»
Non ebbi neppure il tempo di rispondere che Griffin spense il motore e girò intorno all’auto per aprirmi la portiera. Mi prese tra le braccia e mi trasportò sul marciapiede innevato, fermandosi davanti alla porta, pronto a varcare la soglia con me.
Io ridevo, leggermente a disagio, più che altro per l’imbarazzo. Le dimostrazioni di slancio sentimentale non erano il mio forte, soprattutto quelle tradizionali. Un tempo ero convinta di trovarle banali e sdolcinate. Poi avevo capito che in realtà mi erano soprattutto poco familiari. Griffin, però, sembrava determinato a cambiare tutto questo, mentre si avviava deciso verso l’ingresso principale della casa, girava il pomello della porta con me in braccio e calpestava lo zerbino verde con su scritto WELCOME.
«Eccoci arrivati» disse, e mi baciò.
Solo che un’altra persona rispose. «Ehi, ciao…»
Dall’interno della casa giunse una voce maschile, e Griffin mi lasciò cadere di colpo, facendomi sbattere il sedere direttamente sul WELCOME.
Alzai gli occhi scioccata. Guardai prima Griffin, apparentemente nero di rabbia, poi il destinatario della sua ira, che se ne stava lì tranquillo in anticamera a mangiare un gelato. Aveva la barba di quattro giorni e i capelli scuri spettinati, ma si vedeva benissimo che era un uomo molto avvenente, con un paio di occhi verdi penetranti e il sorriso identico a quello di Griffin.
Di fianco a lui c’erano due bambini, uno con in mano un gelato, l’altro un innaffiatoio giallo di plastica. Dovevano avere cinque o sei anni. Ed erano gemelli, praticamente identici, due splendidi maschietti dai capelli rossi.
«Cazzo, a momenti me la facevo sotto dalla paura» disse Griffin.
«Cerca di controllare il linguaggio!» lo rimproverò l’uomo. «Qui ci sono due bambini impressionabili.»
Griffin si piegò per aiutarmi a rimettermi in piedi. «Tutto bene?» mi chiese. «Ti ho fatto male?»
«No…»
Scossi la testa mentre lui mi sollevava. Ero più che altro sorpresa e continuavo a guardare lui e i ragazzini. Loro sorridevano, evidentemente divertiti. Erano due bambini stupendi con i capelli rossi e gli occhi verdi. Assomigliavano molto all’uomo che immaginai essere il loro padre: stessa forma del viso e gli occhi dello stesso colore. La splendida chioma fulva dovevano averla presa da qualcun altro, però.
«Allora, bambini, non andate a salutare lo zio Griffin?» disse. Poi posò simultaneamente le mani sulle due testine.
Lo zio Griffin.
Non poteva che essere Jesse, naturalmente: il fratello di Griffin. Si vedeva benissimo, anche se lui a Los Angeles non aveva alcuna fotografia dei suoi parenti. Mi aveva raccontato che il fratello aveva due bambini – anche che erano gemelli? – che si chiamavano Sammy e Dexter, se ricordavo bene. Sapevo che vivevano a Boston, che non era molto lontano dal Massachusetts occidentale. Jesse stava frequentando un dottorato di ricerca al MIT. E sua moglie – com’è che si chiamava? – aveva un negozio di fiori a Cambridge. Questo avevo saputo. E ora vidi anche un’altra cosa: dietro quegli occhi e quel gelato, Jesse aveva un’aria un po’ stravolta.
«Stanno facendo la gara del silenzio» disse, sospingendoli delicatamente nella direzione di Griffin. «Andate, non c’è bisogno di dire niente.»
I gemelli corsero verso Griffin, che li sollevò entrambi in braccio, stringendo a sé i loro corpicini senza staccare gli occhi dal fratello.
Poi, guardando oltre Griffin e i bambini, notai una serie di cose. In fondo alle scale c’erano alcune valigie enormi con mucchi di vestiti sparsi tutt’intorno; attrezzi sportivi e giocattoli parzialmente tolti dai bagagli e disseminati sulle scale e sul pianerottolo che, almeno dalla mia prospettiva, sembrava in condizioni spaventose: quadri in procinto di cadere dai chiodi, moquette strappata. E un odore inconfondibile di succo d’uva proveniente da qualche luogo che non ero sicura di voler esplorare.
Griffin doveva aver seguito il mio sguardo perché aveva gli occhi puntati nella mia stessa direzione, poi tornò a fissare il fratello.
«Da quant’è che siete qui?» gli domandò.
Jesse scrollò le spalle. «Non da molto.»
«Da quanto?»
«Non tanto…» rispose «tipo cinque settimane.»
«Cinque settimane?» feci io.
Era la prima cosa che dicevo. Jesse si girò verso di me, come se si fosse accorto solo allora della mia presenza. Mi trovavo proprio davanti a lui, in piedi, dopo essere caduta dalle braccia di suo fratello.
«Ehi, ciao» disse.
«Ehi, ciao» ripetei io.
Gli feci un impercettibile cenno di saluto, a dir poco sbalordita di aver aperto bocca.
«Come mai non ti è venuto in mente di avvisarmi che eri qui?» disse Griffin.
Jesse si girò di nuovo verso il fratello con una scrollata di spalle. «Non volevo che ti preoccupassi» disse. «Mi sembrava inutile.»
Griffin rimise a terra i gemelli, che corsero senza fiatare su per le scale, trattenendo le risate, scavalcando con grande fatica la massa di oggetti sparsi per terra. Li osservai allontanarsi, e quando furono scomparsi in una camera da letto sbattendosi la porta alle spalle – l’unico rumore che si udì – tornai a guardare Jesse.
«Qual è il premio per chi vince la gara del silenzio?» domandai. «Sembrano estremamente impegnati.»
«Cento dollari» rispose Jesse.
«Alla faccia…» feci io.
Jesse sorrise. «In effetti, credo che sia un buon incentivo» disse.
Griffin fulminò il fratello con lo sguardo. «Dov’è Cheryl?»
«Cheryl mi ha sbattuto fuori di casa» rispose Jesse.
«Ti ha sbattuto fuori?» ripeté Griffin.
Jesse annuì e, con voce più flebile, disse: «Sammy continua a stringere in mano l’innaffiatoio di sua madre. Se lo porta persino a letto. Deve essere rimasto traumatizzato, vero? Probabilmente lo abbiamo traumatizzato. Dex sembra messo un po’ meglio, ma l’altra sera ha spintonato forte il fratello per cercare di strappargli l’innaffiatoio. Temo che non sia un segno incoraggiante».
Griffin non la smetteva di fiss...