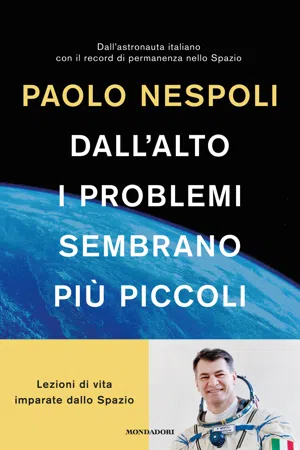![]()
Splash-down o atterraggio: con che cosa è meglio scontrarsi?
Lo splash-down, in altre parole l’ammaraggio, il tuffo in un oceano della navicella al termine delle operazioni di rientro a terra, è impresso nella memoria di tutti noi che abbiamo seguito l’epopea dei primi viaggi spaziali. Aveva una logica, soprattutto per gli americani, giustificata da tre principali ragioni tecnico-strategiche.
La prima è che il mare è aperto, quindi è più facile gestire le operazioni di controllo e recupero di una navicella se precipita in un’area vasta e “pulita” sulla linea dell’orizzonte, come appunto è il mare o un oceano. La superficie è piatta e non ci sono ostacoli naturali. Sull’oceano la visione è panoramica e se sbagli di qualche chilometro, o anche di qualche centinaio di chilometri, è lo stesso, finisci sempre a contatto con l’acqua; non hai grattacieli, montagne, colline o terreni accidentati che possono rappresentare una difficoltà aggiuntiva e che potrebbero significare, in caso di imprevisti, ulteriori motivi di emergenza. Il mare sai dov’è e com’è; non ci sono sorprese e, se quel giorno è troppo mosso o in tempesta, rimandi il rientro a un giorno migliore.
La seconda ragione consiste nel fatto che l’ammaraggio, dal punto di vista delle sollecitazioni strutturali, è più morbido di un atterraggio al suolo per cui consente di costruire una navicella meno robusta. Le navicelle Apollo, per esempio, non erano state costruite per atterrare e se fossero arrivate per sbaglio sulla terraferma avrebbero probabilmente subito deformazioni tali da compromettere l’integrità delle strutture o dell’equipaggio. Ma il fatto di non dover sottostare al requisito di atterraggio consentiva loro di essere più leggere, un vantaggio e un risparmio significativi rispetto ai costi e alle limitazioni del lancio.
La terza è che in mare è più facile stabilire una zona prevista di atterraggio anche di parecchie centinaia di chilometri quadrati e disporre in questa zona un dispositivo di recupero basato su forze militari aero-navali. Tenere quest’area sgombera e sotto controllo è molto più facile che fare la stessa cosa sulla terraferma.
Dopo aver fatto tutte queste considerazioni, negli anni Sessanta, gli americani hanno selezionato l’oceano Pacifico come zona di rientro per le loro missioni umane. Gli veniva facile, d’altronde: è vicino agli Stati Uniti, è temperato e avevano a disposizione una vasta flotta di mezzi aereo-navali da dispiegare per l’operazione. Gli unici nei erano rappresentati da “pescherecci” battenti bandiere strane e dotati di grosse antenne che guarda caso apparivano improvvisamente vicino alle aree di sgombero durante i rientri di navicelle americane così come vicino a Capo Canaveral in corrispondenza di lanci. Ma questo gli americani l’avevano messo in conto perché parte del reciproco monitoraggio tecnologico messo in atto dalle due superpotenze durante la Guerra Fredda.
I sovietici, invece, avevano un problema geografico: il territorio sotto il loro controllo era, a est e ovest, circondato dalla Cina e dall’Europa, e i mari che lambivano le coste delle loro Repubbliche a nord erano troppo freddi. A loro vantaggio, invece, c’era il fatto che nei territori sotto il loro controllo c’erano ampie aree geografiche pianeggianti. Le steppe del Kazakistan, per esempio, erano brulle, piatte e piuttosto isolate, per cui anche se sbagli di 500 chilometri il punto di atterraggio sostanzialmente non cambia nulla. In conclusione, per i sovietici era molto più facile tenere sotto controllo un territorio anche grande all’interno dell’URSS e mantenere un livello di discrezione e segretezza elevato che fare la stessa cosa in mare.
I sovietici, quindi, hanno preferito optare per l’atterraggio invece che per l’ammaraggio, anche se hanno dovuto pagare lo scotto di dover costruire una navicella più pesante e robusta, in grado di resistere all’impatto fortissimo con il terreno. Per avere un’idea dell’impatto, immagina uno scontro frontale tra un TIR e un’utilitaria in autostrada lanciati a tutto gas l’uno contro l’altro. E tu sei nell’utilitaria.
A bordo della Soyuz: abbassare la soglia di allarme
Prima della partenza dalla stazione, insieme agli altri colleghi astronauti, abbiamo fatto le pulizie, come un normale inquilino che rimette a posto le camere dell’abitazione prima dell’arrivo di un nuovo affittuario. Abbiamo ripulito e svuotato i piccoli contenitori per le cose personali che ci erano stati affidati e abbiamo pulito il Crew Quarter. Buona parte dei vestiti indossati nei sei mesi della missione sono stati messi in un contenitore per essere utilizzati come “imballaggio” per le apparecchiature che sarebbero rientrate con lo Shuttle. Un espediente utilizzato in passato per proteggere le apparecchiature e poter riavere al rientro come ricordo alcune magliette usate in orbita.
Poi, dopo essere entrato nella Soyuz, per un’ultima volta mi sono trasformato in fotografo spaziale per riprendere la stazione che si allontanava e alla quale eccezionalmente era attraccato lo Space Shuttle Endeaver. Infine, ho ripreso nella Soyuz il mio posto di ingegnere di bordo numero uno, o co-pilota, per il rientro vero e proprio.
La Soyuz è piccola, spartana e il rientro nell’atmosfera è tutt’altro che banale. O meglio, io me lo aspettavo diverso, forse perché avevo sperimentato il rientro con lo Space Shuttle, rientro che di fatto non è molto diverso dall’atterraggio di un grosso aereo di linea. Ma forse tutto è amplificato dal fatto che i tuoi sensi sono accesi e allertati, e ogni piccolo movimento o scossa vengono attentamente valutati e registrati. Almeno così cominci a fare all’inizio, ma poi impari in fretta che devi abbassare notevolmente la tua soglia di allarme perché la maggior parte delle cose che avvengono al rientro della Soyuz sono catastrofiche e non sembrano assolutamente normali. Cerchi, quindi, di rimanere calmo e lucido anche se, per quanto tu lo possa essere, una certa apprensione è quasi inevitabile quando stai per rientrare sulla Terra dallo Spazio e ti stai per tuffare con la tua navicella nell’atmosfera terrestre. Non è come andare sull’ottovolante!
Sulla Soyuz, al rientro dalla spedizione 26/27, ero in compagnia di Dmitry Kondratyev, cosmonauta e comandante russo della Soyuz, e Catherine Coleman, detta Cady, astronauta americana e secondo ingegnere di bordo. In tre occupavamo lo spazio equivalente al sedile posteriore di una piccola utilitaria. La partenza è avvenuta un po’ prima di mezzanotte di una bella nottata spaziale di maggio.
Operazioni di rientro: una cavalcata selvaggia
La Soyuz è costituita da tre moduli: uno orbitale, chiamato OA, uno di rientro, chiamato CA (che si legge SA), e uno di servizio, chiamato ΠAO (che si legge PAO).
Il modulo orbitale OA è una sfera metallica di circa 1,80 metri di diametro e funziona perlopiù da modulo tuttofare per lo stivaggio dell’equipaggiamento e dei rifornimenti alla stazione (o dell’immondizia al rientro). Contiene anche un piccolo sistema per la rigenerazione dell’aria e un mini-bagno, cioè un tubo aspiratore dove puoi urinare nel caso ne avessi bisogno. In questo modulo ci sono due flange che lo collegano ad altri moduli: una provvista di un boccaporto stagno che va all’esterno (o verso la stazione quando la Soyuz vi è agganciata); una che si interfaccia con il modulo di rientro CA. Una serie di ganci, fermati da bulloni esplosivi, mantiene a stretto contatto le due flange in modo che l’aria all’interno del veicolo non possa perdersi nello Spazio.
Il modulo di rientro CA è anch’esso molto piccolo ma contiene una gran quantità di cose: i tre alloggiamenti per gli astronauti, i pannelli di monitoraggio e controllo con i relativi sistemi elettrici e idraulici, le radio, i paracadute per la navicella e tutto il materiale che potrebbe servire in caso di ammaraggio di emergenza o atterraggio in un’area remota. Contiene anche un machete e una specie di pistola speciale che può sparare proiettili normali o a pallettoni, così come lanciare razzi di segnalazione.
Dal lato opposto rispetto al modulo orbitale c’è imbullonato il modulo di servizio ΠAO, che contiene quasi tutti i motori spaziali, incluso quello di rientro, e quelli che servono per il docking, i computer di bordo, le batterie e il sistema elettrico, oltre alle taniche di ossigeno.
Questo modulo è sigillato e non c’è modo di entrarci nel caso vi fosse un problema. I cinque bulloni che lo collegano al modulo di rientro sono esplosivi, così come lo sono i meccanismi di grosse cesoie metalliche che tranciano cavi e tubature al momento della separazione tra i moduli. La scelta di usare esplosivo per queste operazioni è dovuta al fatto che questo sistema è più semplice e affidabile rispetto ai sistemi e ai meccanismi basati su congegni elettro-meccanici che potrebbero mal funzionare o incepparsi nel vuoto o quando sono soggetti a sbalzi di temperatura tipici dell’ambiente spaziale. Le piccole cariche esplosive contenute nei meccanismi pirotecnici garantiscono al 99,99 per cento il raggiungimento del risultato voluto.
Le operazioni di massima per il rientro sono:
1) si entra nella Soyuz, si sigillano i due boccaporti fra la stazione e la Soyuz e si verifica che siano a tenuta stagna;
2) si indossa la tuta pressurizzata di lancio e rientro e ci si sistema all’interno del modulo di rientro;
3) si sigilla il boccaporto fra il modulo orbitale e il modulo di rientro e si esegue una serie di test per verificare che tutti i compartimenti siano stagni e le nostre tute siano state indossate correttamente;
4) ci si separa dalla stazione spaziale;
5) si accendono i motori di rientro che riducono a circa 27.000 chilometri orari la velocità della navicella;
6) vengono separati i tre moduli della Soyuz. Solo il modulo di rientro con noi astronauti arriverà intatto al suolo, gli altri due si disintegreranno nell’atmosfera;
7) il modulo di rientro si posiziona per l’ingresso nell’atmosfera e decelera passando da 27.000 a 200 chilometri orari;
8) si aprono i paracadute;
9) si equalizza l’atmosfera, si sgancia lo scudo termico e si “carica” il sedile;
10) si accendono i retrorazzi di frenata e si impatta sul terreno;
11) si viene estratti dalla navicella;
12) ci si toglie la tuta di lancio, si effettuano i primi controlli medici;
13) si è trasportati dalla steppa cosacca all’aeroporto internazionale più vicino in elicottero;
14) dal Kazakistan si è trasportati a Mosca o a Houston.
Ecco di seguito una descrizione dettagliata di ciascuna di queste operazioni.
Ingresso nella Soyuz: gettarsi alle spalle gli errori
Questo è il momento in cui ti rendi conto che stai lasciando definitivamente il posto dove hai abitato e lavorato per quasi sei mesi. Lasci anche il resto dell’equipaggio che ora, circa tre mesi dopo il loro arrivo, sono diventati gli “anziani” che accoglieranno e svezzeranno l’equipaggio nuovo che sarà qui tra un paio di settimane. È un momento carico di tensione in cui le emozioni hanno fasi alterne: dispiacere e rincrescimento si mescolano a rallegramenti e felicitazioni. C’è poi l’ansia del rientro: ritornare dallo Spazio non è un gioco da ragazzi e tante cose possono andare storte, come già successo altre volte. La penultima navicella prima della nostra ha avuto un problema con la tenuta stagna: hanno perso aria a un ritmo veramente preoccupante e l’equipaggio non è riuscito a individuarne la ragione. Cosa succederà a noi? Funzionerà tutto come previsto? Saremo in grado di affrontare correttamente malfunzionamenti o emergenze?
Nel nostro caso, poi, abbiamo dovuto lasciare la stazione nel bel mezzo di una missione Shuttle. Fino ad allora non era mai successo. A ragione: quando uno Shuttle è attraccato alla stazione, i ritmi di lavoro sono forsennati ed entrambi gli equipaggi, dello Shuttle e della stazione, lavorano all’unisono per raggiungere i vari obiettivi stabiliti in quei dieci giorni di lavoro comune. Il compito principale dell’equipaggio della stazione è di dare supporto a quello dello Shuttle in modo che tutti assieme si possa lavorare efficacemente. Pensate, è come se sei vostri amici venissero a casa da voi per dieci giorni con il compito di allargarvi la casa aggiungendo un paio di stanze, ampliare l’impianto elettrico e idraulico, cambiare la disposizione dei mobili e delle suppellettili. Il tutto utilizzando attrezzi che voi avete in casa e che solo voi sapete dove sono.
Poi, come se non bastasse, il destino ha voluto che la posizione di attracco alla stazione della nostra Soyuz fosse la più vicina allo Shuttle fra quelle disponibili, e questo fatto da solo faceva preoccupare non poco i controllori di volo in quanto un errore di manovra o il malfunzionamento di qualche motore ci avrebbe potuto portare a sbattere contro lo Shuttle, magari danneggiando irrimediabilmente sia loro sia noi.
Ebbene, la nostra missione è stata la prima e l’ultima nella storia della stazione spaziale dove una Soyuz si è staccata nel bel mezzo di una missione Shuttle. La decisione è stata presa congiuntamente dal Mission Control di Houston e da quello di Mosca, dopo aver considerato che da un lato posticipare il nostro rientro avrebbe causato tutta una serie di altri pesanti e costosi ritardi alle navicelle previste dopo di noi, dall’altro si sarebbe verificata la situazione unica di poter fare foto e riprese video alla stazione con uno Shuttle attraccato. A noi è anche piaciuto pensare che i centri di controllo si fidassero della nostra capacità di effettuare la manovra di sgancio come da manuale, così come di saper svolgere correttamente tutte le delicate operazioni per consentirci di fare le riprese. Ultimo ma non meno importante, erano sicuri che saremmo riusciti a ritornare con della documentazione foto/video unica nella storia spaziale.
Arrivato il momento, quindi, abbiamo raccolto le poche cose che avremmo potuto portare e che ci sarebbero servite durante il breve viaggio di rientro. Era sera tardi, e tutto il pomeriggio ci eravamo occupati dei preparativi. Io avevo anche lavorato sodo nel preparare, pulire, configurare la macchina fotografica e la videocamera che avrei utilizzato per riprendere la stazione. Mentre facevo questo, mi sono ricordato di quello che era successo qualche anno prima quando l’equipaggio di uno Shuttle non era riuscito, nei pochi secondi a loro disposizione, a fotografare il serbatoio esterno appena sganciato. Queste foto vengono scattate con una macchina fotografica normale che, però, viene configurata a terra in un modo particolare.
Ebbene, quella volta il compito di configurare la macchina era toccato proprio a me e io avevo eseguito la procedura a Capo Kennedy il giorno prima del lancio. Operazione non semplice ma neanche particolarmente complessa, anche se durante l’esecuzione avevo avuto qualche dubbio, soprattutto perché la macchina fotografica era un modello nuovo con il quale non avevo dimestichezza e mi era sembrato che la nuova procedura non fosse completamente lineare o inequivocabile. Così è successo che, una volta arrivati in orbita e presa la macchina fotografica, l’equipaggio si trovasse in difficoltà e non riuscisse a fare le foto. Chi aveva commesso l’errore? Io a terra sbagliando la configurazione? Gli astronauti a bordo che maneggiando nella foga la macchina avevano inavvertitamente cambiato la configurazione?
In quell’occasione la NASA aveva gestito l’errore nel modo migliore: cercando di capire quale fosse la causa e individuando il modo per evitare che l’errore si ripetesse. Per fare questo, nelle settimane seguenti e prima del successivo lancio, mi affidarono il compito di rivedere le nuove procedure e assicurarmi che non ci fossero punti oscuri o che potessero essere soggetti a interpretazione. Con l’aiuto di un istruttore, avevo riscritto completamente la procedura che fu approvata dopo essere stata verificata da altri due astronauti. Tra l’altro, la nuova procedura prevedeva di mettere dello scotch speciale di protezione su alcuni piccoli selettori presenti sulla lente in modo che non potessero essere erroneamente azionati quando la macchina viene afferrata per la lente, cosa che nello Spazio si fa in continuazione. In quell’occasione, l’essere stato scelto come responsabile nella risoluzione di un problema mi aveva permesso di esorcizzare la paura di commettere lo stesso errore di prima e mi aveva dato nuova fiducia nelle mie capacità di gestire una situazione simile in futuro. Cosa che si presentò puntualmente al lancio successivo dello shuttle, dove di nuovo mi incaricarono di configurare la macchina. E allora andò tutto come previsto.
Mentre preparavo le macchine fotografiche sulla stazione, per qualche istante ho rivissuto la situazione di Capo Kennedy e ho ripensato al fatto che in effetti forse ero stato proprio io a non aver configurato correttamente la macchina fotografica. Anche questa volta mi trovavo a dover eseguire una procedura scritta in russo e a me non familiare per configurare modelli di apparecchi diversi da quelli di solito utilizzati nell’area non russa della stazione. Ripensare a una situazione simile che avevo già vissuto mi è stato di grande aiuto e mi ha portato a focalizzare le mie energie positive. Mi sono quindi concentrato nel modo migliore, prestando attenzione a tutti i dettagli e controllando almeno due volte tutte le posizioni dei selettori e la configurazione del menu elettronico degli apparecchi. Poi ho posizionato la macchina fotografica, la telecamera, le batterie di scorta e le schede di memoria nel modulo orbitante della Soyuz, pronte per essere usate più avanti.
Sono poi tornato nel mio Crew Quarter, che ormai era vuoto e pulito, asettico come una stanza di ospedale. Erano rimasti solo i computer e ho pensato che occorresse mandare l’ultimo tweet dalla stazione. Ci ho pensato un po’ e poi ho “cinguettato”: “Torno a casa con una cavalcata selvaggia... Non vedo l’ora di aprire i miei sensi al pianeta Terra. C’è qualcuno per una pizza?”.
Ci siamo poi riuniti nel Nodo 1, il posto dove di solito mangiavamo. Abbiamo fatto una piccola cena, abbracciato e salutato i nostri colleghi che sarebbero rimasti sulla stazione e ci siamo diretti verso la nostra Soyuz. Siamo entrati nel modulo orbitale, ci siamo disposti per l’ultimo saluto e l’ultima foto e abbiamo chiuso il nostro boccaporto mentre dalla stazione chiudevano il loro. Subito dopo abbiamo eseguito la procedura per la verifica della tenuta stagna dei due boccaporti. Al termine di questa operazione, tra i due boccaporti era stato creato il vuoto e, mentre di fatto eravamo ancora attraccati alla stazione, ormai eravamo due entità separate, ognuna con la propria atmosfera e il proprio destino.
Indossare la tuta: cosa tenere a portata di mano
La tuta russa è completamente diversa da quella americana, non solo per il colore, una è bianca l’altra arancione, ma soprattutto perché in questa il casco è parte integrante della tuta e non si può staccare, e la si indossa entrandoci da un’apertura in corrispondenza dello stomaco: una specie di nascita alla rovescia.
Nei due anni di addestramento a t...