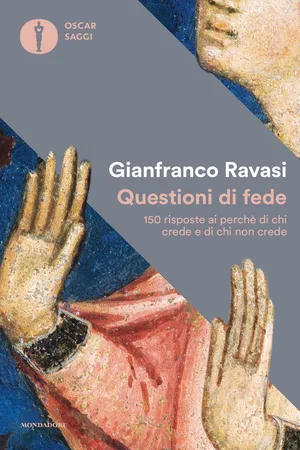![]()
Abbiamo perduto quei lineamenti [di Cristo]
come si può perdere un numero magico,
fatto di cifre abituali,
come si perde per sempre
un’immagine nel caleidoscopio.
Possiamo scorgerli e non riconoscerli.
Forse un tratto del volto crocifisso
si cela in ogni specchio.
Forse il volto morì, si cancellò
affinché Dio sia tutto in tutti.
JORGE LUIS BORGES, Paradiso XXXI, 108
Lo scrittore greco Nikos Kazantzakis, nella sua opera L’ultima tentazione (1955), sulla falsariga del Vangelo di Giovanni, immaginava la morte di Gesù così: «Levò un grido di trionfo: Tutto s’è compiuto! Ma fu come se dicesse: Tutto comincia!». L’esecuzione capitale di Gesù di Nazaret su un modesto picco roccioso gerosolimitano denominato in aramaico – forse per la sua configurazione – Golgota, cioè «cranio», è a prima vista contraddittoria, come aveva già intuito san Paolo, l’apostolo più appassionato del cristianesimo.
Egli, infatti, scriveva che Cristo crocifisso è «scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei sia Greci» Cristo è «potenza e sapienza di Dio» (1 Cor 1,23-24). La morte in croce è fallimentare e sconcertante perché era il sigillo giudiziario destinato dai Romani agli schiavi e ai ribelli; eppure essa è gloriosa e trionfale perché è il segno della secolare storia cristiana, a cui tutti apparteniamo, credenti e agnostici.
Proprio per il rilievo unico dell’evento Gesù Cristo, le domande «cristiane» che ora seguiranno sono particolarmente ampie e toccano aspetti molto variegati, senza poter esaurire un soggetto tematico che dilaga nelle più diverse direzioni. I testi capitali rimangono i quattro Vangeli, fatti di 64.327 parole greche. Un lascito quantitativamente modesto che, però, continua a essere oggetto di un’insonne ricerca critica e teologica, ma che soprattutto non cessa di interpellare il lettore. Come scriveva Mario Pomilio nel suo Quinto evangelio (1975), «Cristo ci ha collocati di fronte al mistero, ci ha posti definitivamente nella situazione dei suoi discepoli di fronte alla domanda: Ma voi, chi dite che io sia?».
Tante sono le risposte che si sono sviluppate nei secoli, attestandosi anche sui particolari di quel volto, della sua voce, dei suoi pensieri o sull’opera delle sue mani. Le domande e risposte che ora sono affidate a queste pagine non fanno che ritornare su quella figura per confermare quanto riconosceva lo scrittore Alfredo Oriani (1852-1919): «Credenti o increduli, nessuno sa sottrarsi all’incanto di quella figura, nessun dolore ha rinunciato sinceramente al fascino della sua promessa».
![]()
L’«avventura» dei Vangeli
Partire dalla voce di Gesù per giungere a una pagina scritta: è un po’ questa l’avventura dei Vangeli. Un’avventura complessa che si sviluppa attraverso alcune decine d’anni, se è vero che il primo Vangelo scritto – stando almeno agli studiosi – è quello di Marco, che appare poco prima del 70 d.C. È possibile ricostruire, almeno per sommi capi, questa avventura che naturalmente coinvolge vari attori e implica non pochi problemi storico-letterari?
Ci sono due premesse da fare. La prima riguarda la vicenda della genesi dei Vangeli: essa è illustrata, oltre che da una sterminata bibliografia, per il mondo cattolico da un documento ufficiale della Pontificia Commissione Biblica datato 21 aprile 1964 (Istruzione sulla verità storica dei Vangeli). Tre sono le fasi fondamentali di quell’«avventura», come la definisce il nostro interlocutore. C’è innanzitutto l’attività pubblica e l’insegnamento di Gesù di Nazaret. Segue il momento della predicazione apostolica durante il quale atti e detti di Gesù vengono annunciati con fedeltà, ma anche interpretati alla luce dell’esperienza della Pasqua vissuta dalla comunità cristiana originaria. È probabile che in questa seconda fase – da collocare nel secondo terzo del I secolo – siano sorti anche alcuni scritti (ad esempio, un racconto della passione-morte-risurrezione o un embrionale «Vangelo dell’infanzia» o qualche raccolta di detti di Gesù, come quella che gli studiosi definiscono «Fonte Q»). L’ultima fase è quella della redazione dei quattro Vangeli canonici che ha inizio dopo il 60 d.C. e che si conclude attorno al 90, stando almeno all’opinione prevalente degli studiosi.
La seconda premessa riguarda invece il concetto di autore che, per l’orizzonte biblico e in genere per l’antico Vicino Oriente, non è da ridurre alla nostra concezione, che è illustrata dall’idea del copyright, cioè dei diritti specifici connessi all’opera originale di uno scrittore ben identificato. In quell’ambito socioculturale, invece, autore non è solo colui che redige un testo ma anche chi lo ispira col suo insegnamento o la sua testimonianza (non dimentichiamo che ci troviamo in una civiltà a matrice orale) e coloro che lo trasmettono. Si tratta, quindi, di un concetto molto più fluido e variegato. In questa luce, l’«ispirazione» divina, tipica delle Sacre Scritture, riguarda l’intero arco di persone che sono coperte da quel concetto di «autore», con particolare rilievo ovviamente per il redattore finale.
Con queste premesse passiamo ora ai singoli evangelisti. I titoli dei quattro Vangeli («Vangelo secondo Marco» e così via) vengono apposti agli scritti nel II secolo. Ma c’è a favore della loro attribuzione un’antica testimonianza (attorno al 125), quella di un vescovo di Gerapoli (Pamukkale, nell’attuale Turchia centrale, città famosa per le sue candide cascate pietrificate), di nome Papia, che si fonda sulle parole di un «anziano» (presbýteros), una figura che alcuni studiosi identificano anche nelle Lettere di Giovanni (2 Gv 1,1; 3 Gv 1,1). Si tratta di un testimone della prima generazione cristiana, che parla di Marco come discepolo e «interprete» di Pietro. Potremmo dire, perciò, che Marco organizzò e riformulò un contenuto proveniente dalla predicazione apostolica (il secondo stadio a cui sopra si accennava), probabilmente petrina, e lo fece forse poco prima del 70.
Di Matteo, Papia dichiara solo che «mise in ordine i detti [di Gesù] in lingua ebraica [= aramaico]». In realtà noi non conosciamo questo testo attribuito direttamente all’apostolo Matteo-Levi: l’attuale Vangelo secondo Matteo, pur rivelando forti influssi semitici, fu scritto in greco ed è possibile che si basi su quel testo «aramaico», ma aggiungendo molti altri elementi. In esso potrebbero essere all’opera sia lo stesso Matteo, che doveva avere una certa conoscenza del greco essendo un funzionario delle imposte, sia un discepolo giudeo-cristiano. Saremmo dopo il 70.
Giungiamo così al terzo Vangelo, che è riferito a un collaboratore di Paolo, Luca: costui è citato tre volte nell’epistolario dell’Apostolo (Fm v. 24; Col 4,14; 2 Tm 4,11) ed è presentato a più riprese anche dagli Atti degli Apostoli. Il prologo del suo Vangelo (1,1-3) illustra in modo esemplare il procedimento da lui adottato, cioè quello di raccogliere e vagliare le narrazioni dei testimoni oculari della vita di Gesù. La sua buona conoscenza del greco ma anche del giudaismo ha fatto pensare a lui come a un pagano divenuto «proselito», cioè convertito all’ebraismo e poi al cristianesimo.
Eccoci, infine, al quarto Vangelo, lo scritto più complesso, per la sua genesi. È evidente, ad esempio, che ci furono almeno due redazioni perché, come abbiamo già accennato altrove, si hanno due evidenti finali diverse che invitiamo a leggere in 20,30-31 e 21,24-25. Non possiamo ora delineare in modo compiuto e sistematico la tradizione che parte da Giovanni, l’apostolo, sorgente di una memoria originale e originaria su Gesù. Probabilmente è lui «il discepolo amato» che entra in scena come testimone, a partire dagli eventi della passione di Cristo. O forse «il discepolo amato» era un ignoto – almeno per noi – «evangelista» che raccolse la predicazione dell’apostolo Giovanni in un testo ben redatto e strutturato, testo che ebbe probabilmente un’ulteriore redazione, attestata dall’aggiunta del capitolo 21, con la quale saremmo già attorno al 90 d.C.
Ma, al di là di questa ricostruzione complessa, nel quarto Vangelo brillano le due premesse da cui siamo partiti: il Vangelo scritto sorge al termine di un itinerario di predicazione fedele ma approfondita e attualizzata; l’autore può essere una figura «corale» che comprende più persone, a partire dall’apostolo per giungere all’«evangelista» vero e proprio.
I Vangeli e la storia
Vengono, tra le altre, spontanee due domande. La prima: il Gesù «terreno» è tout court identificabile col Gesù «storico»? Ovviamente no, perché solo una parte della sua vicenda biografica è documentabile. E allora che cosa noi conosciamo di lui? O meglio, oltre alla storiografia, c’è qualche altra strada legittima da percorrere per sapere qualcosa d’altro su di lui? La seconda considerazione è questa: perché il credente attribuisce tanta importanza alla definizione del Gesù storico? Oggetto della sua fede è il Cristo Salvatore e Figlio di Dio e non tanto il Gesù ebreo «storico» o «terreno».
L’immensa bibliografia attorno alla storicità dei Vangeli, soprattutto in questi ultimi decenni, impedisce o almeno rende arduo dibattere sinteticamente questioni spesso complesse e delicate come quella del rapporto fede-storia o anche semplicemente delineare la metodologia e i risultati dell’investigazione sul Gesù storico, a partire dai due recenti approcci, la cosiddetta New Quest («nuova ricerca») e la Third Quest («terza ricerca»). Si tratta di ricerche che – usando il metodo storico-critico e i canoni ormai codificati della storiografia – tentano di vagliare nei Vangeli e nel loro contesto i dati storici di Gesù e su Gesù. La «nuova ricerca», rispetto allo scetticismo degli studiosi ottocenteschi (la cosiddetta Old Quest, «l’antica ricerca»), propone una serie di criteri di verifica per identificare l’autenticità storica di molti dati evangelici, mentre la «terza ricerca» si preoccupa di collocare Gesù nel contesto giudaico entro cui egli è vissuto, mostrandone sia la coerenza sia l’originalità.
Il nostro interlocutore mette sul tappeto due considerazioni di rilievo. La prima riguarda un fenomeno a cui poco si bada: non tutto il reale è «storico», laddove per «storico» s’intende ciò che è sufficientemente documentato e attestato. Quanti detti e atti effettivamente pronunciati e avvenuti nella vicenda millenaria dell’umanità non possono essere verificati documentariamente e testimonialmente e quindi non sono «storici», pur essendo stati reali! Questo ovviamente vale anche per Gesù di Nazaret del quale – pur avendo a disposizione documenti da sottoporre a esame critico (ed è ciò che fanno le varie Quests a cui sopra si accennava) – si può ricomporre solo parzialmente il profilo «storico».
È per questo che ai nostri giorni si ricorre anche a ricostruzioni di altro genere, soprattutto attraverso percorsi indiretti, contestuali, interdisciplinari: si pensi solo al contributo della sociologia, della psicologia, dell’antropologia culturale e così via. È a questo punto che si colloca anche il vaglio dell’attestazione «mistica» e teologica, che lo storico positivista tradizionale sprezzantemente liquidava come mito o creatività fantastica posteriore della comunità credente (la cosiddetta Gemeindebildung). In questa linea si sviluppa l’approccio proposto da alcuni saggi come il Gesù di Klaus Berger (tradotto in italiano nel 2006) e soprattutto il Gesù di Nazaret pubblicato da Benedetto XVI nel 2007. Approccio molto delicato ma inevitabile, essendo robusta la presenza nei Vangeli di elementi non riducibili alla mera verificabilità storiografica «fattuale» tradizionale (tra parentesi, si ricordi quanto ai nostri giorni riscuota rispetto e credito la stessa categoria del «mito», che è non certo relegabile nell’orizzonte nebuloso del fantastico).
L’altra considerazione proposta dal nostro lettore è, invece, di taglio più teologico, eppure è connessa intimamente alla questione storica. In pratica egli ripropone l’asserto del celebre teologo Rudolf Bultmann (1884-1976), il quale riteneva centrale per la fede l’annuncio del Cristo risorto salvatore (il cosiddetto kérygma) e non certo la vicenda storica dell’ebreo Gesù di Nazaret. In verità si tratta di una dissociazione, segnata da una vaga colorazione «gnostica», che non è sostenibile. Certo, oggetto e fondamento della fede cristiana non è di per sé il solo Gesù storico; eppure il Gesù storico è componente fondamentale e ineliminabile perché la fede cristiana ha al centro la persona di Gesù Cristo, che è quell’unità inscindibile di umanità e di divinità a cui fa riferimento la documentazione evangelica e la stessa testimonianza originaria della comunità cristiana primordiale. È l’intreccio inestricabile, già ricordato, tra Lógos e sarx, tra Verbo e carne, per usare il linguaggio del prologo giovanneo, che da un lato rende complessa l’analisi storiografica ma che, dall’altro lato, esige anche l’integrazione della ricerca storica su Gesù nella stessa cristologia.
Gesù e gli storici romani
Due domande indipendenti tra loro eppure dotate di qualche connessione. Innanzitutto ci sono tracce dell’esistenza di Cristo fuori dei Vangeli? A quale secolo risalgono le copie più antiche dei Vangeli e quali sono gli eventuali frammenti dei primi Vangeli scritti? In entrambe le domande si pone la questione di una documentazione esterna.
Veniamo subito al primo quesito: è noto che negli Annales Tacito (circa 55-125), evocando l’incendio di Roma del 64 d.C., annotava che «Nerone dichiarò colpevoli e condannò ai tormenti più atroci coloro che il popolo chiama Cristiani … che prendevano nome da Cristo, condannato a morte ad opera del procuratore Ponzio Pilato, sotto l’impero di Tiberio» (XV, 44, 2-5). Un altro storico romano, Svetonio, nella sua Vita di Claudio, scritta attorno al 120, ricorda che i «giudei, che tumultuavano continuamente per istigazione di “Cresto” [Cristo], furono cacciati da Roma» (n. 25). Le imprecisioni cronologiche e storiche sono evidenti, ma il rimando a Cristo rimane indubbio.
Tuttavia, il testo più importante e antico è la lettera che, attorno al 111-113, Plinio il Giovane, allora governatore in Bitinia (Turchia nordoccidentale), scrive all’imperatore Traiano, denunciando la «pertinacia e inflessibile ostinazione» di un movimento che si riunisce «in un giorno stabilito, prima dell’alba» per proclamare «un canto a Cristo come a Dio» (Epistulae 10, 96). Altre tracce sono reperibili in Epitteto, Marco Aurelio, Frontone, Luciano, Celso, mentre fondamentale è il passo su Gesù presente nell’opera Antichità giudaiche (XVIII, 63-64) dello storico giudeo-romano Giuseppe Flavio, contemporaneo di Paolo. Egli presenta la figura di Gesù con ammirazione: alcuni pensano che il testo sia stato ritoccato in chiave filocristiana, ma è indubbio che la sostanza è autentica e proviene da un testimone di pochissimo posteriore e di sua natura «neutro».
Eccone il testo così come è giunto a noi con gli eventuali ritocchi a cui si accennava, che sono semplificati in un’antica versione araba di Giuseppe Flavio. «Verso quel tempo visse Gesù, uomo saggio, se pur conviene chiamarlo uomo; infatti egli compiva opere straordinarie, ammaestrava gli uomini che con gioia accolgono la verità, e convinse molti Giudei e Greci. Egli era il Cristo. E dopo che Pilato, dietro accusa dei maggiori responsabili del nostro popolo, lo condannò alla croce, non vennero meno coloro che fin dall’inizio lo amarono. Infatti apparve loro il terzo giorno di nuovo vivo, avendo i divini profeti detto queste cose di lui e moltissime altre meraviglie. E ancora fino ad oggi non è scomparsa la tribù dei cristiani che da lui prende nome.»
Veniamo poi in modo molto essenziale al secondo quesito. Se lasciamo tra parentesi il discusso frammento 7Q5, scoperto nelle grotte di Qumran sul Mar Morto, che da alcuni è ritenuto contenere 13 lettere greche appartenenti a una frase del Vangelo di Marco (6,53-54) e databile attorno al 50 d.C., se scartiamo gli ancor più discussi tre frammenti di Matteo del codice del Magdalen College di Oxford (databili, secondo uno studioso, molto ipoteticamente tra il 40 e il 70 d.C.), la testimonianza certa più antica a noi giunta è il cosiddetto «Papiro Rylands», o «Papiro 52 (P52)», da collocare prima del 125 e che conserva alcuni versetti del capitolo 18 del Vangelo di Giovanni. Sono almeno un centinaio i papiri del II-III secolo con parti del Nuovo Testamento, mentre i codici in pergamena scritti in lettere greche maiuscole (i più antichi) sono 300, iniziano a essere prodotti nel III secolo e hanno testimonianze fondamentali nel IV-V secolo (Codice Vaticano, Sinaitico, Alessandrino, Beza).
Siamo, quindi, di fronte a una massa enorme di documenti (ci sono anche i codici a scrittura minuscola, i «lezionari», gli ostraca o «cocci» con iscrizioni evangeliche) per un totale di oltre 5000 testimonianze. Si pensi che spesso per i classici greci e latini dobbiamo accontentarci di una o due o poche copie a noi trasmesse, e in vari casi si tratta di manoscritti posteriori di molti secoli. Per conoscere maggiormente l’immenso patrimonio testuale che ci ha trasmesso il Nuovo Testamento e la scienza che ne vaglia l’attendibilità (la «critica testuale»), è necessario ricorrere a testi specifici di taglio prevalentemente scientifico, ma non mancano neppure sussidi abbordabili anche da un pubblico più vasto.
I titoli dei Vangeli
Nell’antichità le opere tendenzialmente non avevano titoli: essi furono imposti in seguito, spesso sulla base del genere oppure del contenuto. Il termine greco euanghelion, «buona notizia», era usato nel mondo classico per indicare le ricompense per una vittoria militare o sportiva o i favori elargiti in caso della nascita di un re o del suo anniversario. Il cristianesimo attribuisce un significato più spirituale e generale, almeno se si esamina l’uso del sostantivo (e del verbo «evangelizzare») all’interno del Nuovo Testamento. Quando e con quale procedimento fu, allora, assegnato questo titolo ai quattro Vangeli, allegando anche i nomi dei quattro autori? E soprattutto che cosa significa que...