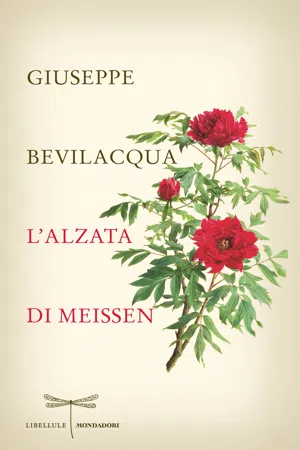![]()
Davanti a una grande cancellata settecentesca l’uomo che gli aveva detto: «Mi segua, vado anch’io in quella direzione» sporse un braccio dal finestrino. Sentì che gridava: «Questa è Villa Bella!». Allora fermò accanto al cancello e scese.
Dall’abitazione del casiere uscirono un uomo e una donna piuttosto anziani.
«Sono Linder» disse.
«Ah, ben arrivato, professore. La stavano aspettando, vanno a cena proprio adesso.»
«Sì, sono un po’ in ritardo, non ho trovato subito...»
Gli tolsero di mano le borse che aveva preso dal bagagliaio. “La prima impressione è positiva” pensò. Quei due avevano tutta l’aria di una coppia di famigli premurosi che accolgono il padrone di ritorno da un lungo viaggio. Si erano appena avviati sul viale quando la donna si volse di colpo a chiedere: «Ma, e la Signora?».
«No, ieri non si sentiva tanto bene...»
«Oh, che peccato, che peccato! Pensare che per Loro abbiamo riservato la stanza del conte Carlo!»
Fino all’ultimo aveva insistito con sua moglie perché l’accompagnasse: «Guarda che deve essere un posto bellissimo, questa villa in riva al lago, con attorno un grande parco... Potresti fare qualche bagno, e Lugano è vicina, potremmo...».
L’aveva interrotto: «No, non insistere, ho tante piccole cose da fare in casa e in questi giorni che sono sola le posso sbrigare tutte. Non mi par vero!». E, sorridendo, gli aveva dato un bacio velocissimo sulla guancia.
Anche lei sapeva che quelle sortite di pochi giorni, per un convegno o una ragione analoga, spesso creavano tra loro un’intesa ancora più intima di quella che li univa da tanto tempo. Li faceva tornare agli anni dei primi, furtivi incontri; o ai primi anni di matrimonio. E, d’altra parte, la donna amava avere di quando in quando alcuni giorni interamente per sé, nella grande casa silenziosa, quando poteva ignorare l’ora dei pasti, nutrirsi quasi soltanto di frutta e yogurt, ripianare la corrispondenza, riordinare i libri sparsi ovunque o riporre i panni invernali.
Il custode lo introdusse nella sala da pranzo ancora completamente immersa nella luce serale che entrava dalle grandi vetrate. Una trentina di persone erano sedute a due tavole imbandite. Da una di queste si alzò un signore molto alto, dai capelli candidi: Mayer-Freksa, Università di Zurigo.
«Caro Linder, ho piacere di rivederLa, già qualcuno temeva che avesse cambiato idea. Ma guardi, Le ho fatto riservare un posto a capotavola.»
L’accompagnò al suo posto, mentre Linder scambiava saluti, cenni di mano, brevi frasi. Alcuni colleghi si alzarono e gli vennero incontro. Tra questi il piccolo Fallani che, con il suo forte accento fiorentino, gli disse: «Peterson non ha potuto venire, ma ti manda un bacio da Berlino per mezzo di chodesta bella figliola!». «Ah, lo incasso subito!» disse Linder con allegria; e porse distrattamente la guancia a una giovane appena intravista che Fallani gli aveva spinto quasi addosso. A tavola si trovò accanto a due studiosi di cui conosceva alcuni lavori. Parlarono dunque subito del tema che era stato proposto per il convegno.
Intanto dalla cucina giungevano piatti che confermavano l’impressione avuta fin dall’inizio. Erano cibi usuali ma curati, con un sapore da vecchia buona cucina familiare.
Le due cameriere di mezza età avevano larghe facce bonarie di contadine educate in una casa signorile. Portavano abiti di servizio molto semplici e austeri, fatta eccezione per la scollatura. E quando una di loro si curvava sopra il commensale seduto di fronte per porgere il piatto fumante del bollito, tenuto con un canovaccio per non scottarsi, la vista di quei seni sani e sodi come due budini concorreva alla sensazione di genuinità e abbondanza che era data dai cibi.
Linder intanto si guardava intorno curioso. La sala occupava tutta l’ala ovest della villa, sporgendo nel parco su tre lati. Tra una vetrata e l’altra c’erano grandi specchiere che riflettevano i due sfolgoranti lampadari di Boemia e ingrandivano l’ambiente. Tutto l’arredo era stile impero, bianco e oro. Sopra il camino e negli angoli erano vasi pieni di ortensie color ruggine o azzurrine. Si sentiva fra i presenti, impalpabile, il piacere diffuso di ritrovarsi in un luogo accogliente dove alternare il lavoro e lo svago, lontani per qualche giorno dalle preoccupazioni abituali. Poi, nel brusio animato e vibrante, fu fatto tinnire un bicchiere. Il Presidente della Fondazione si alzò per dare il benvenuto.
Parlando con lunghi intervalli durante i quali teneva il capo abbassato sul petto, come se dovesse aspettare che un invisibile interprete traducesse ogni frase in un’altra lingua, fece una breve cronistoria dell’istituzione. Essa era nata per un lascito, alla morte dell’ultimo dei Regini, il conte Carlo: un gentiluomo solitario e bizzarro che aveva chiuso una lunga serie di generazioni nel corso delle quali si era progressivamente indebolito e infine spento l’iniziale, grande spirito d’impresa.
I Regini, di origine comasca, si erano stabiliti verso il 1760 a Francoforte sul Meno, iniziandovi un grande commercio di sete e divenendo poi anche banchieri, in società con i Kahnweiler, con i quali avevano intrecciato molteplici rapporti familiari. Napoleone, re d’Italia, nobilitandoli, li aveva indotti a tornare in Lombardia, ma essi conservarono con la Germania intensi rapporti economici e parentali. Villa Bella, acquistata e ampliata ai primi dell’Ottocento come residenza di campagna, durante tutta la prima metà di quel secolo aveva ospitato i più illustri personaggi, perché i nuovi proprietari, specie nel ramo Kahnweiler, avevano larghi interessi culturali e politici.
Ma dopo l’Unità la sorte della famiglia si era lentamente oscurata, anche per via di alcuni fatti luttuosi e misteriosi che l’avevano funestata. L’ultimo conte non si era sposato. Ritiratosi a Villa Bella assieme alla madre, una baronessa Cotta von Cottendorf che era morta quasi centenaria, vi aveva riunito le memorie familiari di entrambi i rami, quello tedesco e quello italiano, inseguendo il mito di quegli avi attivissimi e felici. E alla sua morte aveva deciso che tutto fosse devoluto a un istituto collegato con le Università di Francoforte e di Milano per coltivare i rapporti culturali fra i due paesi.
Il vecchio Presidente fece una pausa ancora più lunga. Tutti capirono che stava per concludere il suo discorso. Era ritto, a capo chino e con un’espressione assente, quasi si fosse improvvisamente dimenticato che era lui l’oratore. «Signore e signori» disse finalmente levando il mento e fissando un punto lontano oltre la vetrata che aveva di fronte, «sono certo che questo luogo tanto ameno e questa casa tanto ricca di suggestivi ricordi e preziosi cimeli sapranno non solo offrire una piacevole permanenza, ma anche ispirare i lavori cui Loro si dedicheranno nei giorni a venire.» Dicendo queste parole la voce gli si era quasi spenta, sicché soltanto dopo qualche esitazione, e quando si vide che il Presidente stava lentamente sedendosi, da alcuni punti dei due tavoli si levò un applauso esitante. Ma a dissipare l’imbarazzo si alzò subito il Direttore di Villa Bella.
Quanto il Presidente della Fondazione era stato vago e assorto, tanto il Direttore si mostrò dinamico e deciso. Mentre intorno, come in un film che si rimette in moto, ospiti e personale riprendevano a occuparsi della cena, egli annunciava, a voce alta e sovrastando il brusio, le disposizioni pratiche relative al convegno. I lavori sarebbero iniziati il mattino seguente alle nove e trenta nella ex scuderia della villa. Gli ospiti erano alloggiati in paese presso il Grand Hôtel Beau Rivage. Per i congressisti sprovvisti di mezzo proprio era disponibile un autobus in partenza alle ventitré in punto dal piazzale antistante la cancellata d’ingresso. Alla stessa ora i pochi ospiti alloggiati a Villa Bella erano pregati di ritirarsi nelle loro stanze o comunque al primo piano, perché al pianterreno veniva inserito l’allarme. Qualcuno gridò: «Cos’è? Il coprifuoco?». «No, signori» rispose il Direttore ridendo, «prego di voler avere un po’ di comprensione. Il custode incaricato di chiudere la casa e inserire questo delicato dispositivo deve alzarsi molto presto la mattina e desidera potersi ritirare alle undici di sera. Ma in camera da letto troveranno il telefono e il suo numero interno, per ogni evenienza. L’allarme è necessario, signori» proseguì il Direttore alzando ulteriormente la voce, «perché in queste sale, come Loro avranno modo di vedere, sono conservati oggetti, quadri e soprattutto libri di grande pregio. Per darne un saggio farò ora circolare un raro pezzo della nostra biblioteca: la prima edizione dell’Itinéraire de Paris à Jérusalem con dedica autografa, datata 11 dicembre 1811, del visconte di Chateaubriand al conte Rodolfo Regini Dallago.» Detto questo, prese da una console alle sue spalle un lucido volume in marocchino blu e fregi dorati e, prima di passarlo nelle mani del commensale più vicino, lo sollevò facendolo ruotare da ogni lato.
Al termine della cena Linder raggiunse direttamente Mayer-Freksa, lo pilotò nel vano di una portafinestra, discusse e concordò con lui alcune questioni riguardanti il convegno. Poi cominciò ad aggirarsi nei numerosi salotti del pianterreno: un po’ per reale interesse, un po’ per sfuggire ai saluti e ai convenevoli. Passava con decisione da un quadro a una vetrina di porcellane, da uno stipo in ebano e avorio a uno scaffale di libri, standovi ben accosto e concentrato nell’osservazione.
Gli oggetti, certo, non mancavano. Era il tipico arredo di una dimora borghese del primo Ottocento, con il suo horror vacui, seppur ancora moderato rispetto a quello che sarebbe stato verso la fine del secolo. Ogni tratto di parete aveva la sua serie di stampe inglesi accuratamente disposte una vicina all’altra, o anche una serie di bellissimi Piranesi, tra i quali i due ritratti a olio di un’anziana coppia di conti Regini, lui pieno di decorazioni, lei con un organzino leggero sul capo. Ma parve a Linder che gli oggetti più belli fossero le porcellane.
Suo padre ne aveva fatto collezione ed egli ne aveva ereditato una certa competenza. Sparso su caminetti, scansie e tavolini, vi era molto Capodimonte, fra cui spiccava un delizioso gruppo di maschere napoletane in pose teatrali; vi era uno sgargiante pappagallo di Höchst, appollaiato sulla sua trancia d’albero in uno sfolgorio di piume multicolori attorno alla pupilla nera cerchiata di giallo; poi, di Limoges, galanterie e un grande calamaio azzurro e oro (“sempre un po’ lezioso il Limoges” pensò Linder); infine, ceramiche “diaspro” e “cream colour” di Wedgwood. Ed ecco! C’era perfino una preziosa conca cinese della famiglia verde! Egli l’osservò a lungo, quasi immergendovi il volto, in modo da occupare il fuoco dello spazio virtuale proiettato dalla conca: e da quel punto lasciar entrare nei suoi occhi lo stesso smemorante godimento di colori e di forme che trecento anni prima aveva guidato la mano di un ignoto vasaio della dinastia Ts’ing. Alzò il capo quasi stordito da quell’emozione inattesa; e da una porta laterale uscì nel parco.
La poca luce veniva dalle vetrate illuminate della villa, cadeva sulle inflorescenze di una grande bougainville illividendone il colore, e smoriva poi sui prati in declivio sotto grandi alberi le cui cime sparivano nel buio.
Linder raggiunse una panchina e vi si lasciò cadere. Così rilassato, sentì la stanchezza del lungo viaggio e della giornata afosa affiorare e come depositarsi nell’incavo della nuca che aveva poggiata allo schienale duro della panchina. Nulla si muoveva, il cielo era chiuso e oscuro. Dal paese giunsero i rintocchi che segnavano le undici; e subito, a piccoli gruppi, i congressisti presero a uscire da Villa Bella scendendo lungo il viale. Si sentirono voci confuse, i passi sulla ghiaia e qualche richiamo; poi il rumore dell’autobus messo in moto e infine soltanto lo stridio dei suoi freni ai tornanti della strada che calava al paese. Allora Linder si alzò e raggiunse il grande ingresso ancora spalancato sulla scalinata di accesso alla villa.
Controluce vi spiccava la figura del Direttore. Sembrava aspettarlo, perché disse: «Professor Linder, ho visto che Lei ammirava le nostre porcellane. Il pezzo più prezioso lo tengo nel mio studio. Vuole vederlo?» e, con un piccolo inchino, gli indicò una porta che si affacciava sull’atrio.
La stanza, illuminata scarsamente da una lampada da tavolo, era zeppa: al centro una scrivania Chippendale coperta di carte, e tutto attorno – sul Tabriz rosso e blu grande quasi quanto la stanza – tavolinetti, sgabelli in velluto, poltrone, un lungo divano, e ovunque i cuscini in raso cremisi con ricamato lo stemma dei conti Regini. Le pareti sparivano dietro le librerie intasate di volumi rilegati; e, nell’unica striscia di muro rimasta libera, si affollavano vecchie fotografie di famiglia in cornici di radica, piccole gouaches con vedute notturne del Vesuvio in eruzione, caricature a penna, silhouettes minuscole, un’acquasantiera in argento, un corno da polvere e tante altre piccole cose. Qui veramente l’orrore del vuoto si era imposto.
Il Direttore guidò Linder verso un camino che si apriva sulla parete più lontana.
«Ecco» disse, e rovesciando verso l’alto lo schermo dell’abat-jour, proiettò un raggio di vivida luce su una bianca porcellana che stava posata, al centro del camino, sulla cornice di marmo nero.
Era una grande alzata, di solida base, ma culminante in una tazza traforata di così fragile apparenza da doversi chiedere se potesse reggere un cumulo debordante di frutti maturi. Il decoro, sui profili e in tocchi sparsi, era del tipo bleu de Saxe. Ma altro s’imponeva all’attenzione: attorno al fusto, simulante un tronco d’albero, su lati opposti, erano modellate due figure. Una giovane dama con l’abito rialzato fin quasi alle ginocchia era in atto di correre protendendo dinanzi a sé un cestino colmo di frutta con una mano, mentre con l’altra si reggeva al tronco; slanciata in avanti, si voltava tuttavia a mezzo come per accertarsi d’essere tuttora seguita; gli occhi, la bocca, le narici sottili, tutto esprimeva una gioiosa sfrenatezza. I tocchi di cobalto facevano ancor più risaltare la trasparenza dell’incomparabile bianco Meissen: la gola scoperta, la fronte, le spalle nude e rotonde.
«Ma è splendida...» mormorò Linder.
«Aspetti» sentì dire alle sue spalle. Il Direttore, stendendo il braccio, fece delicatamente ruotare l’alzata senza sollevarla. Allora Linder vide che la figura sull’altro lato era un cavaliere in abito settecentesco, un piede a terra e uno levato nella corsa, la mano sinistra protesa nel tentativo di afferrare l’altra figura. Il cavaliere era così sbilanciato che sembrava sul punto di cadere in avanti da un momento all’altro; il volto, anch’esso, era proteso, e segnato in tutti i suoi lineamenti da un desiderio ansioso fino alla disperazione.
«Ma è splendida» ripeté Linder, quasi senza voce. «Non è una scena meravigliosa?»
«Così vera, soprattutto!»
Si volse. Nella luce che veniva di sbieco dalla lampada posata sul tavolo bas...