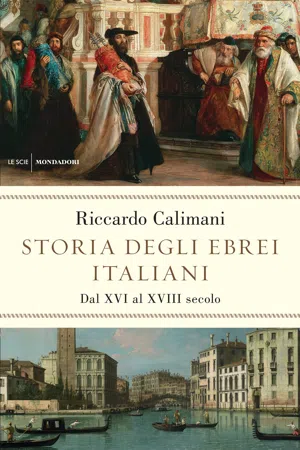![]()
![]()
Dopo il 1492
L’espulsione degli ebrei dalla Spagna sconvolse non solo le comunità ebraico-spagnole, ma anche buona parte di quelle ebraico-italiane. A questo si aggiunse, nel 1494, la rapida calata in Italia dell’esercito di Carlo VIII che seminò morte e distruzione in molte città, cittadine e borgate della Penisola e, in particolare, colpì le comunità ebraiche fino a cancellarne alcune. La conquista del regno di Napoli, un decennio dopo, spinse gli ebrei dal Meridione, da una parte, verso il Nord e, dall’altra, verso il Levante ottomano. Dal Nord, nel frattempo, scendevano gli ebrei francesi, detti i «gallici».
Gli ebrei siciliani, pugliesi, napoletani, che si erano fermati nell’Italia centrale, si incontrarono con i gruppi di sefarditi sbarcati sulle coste tirreniche. Diversi in tutto, a cominciare dalla lingua e poi per tradizioni culturali, mentalità e vocazioni economiche, i gruppi ebraici, nonostante qualche affinità, ebbero tra loro relazioni difficili e spesso aspri attriti, dovuti anche al diverso trattamento che riservarono loro i vari signori, principi, repubbliche o papi, che spesso distinguevano tra ebrei vecchi e nuovi e offrivano condizioni di vita e di lavoro disuguali.
Questo rimescolamento è stato testimoniato, agli inizi del Cinquecento, proprio dai notai italiani, che fino a qualche anno prima nei loro atti scrivevano hebreus, mentre ora specificavano de Apulia, de Hispania, alemannus, hispanicus, siculus, gallicus.
A Roma, per esempio, nella seconda metà del Quattrocento esisteva una sola organizzazione comunitaria, la Communitas Hebraeorum de Urbe, a cui nel 1496 si aggiunse la Communitas Hispanorum et Teutonicorum e nel 1504 il gruppo dei gallici, ebrei francesi e, in particolare, provenzali (Avignone e Contado Venassino). Ogni gruppo aveva la sua sinagoga, con ritualità e cerimonie influenzate dai Paesi d’origine.
Nel 1524, dopo lunghe e tormentate trattative, si sarebbe arrivati a un capitolato di intesa tra ebrei «romani» e «italiani», da una parte, e «forensi» e «ultramontani», dall’altra.1
Alessandro VI e gli ebrei iberici
Molti ebrei stranieri cercarono rifugio a Roma dove, in quell’anno, era diventato papa Alessandro VI (1492-1503), un Borgia. La maggior parte (secondo alcune stime, 400 persone) si accampò fuori delle mura sulla via Appia, nella zona di Capo di Bove. Alcuni, di tanto in tanto, entravano in città segretamente ma poi, a poco a poco, con il permesso del papa, vi si stabilirono definitivamente.2
Il loro arrivo allarmò gli ebrei romani, preoccupati per le conseguenze che avrebbero potuto essere molto negative. Temevano, infatti, possibili contraccolpi da parte del papa e della popolazione. Nella sua cronaca Shevet Yehudah (La verga di Giuda) Salomon ibn Verga scrisse:
Parte degli ebrei iberici, che erano giunti al porto di Genova, si videro costretti ad abbandonarlo a causa della fame che imperversava e si mossero di là alla volta di Roma. Ma gli ebrei di Roma si riunirono e presero consiglio per impedire che quegli stranieri si insinuassero tra di loro, portando grave detrimento alle loro attività economiche. Allora misero subito insieme mille fiorini che offrirono come presente al papa, perché non li accogliesse nelle sue terre. Quando la cosa fu riferita al papa, questi reagì dicendo: «Per me questa è veramente una novità. Fino a ora sapevo che è una caratteristica degli ebrei solidarizzare tra di loro, e invece questi si comportano senza compassione! Pertanto ho deciso che anch’essi (cioè gli ebrei romani) siano cacciati dai miei territori e non sia più lecito loro risiedervi». Allora gli ebrei di Roma si videro costretti a raccogliere altri duemila scudi d’oro da offrire come presente al papa perché li lasciasse in pace, e nello stesso tempo si rassegnarono all’arrivo di quegli stranieri (cioè gli ebrei iberici) in città. Così i poveri profughi poterono cibarsi del buono di quella terra.3
Appena l’anno successivo, nel 1493, l’ambasciatore spagnolo cercò di forzare la mano ad Alessandro VI, chiedendo che i nuovi arrivati fossero espulsi in ossequio alle decisioni del suo re, ma il pontefice mantenne una posizione di relativa autonomia di giudizio. Nel 1495 i francesi invasero Roma e la misero a sacco, devastandola, e anche le sinagoghe della città furono colpite dalla brutalità della soldataglia.
Nel 1498 il papa intervenne contro un gruppo di marrani sospettati di trame oscure. Solo dopo la loro formale abiura ottennero la grazia e il reinserimento nella Chiesa. Questo episodio non fu l’unico: i marrani crearono difficoltà in più di un’occasione. Appena l’anno prima, la questione marrana si era radicalizzata ancora di più con l’espulsione che aveva colpito tutti gli ebrei iberici che vivevano in Portogallo e ai quali era stata offerta una drastica alternativa: battesimo o espulsione. Alessandro VI ebbe il merito di accogliere a Roma un migliaio di ebrei, fra cui molti di probabile origine marrana, che tuttavia si proclamavano ebrei senza macchia. Quanto ai marrani palesi, tra il 1498 e il 1503, circa 400 finirono in carcere a Roma e furono costretti ad accettare il cristianesimo per ottenere di essere rimessi in libertà.4
Come sempre vi erano ebrei privilegiati per via del loro mestiere e delle loro ricchezze. Il famoso medico ebreo Bonet de Lattes (il suo nome ebraico era Jacob ben Immanuel Provincial), per esempio, dedicò al pontefice uno scritto in latino su un anello astronomico, Anulus astronomicus, che aveva scoperto.5 Giunto a Roma nel 1498, fu non solo medico personale del papa, ma anche giudice generale della comunità. Alessandro VI concesse qualche importante privilegio anche al medico Samuele Sarfati, che ebbe la concessione di costruirsi una sinagoga privata, vivere dove voleva e godere di una speciale immunità, con esenzione dalle tasse per sé e per i suoi familiari.6
Agli inizi del Cinquecento gli ebrei detti ultramontani erano quasi il 20 per cento della popolazione ebraica romana e, tra questi, i catalani, gli aragonesi e i castigliani erano i più numerosi.
Il governo di Giulio II a Roma e a Bologna
Protettore di grandi artisti e architetti, uomo, in qualche caso, bellicoso, Giulio II (1503-1513), il Della Rovere,7 non fu duro con gli ebrei che vivevano a Roma, anzi nei loro confronti manifestò insospettate aperture, anche nel 1510, quando gli spagnoli conquistarono Napoli ed espulsero gli ebrei.
Alla sua incoronazione partecipò il suo medico rabbi Samuele Sarfati che gli rivolse alcune parole di saluto. In un documento del maggio 1504 il papa così rispose:
Abbiamo appreso che il nostro predecessore di felice memoria Alessandro VI, in considerazione della tua perizia e grande esperienza nell’arte medica per averla tu esercitata e praticata a lungo, [ti ha autorizzato] ad applicare questa stessa arte, così come vogliono le sue tradizioni, anche sulle persone dei cristiani, e a prescrivere i rimedi confacenti alla malattia. [E ha autorizzato] i suddetti cristiani di ogni grado, stato, rango e condizione a prendere le medicine da te e secondo la tua prescrizione. A questo riguardo [sappiamo che] anche il nostro diletto figlio in Cristo, il re cristiano Luigi [XII] di Francia, ha concesso a te rabbi insieme con la tua sposa e i tuoi figli di ambo i sessi, eppure con i tuoi servitori e tutti i singoli beni e cose che puoi possedere in qualsivoglia signoria, paese, villaggio e località al di qua dei monti [Alpi] soggetta al suddetto re [ti ha dunque concesso] di stare, soggiornare, accrescerti, operare, entrare, uscire e muoverti a tuo pieno e libero piacimento. Il nostro predecessore Alessandro VI ha, infatti, dichiarato in forma breve che tu sei dottore in arti e medicina, come è anche scritto nella patente del re.
Giulio II concesse, inoltre, al medico Samuele Sarfati, alla moglie, ai suoi figli, ai suoi servitori e ai suoi familiari di non portare il contrassegno degli ebrei. Autorizzò tutti loro, finché non fosse stata edificata una sinagoga, a tenere sermoni e a cantare a bassa voce in casa specificando pur sempre: «Con questo non intendiamo però convalidare in alcun modo il culto degli ebrei». Ordinò che a tutti i suoi sudditi, alle singole comunità e associazioni di cittadini, regioni e località, alle strutture ecclesiastiche della Chiesa, ai loro rettori, signori e giudici e agli ufficiali di Roma, a tutti i suoi protetti fosse concessa libertà, pace e tranquillità. Nessuno di costoro avrebbe dovuto essere importunato o molestato «in qualsiasi modo con qualsivoglia pretesto». Questa la conclusione:
Fermi restando gli statuti e i decreti apostolici e i privilegi e i diritti acquisiti di qualsiasi sorta e tenore eventualmente concessi o da concedere in futuro anche alla suddetta città e ai suoi ufficiali; e mentre essi mantengono la loro validità sotto un diverso aspetto, sotto questo aspetto, ma con analoga motivazione e scienza, noi li confermiamo espressamente, nonostante altre disposizioni in contrario.
Nell’agosto 1511 accadde che papa Giulio II fosse dato per morto dagli ufficiali di palazzo. Samuele Sarfati intervenne, lo visitò d’urgenza e fece sapere che non era affatto morto e aveva qualche speranza di riprendersi. Aveva ragione: il papa si riprese e governò la Chiesa fino al febbraio 1513.8 Erano quelli gli anni in cui i gruppi di profughi aragonesi, castigliani, catalani, teutonici e gallici avevano finito per fondersi, non senza attriti e difficoltà, in un amalgama detto Universitas Hebraeorum Forensium et Ultramontanorum, spesso in polemica con il nucleo originario degli ebrei romani detto Universitas Hebraeorum Romanorum.9
Quando Giulio II assunse in modo diretto il governo di Bologna, i rapporti tra cristiani ed ebrei in città erano discreti, anche se i contrasti non mancavano. La fondazione del monte di pietà nel 1473, d’altronde, aveva favorito l’inserimento degli ebrei nella vita cittadina e i rappresentanti comunali avevano difeso i loro ebrei dalle esose pretese che arrivavano da Roma.10
Il cambiamento di governo nel 1506, che passò dai Bentivoglio al papa, non portò mutamenti rilevanti in città. Sia la classe dominante bolognese sia Giulio II erano concordi che fosse necessario evitare possibili turbolenze. La coesistenza tra banchi ebraici e monti di pietà era collaudata e tutti ne ricavavano vantaggi. «Giunto il papa in piazza nuova» si legge nella cronaca di Cherubino Ghirardacci «gli si fecero incontro tutti gli ebrei della città ben vestiti, et con rami d’uliva in mano, cantando salmi in lingua ebrea; et il papa hebbe gran piacere d’udirli così cantare.»
Quando, nel giugno 1507, il commissario apostolico Pietro Grifo fece sapere che i beni dei Bentivoglio dovevano essere venduti al miglior offerente, precisò anche che tutti i creditori dovevano essere soddisfatti e che gli ebrei erano compresi tra questi. Il legato pontificio Francesco Alidosi, nel 1507, fece loro molte concessioni: potevano vendere a loro piacere i pegni non riscossi, comperare terre e case, tenere aperti i banchi di Pasqua e impedire che nuovi banchi potessero essere installati. Queste misure suscitarono la reazione dei senatori bolognesi, che inviarono a Roma una lettera di lamentele.
Dopo il 1506 il pontefice e il legato controllavano la città attraverso il Senato locale composto dalle 40 famiglie più influenti della città che spesso entravano in conflitto con i prestatori ebrei e, in più occasioni, cercarono di scalzarli, tanto che nel 1531 avrebbero proposto al papa che l’ufficio dei beni pignorati passasse sotto il controllo del monte di pietà.11
L’obbligo di consegnare al monte i pegni non riscossi venne così revocato dopo un anno. Nel febbraio 1506 Giulio II confermò l’istituzione del monte e otto mesi più tardi impose agli ebrei di portare il segno di distinzione, insignia solita, nonostante eventuali privilegi e, un mese dopo, il Senato cittadino approvò l’editto sopra il segno.12 Solo i banchieri, i medici e i loro familiari ne erano esentati.
«Confirmamus, sed non consentimus»
Al momento dell’elezione di Leone X (1513-1521),13 il rito del possesso, la solenne presa di potere, fu caratterizzato da una scenografia sontuosa, con archi trionfali, ornati con fauni e ninfe.
Gli ebrei, che subirono il fascino della sua umanità e raffinatezza, rivaleggiarono con i cristiani nel manifestare entusiasmo e magnificenza al pontefice, offrendo stoffe preziose e ricchi ornamenti. Aspettavano l’arrivo della sua cavalcata solenne accanto alla porta di Castel Sant’Angelo. Sul palco di legno, «coperto di broccati di oro e sericei drappi, si trovavano molti Judei».14
Gli stessi ebrei romani, i rabbini e i fattori, durante il passaggio del corteo della incoronazione del pontefice tenevano nelle loro mani delle candele di cera bianca. Di fronte all’offerta di un esemplare del Pentateuco, Leone X lo guardò e poi affermò: «Confirmamus, sed non consentimus».15 Fu questo il primo approccio da parte del pontefice con la comunità ebraica di Roma.
Amante della cultura e del benessere, più incline alla diplomazia che alla forza, Leone X protesse artisti e scienziati, istituì una cattedra di ebraico, e Sante Pagnini da Lucca, probabilmente un convertito, fu incaricato di tradurre la Bibbia in latino, ottenendo un lauto compenso. Molti ebrei furono accolti in Vaticano: un flautista, Giovan Maria, diventato cristiano e nominato conte, ricevette dal papa in dono un castello, e molti medici ebrei, tra cui quello personale di Leone X, Bonet de Lattes, rabbino e medico di gran fama, ottennero onori e considerazione. Che questo medico ebreo godesse di tanta considerazione lo testimonia una lettera in ebraico scritta da Johannes Reuchlin,16 nella quale lo prega di intercedere presso il papa affinché il processo intentatogli dall’Inquisizione si svolgesse nella sua diocesi d’origine.17
È di antica tradizione il proverbio italiano: «A Roma i Dieci Comandamenti stanno nelle dieci lettere: da pecuniam (paga)». Sotto il pontificato di Leone X, in effetti, a causa delle spese eccessive, il livello della tassazi...