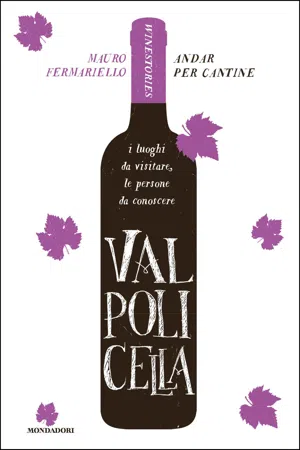![]()
Quest’uva, prima di diventare
vino, deve soffrire.
Appassire, perdere i suoi umori, per dare il meglio di sé
Mister Amarone. Lo chiamano così, Sandro Boscaini, e il titolo se l’è meritato sul campo. D’altra parte, se nasci in una casa dove in soffitta c’è uva che matura, e in cantina uva che fermenta, hai poche vie di scampo.
In realtà, il padre di Sandro aveva per lui altri progetti. Conosceva la fatica delle vigne, e volentieri l’avrebbe risparmiata al figlio. Erano anni di grandi produzioni e piccoli prezzi.
Ecco come ce li racconta Sandro: «C’erano tre vini nei trani (osterie) a Milano, quando li frequentavo da studente. Il vin ciar, il vin scur e il vin gross. Lo scuro erano i vini piemontesi, il grosso i vini meridionali, e il chiaro quelli del Nordest, vini semplici, leggeri e beverini. Venivano chiamati “Valpolicella”, ma in realtà provenivano da un territorio molto più esteso. C’era una presenza di vini di pregio, ma riguardava solo una piccola nicchia di amatori lombardi o tedeschi, per il resto era una produzione di massa, venduta perlopiù in damigiana, e senza alcun riconoscimento dei crediti del produttore e del territorio. Mio padre non vedeva quindi i presupposti per continuare su questa strada, se non producendo vino ignorando l’uva, cosa che non era nel nostro stile. Mi iscrissi così a Economia e commercio, conservando però la mia passione per il vino. Non per caso, quindi, la mia tesi fu sui “Sistemi e canali distributivi del vino in Italia”. Nel contempo, il mio docente fu coinvolto in un’iniziativa della Fiera di Verona, che intendeva realizzare un’Esposizione dei vini italiani, separandola dalla Fiera dell’agricoltura. Fui così incaricato di effettuare uno studio di marketing sull’opportunità di creare una fiera di settore, in un periodo in cui esistevano solo fiere generaliste. Lavorai due anni, creando i presupposti per il Vinitaly, che oggi è tra le grandi fiere del nostro settore. Tutto questo fu per me come un secondo battesimo del vino, mi fece intuire un nuovo modo per poterlo comunicare e distribuire, e quindi anche un nuovo modo di produrlo. Non mi fu quindi difficile accettare la proposta di mio padre, che mi suggerì di rientrare in azienda insieme a mio fratello Bruno, per darle un nuovo impulso. Posi solo alcune condizioni preliminari, che mio padre accettò senza difficoltà.
E dire che avevo solo ventitré anni! La prima fu quella di poter sviluppare in autonomia, con l’aiuto di mio fratello, una piccola cantina, per poter esaltare il valore del podere che era da sempre nella nostra storia, la Tenuta dei Masi. Nostro padre ci mise a disposizione la proprietà dove siamo adesso e tre piccole cantinette, dove cominciammo subito a fare un lavoro di vinificazioni separate e di commercializzazione autonoma rispetto all’azienda di famiglia, che era molto più grande. Avevamo deciso di attaccare il mercato dall’alto, puntando sull’Amarone e sui prodotti che nascevano dalle uve appassite, in primis il Campofiorin. Nel tempo siamo cresciuti, aggiungendo altri vigneti, al punto da “fagocitare” la nostra casa madre. Ma il successo non deve far pensare a un’impresa facile.
È stata molto dura, si andava a vendere un vino allora poco apprezzato, di scarso reddito e costoso da realizzare. Ricordo un mio momento di sconforto, dopo qualche anno di lavoro intenso. Ragionando con un amico scrittore, Cesare Marchi, dicevo: “Non posso continuare così; ho studiato, mi sono dedicato, ma il mio lavoro continua a essere considerato di secondo livello, e non dà prospettive di ritorno economico. Non posso andare avanti solo per il piacere di fare le cose fatte bene”. Lui mi rispose: “Perché ti mortifichi così? Cos’hai meno degli scrittori, musicisti o artisti veneti, che hanno successo proprio perché legati al Veneto? Premia loro, e premiando loro ti metterai sullo stesso piedistallo”. Da lì nacque l’ormai più che trentennale premio Masi, che va ai campioni della civiltà veneta. I vincitori ricevono una botte di Amarone, un alto prodotto della nostra cultura. Oggi posso dire con orgoglio che l’Amarone, insieme al Barolo e al Brunello, è nella terna dei grandi vini italiani».
Mi sono sempre chiesto cos’ha tenuto i vignaioli legati alla terra e alle loro tradizioni, quando tutte le condizioni sembravano avverse. Hanno saputo vedere lontano? Approfitto della situazione per girare la domanda a Sandro Boscaini.
«Mi piacerebbe poterlo dire, ma non credo sia stata lungimiranza, ancora oggi molti non hanno capito il perché di questo successo. Ritengo che sia stata una mancanza di alternative, la nostra è sempre stata una valle chiusa, e fuori dai grandi traffici produttivi. Ma alla base c’è una consapevolezza, una sensibilità quasi animalesca del valore delle nostre uve. Se siano migliori o peggiori non lo so, ma di sicuro le nostre uve fanno qualcosa di diverso dalle altre. È stata tramandata per secoli questa cultura delle uve autoctone e delle loro lavorazioni particolari, anche se solo per consumi minimi, familiari, e questo è stato il seme che ha permesso lo sviluppo del successo degli anni a seguire. Tutto ciò non è stato compreso dalla critica, che per decenni ha sottovalutato le espressioni del nostro territorio, i sedimenti millenari della storia, per limitarsi a consigliare quei quattro vitigni internazionali che si esprimono sempre ad alto livello: merlot e cabernet per i rossi, sauvignon e chardonnay per i bianchi.
Ma in nessun’altra zona al mondo esiste un’interazione così perfetta tra tutte queste condizioni come nella Valpolicella. È una terra benedetta da Dio. Abbiamo tutto, e in più la specificità di quest’uva che convive con i produttori per tutto l’inverno, come fosse un’ospite. Mentre in tutta Europa l’uva è già diventata vino, noi continuiamo ad accudirla con mille premure, per mesi. E convivere con l’uva significa convivere con i profumi, i sapori, i colori del frutto, e acquisire una sensibilità che consente di accompagnare questo prodotto deperibile fino alla maturazione e quindi alla pigiatura. Perché non è come con le castagne o i fagioli, che puoi lasciare lì e dimenticartene. L’uva ha bisogno di attenzioni quotidiane, bisogna chiudere le finestre quando è umido e aprirle quando è secco, e controllare l’eventuale presenza di muffe. Sono cresciuto così, tra i profumi che salivano dalle fermentazioni in cantina e quelli provenienti dal fruttaio in soffitta e che, a seconda dell’alta o bassa pressione, invadevano le stanze di casa. Ma non sono stato il solo, era così per tutte le famiglie di agricoltori della Valpolicella, le case erano costruite per ospitare tutti i processi di lavorazione dell’uva. C’erano una cantina per fare il vino, un basamento dove la famiglia viveva, un primo piano con le camere da letto e una soffitta per maturare l’uva. Agli occhi di un bambino c’era qualcosa di magico; si imparava ad apprezzare la natura, lo scorrere del tempo, e il miracolo di quest’uva che, come diceva san Zeno, patrono di Verona, prima di diventare vino deve soffrire. Appassire, perdere i suoi umori, per dare il meglio di sé. L’originalità del nostro metodo di vinificazione non sta tanto nell’appassire le uve, pratica ampiamente diffusa per concentrare gli zuccheri, ma di farlo separando il grappolo dalla pianta per portarlo in un luogo coperto. Infatti, mentre altrove il clima consente l’appassimento sulla pianta, da noi l’eccessiva umidità provocherebbe la perdita del raccolto. Ecco allora la necessità di ricoverare le uve, e di disporle su graticci di bambù. Ma tutto questo è stato possibile realizzarlo solo qua in Valpolicella, e non in altre aree del Nord Italia; per la presenza del lago di Garda, che crea speciali condizioni climatiche, e di vitigni particolari come le corvine. Queste uve, con l’appassimento, danno particolari reazioni enzimatiche e subiscono l’attacco della muffa nobile, che apporta glicerina. La glicerina dà un’illusione di dolcezza, tipica dell’Amarone. Al naso si ha l’impressione di dover affrontare un vino dolce, mentre in realtà è un vino totalmente secco. Sono caratteristiche molto apprezzate dal pubblico femminile, e anche da chi non ha dimestichezza con i vini più impegnativi. Possiamo dire che l’Amarone è un vino generoso, barocco, dalle mille sfumature, un grande vino che può essere apprezzato anche da chi non ha una forte esperienza enologica. Insomma, piace a tutti.»
Come molti altri comprensori viticoli, anche la Valpolicella è stata attraversata da forti polemiche interne. Ne chiedo i motivi a Boscaini.
«Nel ’68 uscirono i disciplinari di produzione dei vini del veronese, e ne paghiamo ancora il prezzo. Furono basati unicamente sullo status quo, che era quello di un forte sfruttamento commerciale delle nostre zone. Senza alcuna cura dei particolari e delle peculiarità del territorio. Luigi Veronelli aveva preso a cuore la questione, reputando si stesse facendo di tutte le erbe un fascio. Si stava triplicando la zona della Valpolicella, estendendola a est e invadendo le valli adiacenti, che portavano altri nomi. Lui ha sempre ritenuto che ci fosse una scarsa coesione tra i produttori della Valpolicella nel sostenere le nostre ragioni, e ha sempre lottato perché facessimo rispettare i nostri diritti. Lo facciamo oggi, con le Famiglie dell’Amarone d’Arte, associazione di cui sono stato ispiratore e a lungo presidente. Cerchiamo di limitare il degrado evidente che c’è nella produzione dell’Amarone, interpretato come un prodotto di massa, che va bene purché soddisfi alcuni requisiti minimi, al prezzo più basso possibile. L’Amarone è tutt’altro, è un prodotto che richiede una cura speciale, con costi conseguenti, e non potrà mai essere un vino di massa. In un’ideale piramide dei vini della Valpolicella, che veda alla base il semplice Valpolicella, l’Amarone va situato al vertice. Se invece appiattiamo il tutto comprimendo i prezzi, facciamo sì un cattivo servizio all’Amarone, ma anche al Valpolicella e al Ripasso, che si vedranno scalzati da un vino di maggior fascino.»
Stiamo parlando di vini, e allora chiedo del Recioto, che al momento soffre di una crisi d’identità. Sandro ride, e annuisce col capo.
«Il Recioto è un vino che tutti amano e nessuno compra, com’era l’Amarone trent’anni fa. Tutti dicevano “è un grande vino”, ma non c’era un mercato intorno all’Amarone, nessun giornalista internazionale se ne occupava. Il primo articolo importante sull’Amarone uscì su “Wine Spectator” nel ’95, quando convinsi Marvin Schenken e i suoi collaboratori ad assaggiare varie annate, che portai di persona a New York. Ecco, ora con il Recioto siamo nelle stesse condizioni, è un prodotto che va studiato e proposto in maniera diversa. Probabilmente vanno rivisti alcuni accorgimenti tecnici, non si può continuare a offrire lo stesso vino di cinquant’anni fa. Ma temo che, finché andrà così bene l’Amarone, pochi avranno voglia di impegnarsi a ripensare al Recioto, se non per un moto di nostalgia. Sarebbe invece proprio questo il momento di dare un nuovo ritmo al Recioto, sulla scia dell’Amarone. Al contrario, ora va molto bene il Ripasso. Questo vino non esisteva, o meglio, c’era la consuetudine di rifermentare vini molto scadenti sulle vinacce dell’Amarone per renderli “potabili”.
Quello che fecero mio padre e Nino Franceschetti, uno dei principi dell’enologia veronese, fu utilizzare per la rifermentazione un prodotto già di alta qualità, codificando così una tecnica che realizzava un Valpolicella “col turbo”, che si staccava nettamente dalla produzione media. Il primo Campofiorin fu del 1958, e arrivò poi sul mercato nel ’64. È rimasto per almeno trent’anni l’unico Ripasso in commercio, imitato poi da tanti altri produttori, al punto che Hugh Johnson, autore inglese esperto di vini, scrisse: “Il Campofiorin ha creato una nuova categoria dei vini veneti”. Negli anni ho poi apportato alcune migliorie al processo di rifermentazione, che nasceva da un utilizzo delle risorse a costo zero. Oggi che possiamo permetterci qualcosa in più ho ideato la tecnica della doppia fermentazione: le uve fermentate del Valpolicella subiscono una seconda fermentazione al contatto di uve semiappassite, e non più dalle bucce già sfruttate. Si ottiene così un prodotto più fresco e profumato, maggiormente in sintonia con i gusti contemporanei. Il successo del Ripasso ha creato però nuovi problemi perché sollecita una maggiore produzione di Amarone, per sfruttarne le bucce, e una riduzione eccessiva di Valpolicella. Di fatto si crea un sistema in cui un vino è subordinato a un altro, e questo non è un bel messaggio che si dà al consumatore. Ogni vino deve avere una sua personalità e un suo modo di essere, e non essere forzato dalla presenza degli altri vini.»
Quello che mi colpisce di S...