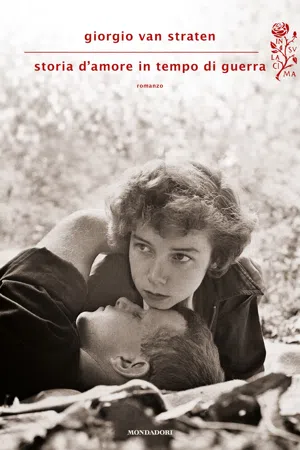![]()
All’inizio fu solo un nome.
Sentii parlare per la prima volta di Enrico Foà durante la quattordicesima ora di intervista ad Antonio Manca, cioè dopo quasi due settimane che quotidianamente lo andavo a trovare, mi sedevo davanti a lui e facevo partire il registratore.
Avevo immaginato che con quel vecchio di più di novant’anni me la sarei cavata alla svelta: mi aspettavo poche parole smozzicate e una grande confusione di date, nomi, avvenimenti. Contavo, come mi era già successo, di tornare presto in archivio a cercare nelle carte tutto ciò che lui non sarebbe stato in grado di dirmi.
Invece la sua voce, che spesso quasi svaniva in un sussurro, cominciò a raccontare con una precisione e una mole di informazioni che mi sorpresero.
Sedevo di fronte a quello che era stato uno dei politici più importanti del nostro paese, un tessitore spesso silenzioso di molte trame complesse e sfuggenti, trame che ora sembrava deciso a rivelare o delle quali mostrare almeno qualche meccanismo, qualche aspetto prima ignorato, con una lucidità che quasi un secolo di vita non pareva offuscare.
Mi domandai se avesse dei documenti ai quali attingere prima di incontrarmi, ma Alessandro, il suo infermiere, quando gli chiesi qualcosa al riguardo si mise a ridere.
«C’è una biblioteca in casa, piena di libri e di carte» mi disse, «ma penso che non ci metta piede da una decina d’anni come minimo. Di sicuro non c’è entrato da quando lavoro qui, perché avrei dovuto portarcelo io. E sono più di cinque anni che mi occupo di lui.»
Allora capii che quello che avevo in mente di scrivere, la biografia di Antonio Manca, poteva diventare il libro più importante della mia oscura carriera di storico.
Aneddoti, particolari inediti, incontri riservati, lunghe e dotte disquisizioni di politica: tutto convergeva nella descrizione di come, finita la guerra, un partito clandestino minoritario fosse diventato il perno intorno al quale aveva ruotato la politica italiana per decenni; di come uomini di saldi principi morali, credenti e spesso oppositori del regime fascista, si fossero addentrati nei meandri del potere, conquistandone, pezzo dopo pezzo, il controllo totale, magari fino a perderci l’anima. Ma il fatto che ci avessero perso l’anima in quel momento non mi sembrava affar mio: gli storici, avevo sempre pensato, devono stare attenti a non farsi prendere la mano dai giudizi etici. E poi la morale della storia me l’aveva già detta lui:
«La politica, vuole sapere cosa è stata per noi? Avrà difficoltà a credermi, visto quello che è diventata oggi. Ma per noi la politica, prima che ci traviasse con il potere, è stata rimettere in piedi un paese distrutto e sconfortato, farne una nazione moderna, ricca come non lo era mai stata prima. Parlo degli anni del dopoguerra, fino al boom economico: non dico che non abbiano svolto una funzione anche gli altri, i comunisti per esempio, ma siamo stati noi cattolici democratici a guidare l’Italia, sono state le nostre idee a vincere, è stato il nostro sogno quello capace di realizzarsi. Ecco cos’era la politica per noi in quegli anni; e mentre la facevamo siamo stati felici.»
Mi sono sempre considerato un uomo di sinistra, quindi ero prevenuto verso quel partito e i suoi esponenti. Eppure lì, di fronte a quel vecchio, rimanevo affascinato dalla calma con cui sceglieva le parole, dall’orgoglio per la propria capacità di trovare sempre il termine più efficace, dalle sue mani ossute e macchiate dal tempo, ma ancora mobili, svelte, capaci di disegnare nell’aria geroglifici appassionanti.
Starlo ad ascoltare era un piacere e mi rendevo conto di come fosse riuscito a conservare il suo potere così a lungo: perché ancora oggi, in controluce, si poteva continuare a vedere l’orlo dei meravigliosi merletti con cui aveva decorato l’Italia negli anni prima della mia nascita.
Quanto al fatto che Antonio Manca avesse deciso di raccontarmi tutta la storia che aveva celato, o solo parzialmente accennato in precedenza, me lo spiegavo in due modi: in primo luogo quel partito era scomparso da tempo e non c’era più niente da proteggere, ma soprattutto lui era ormai tanto vecchio che le possibilità di raccontare a qualcuno la propria vita si andavano riducendo. Credo che nessuno lo cercasse più da anni, così aveva deciso di rispondere alle domande della prima persona che gli fosse capitata, anche se si trattava di un semplice bibliotecario con la passione per la ricerca storica.
Seduto di fronte a lui, mi interrogavo sulle origini della mia insperata fortuna, ma senza rifletterci troppo: stavo attento a non distrarmi, perché è vero che avevo le registrazioni, ma il lavoro sarebbe venuto meglio se fossi rimasto vigile mentre il vecchio parlava, così da poter chiedere spiegazioni quando qualcosa mi suonava strano o sconosciuto – un nome ad esempio – e per questo continuavo a riempire quaderni di appunti, come fossi un allievo ammirato dall’erudizione del suo professore.
I nomi, appunto. Quelli che Antonio Manca forniva nel corso delle nostre conversazioni erano tanto numerosi quanto noti, almeno a me che di quel periodo storico e di quel partito avevo fatto da anni l’oggetto delle ricerche che affiancavo con fatica al lavoro di bibliotecario.
Ma quando venne fuori il nome di Enrico Foà rimasi sorpreso, perché non l’avevo mai sentito prima.
Eravamo seduti come al solito al tavolo del giardino, il vecchio nella sua grande poltrona imbottita e io su una scomoda sedia di metallo da esterni, perché mi vergognavo a chiederne un’altra.
Lui preferiva che parlassimo all’aperto, a meno che il tempo minacciasse pioggia. Ma in quella tarda primavera sembrava che la pioggia si fosse dimenticata della nostra città e, se il giardino ne soffriva, noi ci godevamo quelle giornate di sole sempre più lunghe.
All’inizio lasciai che il vecchio continuasse a parlare, temendo che un’interruzione potesse fargli perdere il filo. Ma quando vidi che proseguiva per la sua strada e di questo Foà non diceva nulla, interruppi il suo ragionamento intorno alle riunioni clandestine che si erano tenute a Roma nel novembre del 1943 e gli domandai chi fosse quell’uomo.
Mi guardò sorpreso, come se quel nome, lasciato cadere a metà di un lungo elenco di partecipanti (una quindicina), gli fosse sfuggito inavvertitamente, quasi si trattasse di qualcuno dimenticato che riemerge solo per un ricordo, nella ricostruzione mentale di un incontro che rivedi come fosse una foto, e là, sull’angolo destro del tavolo, stretto fra due amici, spunta il volto di un uomo scomparso da tempo.
Già, sembrava dire lo sguardo interrogativo del vecchio, chi mai era Enrico Foà? Che fine aveva fatto?
O almeno così interpretai la sua espressione vaga, un accenno di sorriso sulle labbra, gli occhi che guardavano qualcosa oltre le mie spalle.
«Ha detto Enrico Foà? Che strano. Non credo proprio fosse a quella riunione. La nostra conoscenza risale a tempo prima e non mi pare abbia mai partecipato a incontri del partito clandestino. Del resto, con quel nome...»
Avrei voluto contraddirlo: ho detto Enrico Foà perché lei ha detto Enrico Foà, ma evitai di iniziare una discussione che rischiava di farci deviare dal saldo tracciato delle nostre conversazioni e mi ripromisi di ritornarci sopra in una successiva occasione. Così mi limitai a segnare il nome sul quaderno e a riquadrarlo con il pennarello perché mi balzasse agli occhi quando avrei ripercorso gli appunti.
![]()
Quando partii col piroscafo alla volta dell’Argentina, nel novembre del quarantacinque, ero sicura che non sarei mai tornata indietro, perché volevo lasciarmi per sempre alle spalle tutto il dolore che si era accumulato, che si era depositato dentro di me, uno strato sull’altro, come in un’era geologica.
Salpai da Napoli, sola, due valigie e un biglietto con l’indirizzo di mia zia, che si era trasferita a Buenos Aires al tempo delle leggi razziali e che, per quanto ne sapevo, poteva anche essere morta. Le comunicazioni fra noi si erano interrotte da anni e, ora che la guerra era finita, non ebbi il coraggio di chiamare al telefono l’unica parente che mi era rimasta, nel terrore che fosse scomparsa anche lei.
Tutti gli altri erano partiti per i campi e ormai avevo capito che non avrebbero fatto ritorno. Mio padre, mia madre, le mie due sorelle. Non volevo diventare come quelli che continuano ad apparecchiare un posto per persone che non si siederanno più intorno alla loro tavola.
E soprattutto non volevo più pensare a Enrico.
Dunque arrivai a Buenos Aires, ritrovai mia zia – che per una settimana non fece altro che piangere – e mi ricostruii un’esistenza, cercando di dimenticare quella che non avevo più.
Al mio futuro marito, Joseph Adlerblum, quando mi chiese se volevo sposarlo dissi che di tutto quello che era successo prima non avremmo mai dovuto parlare, perché altrimenti la tristezza e il dolore sarebbero penetrati nella nostra nuova famiglia, ammorbandola. Lui forse non era neppure d’accordo, ma mi amava e ha rispettato la mia imposizione per tutto il tempo in cui abbiamo vissuto insieme.
Ero convinta, e rimasi convinta per anni, che non sarei mai tornata in Italia.
Fu la mia figlia maggiore, quando la secondogenita mi aveva già resa nonna, a farmi cambiare idea. Mi disse che aveva voglia di vedere la città dove la sua mamma era nata e aveva vissuto per quasi vent’anni; le sembrava ingiusto che nessuno avesse più visitato le tombe degli antenati e pregato nella sinagoga per coloro che una tomba non l’avevano mai avuta.
Rebecca, mia figlia, è una donna testarda e indipendente. C’era qualcosa nella sua energia di allora che mi inorgogliva e anche mi spaventava: ci riconoscevo i tratti della mia giovinezza ma sapevo che l’avrebbe fatta soffrire.
Era l’inizio degli anni Ottanta e io mi resi conto che ormai ero abbastanza forte per tornare. Restava, certo, una struggente malinconia quando pensavo alla mia vecchia casa, ai miei genitori, quando sentivo per caso delle parole italiane pronunciate in mezzo a una strada da sconosciuti. Di tutto questo non sono mai riuscita a liberarmi ed è giusto così. Però mi ero costruita un’altra vita, un’altra famiglia, avevo un marito, figli, persino un nipote, e riuscivo a guardare l’oceano senza mettermi a piangere come mi era successo per anni. E poi quello era un periodo triste per l’Argentina, c’erano i militari al potere, sentivo che Rebecca diventava sempre più insofferente e speravo che portarla via per un po’ l’avrebbe aiutata a uscirne viva.
Sono una donna all’antica, e anche ora che ho deciso di raccontare tutta la storia mi piacerebbe farlo camminando per le strade del mio vecchio ghetto, e non in questi viali larghi e assolati che corrono aperti verso il Rio de la Plata. Penso che ogni storia ha i suoi luoghi, e quei luoghi vanno rispettati. Ma proprio al ritorno dal mio ultimo viaggio in Italia mi sono convinta che è venuto il momento di parlare, ho capito che la mia vita è una vita argentina e che tutto il resto fa parte del passato e lo si può riporre con ordine negli scaffali, proprio come fa un bravo bibliotecario con i suoi libri.
Dunque è a Buenos Aires che la racconterò, anche se lei l’ascolterà a Roma, e questo mi pare un buon compromesso.
Ma stavo dicendo del mio primo ritorno in Italia, non dell’ultimo.
Quella volta non venni per nave, ormai non si usava più, e mi dispiacque. Avrei preferito mettere dei giorni fra la partenza da Buenos Aires e l’arrivo a Roma, avrei preferito vedere la terra emergere lentamente dall’orizzonte e avere il tempo di prepararmi allo sbarco e all’incontro con i miei ricordi.
Invece salimmo su un aereo, mia figlia e io, e dopo poche ore atterrammo sulla pista di Fiumicino, senza aver avuto il tempo di capire cosa mi aspettava.
All’inizio non riconobbi nulla: Roma si era dilatata in ogni direzione, erano spuntati interi quartieri pieni di enormi edifici, tutti uguali e brutti, già vecchi. E anche quando ho cominciato a riconoscere le strade e le piazze, la città mi sembrava stravolta da un traffico caotico, non tanto diverso da quello che odiavo a Buenos Aires, ma peggiorato dagli spazi angusti.
Avevo prenotato nello stesso albergo dove lei è venuto a cercarmi, e già quella prima volta l’avevo trovato un po’ fané, lasciato andare come il resto della città. Temevo che mia figlia sarebbe rimasta delusa. Non è che le avessi mai parlato molto di Roma; troppo dolore, troppi lutti per raccontarla come una fiaba e non volevo intristire le mie bambine con la realtà. Eppure qualcosa era arrivato loro: un mondo mitico, che confondeva la mia infanzia con gli antichi romani e gli imperatori.
(si sente Miriam ridere)
Ma quando ci siamo fatte portare da un taxi a largo Argentina e da lì ci siamo infilate nelle vecchie stradine del quartiere ebraico fino a sbucare al portico di Ottavia e a costeggiare la sinagoga, allora tutto è tornato come era decenni prima: non le persone, certo – nessun volto che riconoscessi, né nomi che mi facessero voltare di scatto –, ma il resto, le pietre e i muri, le insegne e gli odori, tutto questo era di nuovo mio, mi sentivo di nuovo a casa.
Rebecca mi prese sottobraccio, stringendomi il gomito. Forse avevo vacillato, avevo cercato il suo appoggio, o forse anche lei aveva sentito che quell’aria era proprio ciò che eravamo venute a cercare.
Mi chiese se andava tutto bene, e me lo chiese in italiano, la nostra lingua del cuore, quella che usavamo ogni volta che erano i sentimenti a prendere il sopravvento.
Le dissi che andava tutto bene, che mi girava appena la testa, perché l’aria era diversa, e intorno a noi ritrovavo degli odori che mi stordivano; perché gli odori non si possono ricordare, mi sembra, ma solo riconoscere quando li si incontra di nuovo, a distanza di tempo. Per me erano decenni, addirittura.
Mi sentivo più giovane a stare lì, e per un momento quella ragazza che mi teneva sottobraccio mi sembrò un’amica, una mia vecchia amica di allora, come se passeggiassimo insieme nelle nostre strade, sperando che qualcuno si avvicinasse per attaccare discorso.
(alcuni secondi di silenzio)
Ma avevo anche paura. Di essere fermata, per esempio, di venire riconosciuta, che qualcuno mi chiedesse se davvero ero Miriam Levi. Era molto improbabile, ma non impossibile. Avevo paura di dover spiegare, di chiedere, di ripiombare nello stesso dolore che mi aveva quasi ucciso molto tempo prima e che se ne stava ancora acquattato in un angolo, confinato ma vivo.
Per questo mi misi a parlare con Rebecca in spagnolo, per sembrare due turiste qualsiasi, e lei, nonostante la sorpresa, mi rispose a tono, in una conversazione leggera, di pure chiacchiere, come si fa mentre si passeggia e si guardano i monumenti o le vetrine.
Ecco: questa è la storia del mio primo viaggio a Roma. E potrà capire che per me il solo fatto di ritrovare le strade e le case era un’emozione sufficiente a sconvolgermi. Per questo allora, e anche le altre volte che sono tornata, non ho mai cercato le persone, e nemmeno le loro tracce: non ho mai letto gli elenchi di nomi scolpiti sulle lapidi o stampati nei libri. Ho lasciato dei soldi alla comunità perché curasse le tombe dei miei antenati, ma non sono mai andata a vederle. E quando ho dovuto dire quali erano, ho buttato giù una lista e l’ho affidata a Rebecca.
Ogni volta che sono tornata, mi sono fatta accompagnare da una donna della mia famiglia, e appoggiarmi al braccio di una figlia o di una nipote mi aiutava a pensare solo ai vivi, a sentirmi contenta di essere lì, come se potessi guardare la città attraverso i suoi occhi e tutto il resto rimanesse in una bolla nel mio petto. La stessa bolla che portavo con me ogni giorno anche a Buenos Aires, dentro la quale continuavano a fluttuare le figure sempre più sbiadite, ma non meno presenti, di mio padre e di mia madre, di Ester e Liliana, le mie due sorelle. E anche quella di Enrico.
(alcuni secondi di silenzio)
Por favor, Carlos, apagas la grabadora.
(la registrazione si interrompe)