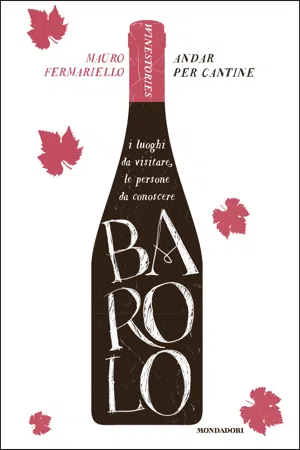![]()
Alla fine, vogliamo tutti
il bene del Barolo
Salendo da Alba, poco prima d’arrivare a Serralunga, c’è l’insegna giallo-nera dell’azienda Ettore Germano, che mi manda a sinistra. Poche centinaia di metri e sono arrivato. Sergio Germano, il titolare, è in ufficio che mi aspetta. Ha un fisico che non sfigurerebbe nella seconda linea degli All Blacks, una barba ispida e il cranio pelato; detta così, non è molto rassicurante, ma è simpatico e schietto, e ci si discute con piacere. È anche molto paziente, e si dilunga in esaurienti spiegazioni tecniche quando gli chiedo qualcosa. Mi porta in sala degustazione, sopra la cantina, e partiamo subito con l’intervista. In cantina c’è gran fermento, la vendemmia è già iniziata, e anche se oggi non si raccoglie, è meglio non perdere tempo.
«L’azienda Germano nasce come tante altre in Langa; storie di famiglie che hanno fatto la fame, con le loro piccole proprietà derivate dalle cascine del feudo dei marchesi di Barolo, che fu smembrato e lasciato ai contadini, due-tre ettari per famiglia, che li coltivavano in affitto o mezzadria.
I primi documenti che ci riguardano sono del 1856, un atto notarile con cui la mia bisnonna ricevette dal padre diversi appezzamenti. La proprietà fu dapprima suddivisa tra fratelli, finché, a metà degli anni ’60, mio padre Ettore la riaccorpò, riportandola ai suoi sei ettari originari. Appena sposato, nel ’64, aveva il terreno dov’è oggi la nostra cantina, la vigna in Prapò. Un’ottima scelta, sia per la qualità delle uve, sia per la posizione, vicino alla strada principale. Era ancora un’azienda mista, con grano, pesche e nocciole. Nocciole poche, per fortuna non avevamo campi esposti a nord, per cui fu facile riconvertire il tutto a vigneti. Mio padre era famoso come innestatore, da marzo in avanti girava sempre con il coltello da innesti in tasca, era un continuo “guarda, queste due piante hanno i grappoli belli spargoli, me le segno” oppure “il vicino ha un’ottima uva da tavola, chiediamogli un paio di tralci”.
Un tempo i contadini facevano l’uva per venderla, nessuno imbottigliava in proprio. Mio papà ha sempre prediletto l’uva dolcetto, perché in passato erano in pochi a vinificare il nebbiolo, e c’erano quindi meno clienti potenziali per le nostre uve. Se ci pensi, il vino un tempo era nutrimento. E allora, molto meglio avere dolcetto o barbera, vitigni produttivi, con certezza di fare un buon raccolto tutti gli anni. Il Nebbiolo era qualcosa di elitario, erano in pochi a produrlo, con una clientela cittadina, o addirittura straniera. Aveva una produzione molto irregolare; e poi, per venderlo, ti facevano ballare. Essendoci poca concorrenza, i compratori tiravano giù il prezzo dell’uva nebbiolo, senza guardare le differenze qualitative. Il Barolo, anche se era detto “il vino dei re, il re dei vini”, non era poi così diffuso. Mentre noi avevamo una buona clientela di contadini piemontesi, che compravano le nostre uve dolcetto e si facevano il vino in casa. Guadagnavamo di più in questo modo, erano soldi sull’unghia, piuttosto che stare a inseguire quei pochi vinificatori di nebbiolo, che avrebbero trattato sul prezzo e pagato chissà quando.
A questo proposito, c’è una storia che si racconta in famiglia. Come dicevo, c’erano pochi vinificatori, che facevano a gara nel ribassare i prezzi. Non andavano mai in vigna, ma usavano una figura che stava nel mezzo, il mediatore. Era quello che combinava un matrimonio, ti aiutava a vendere una cascina o a comprare una vigna. E, naturalmente, per sopravvivere, erano ossequiosi con i ricchi, con chi stava bene, a discapito dei contadini poveri. Mio padre aveva uno zio, fratello di mia nonna, che faceva appunto questo mestiere; non lo sopportava, ma i parenti non si scelgono. Nel ’65 installarono il telefono in casa, e capitò che lo zio, che girava le campagne per affari, gli chiese di poter fare una telefonata. Non che volesse ascoltare, ma la casa era piccola, e gli sentì dire al compratore: “Se adesso scendono ancora due gocce d’acqua, la prendiamo per qualche lira in meno”. Mio padre s’infuriò e, in nome di tutta la categoria, lo cacciò di casa malamente.
Per mettere a vigneto l’azienda, propagò tutto materiale di sua scelta, da cinquanta tralci potati ricavava circa duecento piante, che innestava una per una. Era un innesto in campo, a spacco; sulle viti di un anno, delle dimensioni di un dito (fate la tara, le vostre dita probabilmente sono spesse la metà di quelle di Sergio), veniva effettuata una spaccatura di pochi centimetri, su cui si inseriva la marza di nostro interesse, la cui estremità veniva affilata a forma di cuneo, per aderire meglio allo spacco. Il tutto era poi fissato con del filo di canapa, mentre oggi si usa il nastro adesivo degli elettricisti, resistente ed elastico. Era un’operazione chirurgica, richiedeva una mano ferma. In questo modo si otteneva un portainnesti resistente alla fillossera, e un innesto selezionato da noi. Oggi, le marze selezionate vengono affidate ai vivai, che provvedono a innestarle, per poi consegnare barbatelle già pronte da piantare.
Quando mio padre ha capito che ero intenzionato a seguire la sua strada, iscrivendomi a Enologia, ha continuato a espandere l’azienda, comprando dei terreni confinanti che si erano resi disponibili. Siamo arrivati così a circa dieci ettari di vigneti, qui a Serralunga.
Non ho mai avuto problemi, quando ho affiancato i miei nell’attività; nessuno scontro generazionale, nessun ostacolo nel voler innovare, mi hanno sempre detto “fai quello che ritieni più opportuno”. L’unica volta che c’è stato del malumore è stato quando ho preso le vigne a Cigliè, a cinquanta chilometri di distanza. Per mio padre era inconcepibile che un’azienda familiare non avesse i filari in camera da letto. Ma io morivo dalla voglia di fare i bianchi, non ho resistito. Era una sfida con me stesso, e qui il terreno è troppo ricco, non avrei ottenuto gli stessi risultati.»
E i risultati sono stati davvero brillanti, il suo Riesling renano, il Langhe bianco Hérzu, riscuote un grande successo, basta dare uno sguardo alle guide di settore.
«Quando abbiamo deciso di vinificare per imbottigliare in proprio, ci siamo ritrovati con un solo ettaro e mezzo di nebbiolo; abbiamo poi riconvertito alcune vigne, fino ad arrivare a poco più di sei ettari. In tutto, oggi arriviamo a sedici ettari e mezzo di vigne. Dieci sono qui a Serralunga, comprendenti i quattro cru di Barolo; Cerretta, Prapò, che è una frazione di Cerretta, poi la vigna Lazzarito, che apparteneva alla famiglia di mia madre, e quasi mezzo ettaro di vigna Rionda, piantato nel 2010, e che sarà produttivo nel 2016. Abbiamo quindi quattro vigne importanti di Serralunga; siamo molto onorati di poterle vinificare, ma questo significa anche una bella responsabilità.
Ci sono poi i sei ettari e mezzo di Cigliè, in Alta Langa, dove produco tutti vitigni a bacca bianca, o comunque atti a produrre vini bianchi. Quindi chardonnay, riesling, nascetta e pinot nero, per lo Spumante Alta Langa Metodo Classico.
I rossi qui a Serralunga sono dolcetto, barbera, nebbiolo, e una piccola porzione di merlot , che però stiamo spiantando.
Mio padre era uno sperimentatore dal punto di vista viticolo, gli piaceva avere diverse varietà, mentre io mi sono sbizzarrito con i vini; abbiamo in cantina ben quattordici etichette diverse; ai vini rossi ho voluto affiancare i bianchi, una mia passione. Appena diplomato enologo, ho piantato una vigna di chardonnay, nell’85. In seguito ho piantato il riesling, e quando è uscita la denominazione Alta Langa ho voluto provare anche quella, visto che la produzione Spumante Metodo Classico Champenois mi ha sempre affascinato. L’ultimo nato è uno Spumante Metodo Classico Rosato base nebbiolo.
I vini che produciamo oggi sono fatti con uve che trent’anni fa si facevano solo in annate eccezionali. Il riscaldamento globale, al momento, ci favorisce; una volta, di annate buone ne capitava una ogni tre-quattro anni. Il nostro problema era che il vino riuscisse a raggiungere una gradazione minima di tredici gradi, così da poter essere chiamato Barolo, e non essere declassato. Oggi di Barolo sotto ai quattordici gradi non se ne trova! Se escludiamo il 2002, funestato dalla grandine, l’ultimo decennio è stato caratterizzato da annate tutte di ottima qualità.
Forse siamo migliorati noi vignaioli, ma mio padre ha sempre detto che il primo operaio è il clima. Se lavora bene lui, fai meno fatica e ottieni buoni risultati. In caso contrario, più di tanto non potrai fare. Quindi, cambiano i cicli climatici, cambiano i prodotti che si ottengono e cambiano i gusti delle persone. E questa variabilità è un elemento di sfida per il nostro mestiere, che altrimenti sarebbe tristemente noioso.
Appena diplomato, ho avuto la fortuna di lavorare in una cantina dove c’era un grande enologo, Marco Monchiero. Mi aveva assunto dapprima come secondo enologo, poi mi mise alla direzione tecnica del vigneto, 130 ettari di vigna. Mi ha fatto capire l’importanza delle analisi chimiche, utili per capire cos’è successo al vino, e non per decidere cosa fare al vino. È una sottigliezza, ma che cambia tante cose. Sono rimasto lì dall’88 al ’93. Mio padre mi aveva insegnato a produrre uva di qualità, limitando al massimo i trattamenti chimici; Monchiero mi ha fatto capire come si potesse rispettare l’uva che arrivava in cantina, intervenendo il minimo, e utilizzando poca solforosa.
Il discorso del biologico non mi convince; non voglio che i miei clienti comprino il mio vino perché sono biologico, ma perché è buono, e perché si fidano di come lavoro. Penso di essere più “pulito” di molti biologici, rispettoso dell’ambiente, dei miei clienti e del vino che faccio. Però voglio anche che il vino si esprima; perché devo tollerare difetti che, con un minimo di attenzione in cantina, potrebbero essere evitati? Certi vini possono essere fatti senza solforosa, ma questo rischia di diventare una questione di lana caprina, e c’è troppa gente che parla senza sapere. Solo perché scrivi su un blog o per un giornale, non puoi farti maestro di chi ha cinque generazioni di vigneto alle spalle.
Ho la fortuna di avere vigne alte, ventilate, dove la virulenza delle malattie non è elevata. E se servono cinque trattamenti ne faccio cinque, non ne faccio dieci, sistematicamente, pur di stare tranquillo; io mi metto in gioco con la natura. Se uso un prodotto sistemico, prima della fioritura, faccio meno danni di chi usa il rame, che non è così innocuo come si dice. E alla vendemmia, i sistemici non li ritrovi più nel vigneto. Oggi è il 30 di settembre, l’ultimo trattamento l’ho fatto il 10 di agosto, son passati cinquanta giorni.»
Gli chiedo se ricorda i momenti salienti della rinascita di queste zone, e di quando il Barolo ha iniziato a imporsi come uno dei grandi vini mondiali.
«Lo ricordo ancora, in quei giorni ero militare. Fu un trauma, fu lo scandalo del metanolo, a convincerci che le cose dovevano cambiare. Ma le disgrazie portano anche qualcosa di positivo, che stimola gli animi a reagire. È triste pensare che ci furono delle vittime, per quella truffa, però quell’anno rappresentò il giro di boa di tutta l’enologia italiana. Toccammo il fondo, ma capimmo che qualcosa andava modificato. E i consumatori compresero che un vino di qualità non poteva costare meno di una certa cifra. Da allora, è cambiato tutto.
C’è stato un momento in cui alcuni produttori, come Gaja, Ceretto, Conterno, hanno intuito le potenzialità di queste zone, e che c’era un mercato pronto ad accogliere i nostri vini. Subito a ruota, altri vignaioli li hanno seguiti, anche perché si era intravista la possibilità di crescita da parte di aziende che, fino a quel momento, si limitavano a produrre uva. Il contadino non si risparmia i sacrifici, se ne vede l’utilità; in dieci anni, ci fu una crescita esponenziale di piccole aziende, che hanno creato un tessuto connettivo simile alla Borgogna, con il Barolo al posto del Pinot nero. Sono nate tante etichette con individualità diverse, ma è stata proprio la naturale inclinazione delle Langhe a far sì che ognuno producesse la sua particolarità; è un territorio unico, ma con infinite microdiversità, le condizioni pedoclimatiche variano da comune a comune, da parcella a parcella. E con un vitigno come il nebbiolo, molto sensibile al terreno in cui viene coltivato, le espressioni finali possono essere infinite.»
Ma cos’è che tratteneva un giovane in campagna in quegli anni rampanti, dove altrove tutto sembrava più scintillante?
«Quando nasci in un vigneto, e hai una famiglia dedita al lavoro con passione, finisce che questa passione l’assorbi. I miei coetanei non hanno avuto l’occasione di frequentarla, per cui non potevano amare la ...